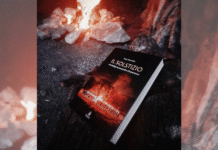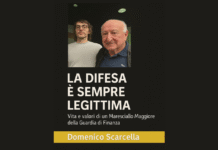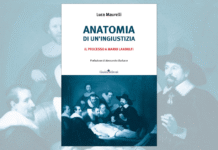In occasione del convegno in Senato “Italia, Europa, Cina: influenze accademiche e squilibri economici” promosso dal sen. Giulio Terzi (FdI) e alcune organizzazioni per la promozione dello Stato di Diritto – Federazione Italiana Diritti Umani, Fondazione Luigi Einaudi, Comitato Globale per lo Stato di Diritto “Marco Pannella” e The Global News, Terzi ha dichiarato: “C’è un comune denominatore nei temi trattati nei due panel. Il primo riguarda le libertà accademiche attraverso influenze esercitate non per ampliare l’orizzonte di libertà ma piuttosto per limitarlo; per proporre una narrativa strumentale e deviata, per condizionare la conoscenza e riscrivere la storia. Il secondo riguarda l’economia delle infrastrutture marittime, un settore assolutamente vitale perché conosciamo bene i principi della fusione civile e militare che sono da molti anni propri alla strategia cinese che dimostra caratteri molto più aggressivi e non soltanto competitivi; spesso antagonisti nei confronti delle nostre società.”
Terzi ha poi parlato più specificamente degli Istituti Confucio all’interno degli atenei italiani, questione su cui si interrogano gli altri Paesi europei. Tali istituti non sono semplici centri culturali della Repubblica popolare cinese. “Di fatto – ha detto Terzi – essi sono il braccio operativo del soft power cinese, la longa manus di sistemi di propaganda, di censura e di raccolta dati. Non sono l’equivalente del Goethe Institute, British Council, Alliance Francaise o degli istituti di cultura giapponese. La storia insegnata negli Istituti Confucio sulla Cina imperiale, sul Tibet, su Taiwan, su Hong Kong, per non parlare del massacro di Piazza Tienanmen – totalmente rimosso – è una storia riscritta, falsata dalla propaganda e dall’agenda autoritaria di Xi Jinping. L’Italia è un unicum purtroppo in Europa perché nessuna università del nostro Paese ha chiuso anche solo uno dei sedici Istituti Confucio né ridotto i rapporti con loro”. Un altro quadro allarmante risulta dal rapporto commissionato dal Parlamento europeo sulle strategie cinesi volte a sfruttare a proprio vantaggio le potenzialità che le infrastrutture europee, in particolare i porti. Vi sono molti segni allarmanti anche rispetto all’interscambio complessivo fra Europa e Cina. “Pechino adotta una politica aggressiva che produce uno squilibrio commerciale determinato da un rapporto che è sempre meno un partenariato tra eguali perché sempre più a favore di chi non rispetta le regole. Nelle parole di Borrel lo squilibrio commerciale fra Ue e Cina è ‘abissale’. Perciò è fondamentale mettere in sicurezza le catene di approvvigionamento rendendole compatibili con le esigenze fondamentali della nostra sicurezza nazionale”, ha detto Terzi che ha concluso dicendo: “Si devono rivedere i fondamentali imperativi di sicurezza e di reciprocità di una partnership strategica che negli accordi fra Europa e Cina viene definita come tale, ma che di fatto è sempre più monodirezionale”.
Giulia Pompili ha parlato del ruolo della diplomazia scientifica di cui Pechino ha tratto beneficio sottraendo informazioni e dati impiegati nel “dual use” civile e militare. In proposito, ha riportato la decisione del governo federale canadese di pubblicare linee guida nella cooperazione scientifica con Paesi sensibili che esercitano influenze ed ingerenze ostili. Il Senatore francese André Gattolin, relatore di un rapporto del Senato sulle influenze straniere in Francia, ha sottolineato come sia emerso rapidamente che la Cina “non è l’unico Paese autore di interferenze, ma è quello più potente, con un modus operandi proteiforme e sistemico che induce alcune università francesi ad agire in modo totalmente contrario al principio della libertà accademica.” Una condizione simile è quella descritta da Luke de Pulford, direttore della Inter-Parliamentary Alliance on China, che ha parlato di una dipendenza sempre più marcata da parte di numerose università britanniche. Andrea Merlo, vice direttore di The Global News, ha evidenziato la necessità di parlare non più di libertà della ricerca, ma libertà e sicurezza della ricerca. Antonio Stango, presidente della FIDU, ha evidenziato il carattere impercettibile delle attività di influenza e ingerenza da parte cinese che si rivelano meno grossolane di quelle di altri Stati, a cominciare dalla Russia.
Il secondo panel ha trattato il tema delle infrastrutture ed è stato aperto dal Sen. Gianni Vernetti che ha dichiarato come a differenza di quanto succede nel libero mercato, gli scambi e le relazioni economiche con la Cina spesso prendono forme opposto a quelle del libero mercato. “La cosiddetta via della seta marittima, cioè la declinazione portuale e marittima della “Belt and Road Initiative” – ha detto Vernetti – non è un normale insieme di progetti di cooperazione e sviluppo con Paesi terzi, è piuttosto un progetto di esportazione di un modello autoritario, un progetto in diretta competizione con il mondo delle democrazie liberali ed è una competizione soprattutto politica ancor prima che economica”. Marco Casale, direttore di Port News, ha parlato di una attenuata interdipendenza con Pechino derivante da una presa d’atto da parte statunitense delle dinamiche del trasporto marittimo commerciale divenute uno strumento per Pechino per raccogliere informazioni e dati. “Occorre rispondere alle inefficienze delle catene di approvvigionamento e alla vulnerabilità di un trasporto marittimo che già durante il periodo pandemico è diventato un fattore di rischio strategico, come vediamo anche oggi alla luce di quello che sta accadendo nel Medio Oriente con l’escalation nel Mar Rosso”, ha detto Casale. Francesco Gallietti ha descritto la presenza nei porti non solo italiani delle gru provviste di una sensoristica molto sofisticata che condividono in tempo reale informazioni con Pechino su tutto ciò che viene movimentato. “Si pone il tema degli ‘asset a rete’, una questione molto rilevante di cui i Paesi singolarmente si occupano con sempre maggiori difficoltà. Serve una riforma portuale che istituisca un’autorità competente, possibilmente la più ampia possibile”, ha detto Gallietti. Infine, Beniamino Irdi, sullo stesso punto, ha notato come “Pechino trasformi le informazioni raccolte in indicazioni-macro che contribuiscono all’elaborazione di una direzione strategica, nel medio-lungo termine, del governo cinese e delle sue propaggini: aziende, industrie, difesa.” I rischi di inasprimento della competizione sistemica e di aggravamento della minaccia ai sistemi e ai valori delle democrazie liberali sono dunque reali ed è per questo che “è necessario un rafforzamento della leadership tecnologica basata sui principi della libertà e della sicurezza”, ha concluso Terzi.