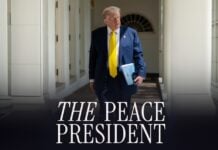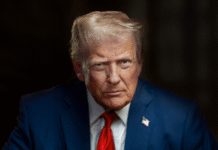“… unità 15 unità 15 portarsi in viale Italia…”
Inizia così una chiamata radio qualsiasi. L’adrenalina sale, il battito accelera, la concentrazione è al massimo. È il quotidiano delle Forze dell’Ordine. Ma cosa resta dentro, una volta che l’emergenza è passata?
Nel cuore del servizio quotidiano degli operatori delle Forze dell’Ordine e Armate, esiste una dimensione spesso trascurata: quella psicologica. Lo stress, il trauma vicario, la fatica da compassione sono realtà invisibili che accompagnano chi ogni giorno è chiamato a garantire l’ordine pubblico, ad intervenire in situazioni drammatiche, a portare soccorso e protezione agli altri. Dentro ogni uniforme c’è una persona che vive l’impatto emotivo delle esperienze affrontate sul campo, che comportano un carico emotivo e situazioni di stress.
Ma cosa è lo stress?
Studi effettuati dagli specialisti definiscono lo stress non un sintomo ma bensì una risposta psicofisiologica dell’individuo agli stimoli che richiedono un adattamento, gli “stressor”. In ambito operativo, il personale delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate è esposto a molteplici fonti di stress:
- di tipo organizzativo, come la turnazione, la carenza di personale o l’insufficiente supporto dei colleghi;
- di tipo contenutistico, legate agli interventi su incidenti, violenze, eventi traumatici.
È utile chiarire che lo stress può essere “eustress”, quando funge da stimolo adattivo rispetto all’evento, oppure “distress”, quando diventa eccessivo e prolungato nel tempo. In ambito clinico è importante distinguere anche tra stress acuto e stress cronico.
Lo stress acuto è una risposta temporanea e fisiologica a una minaccia o a una situazione critica; lo stress cronico, invece, si verifica quando lo stato di attivazione viene mantenuto nel tempo, anche in assenza di pericoli reali, logorando progressivamente le risorse psicofisiche dell’individuo. È proprio questa cronicizzazione che rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo di alcuni disturbi psicologici come il Disturbo da Stress Post-Traumatico (PTSD).
Il doppio ruolo: persona e professionista
Uno degli aspetti più delicati su cui è bene riflettere è il conflitto tra l’identità personale e quella professionale. L’operatore delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate non è solo un punto di riferimento per tutta la cittadinanza, un garante dell’ordine e della sicurezza, ma è anche madre, padre, cittadino. Vive il trauma al pari delle vittime, ma spesso non ha spazio per elaborarlo. Questo “doppio ruolo” comporta un carico emotivo pesantissimo, soprattutto nei momenti di crisi.
«Quando assistiamo al dolore altrui, il nostro cervello può reagire come se stessimo vivendo noi stessi quel dolore…» (Loredana Lia, Alessandro Serretti. – Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie; AMSU di Bologna, 2014)
Tale esposizione al dolore/trauma può far derivare due reazioni:
- la compassion fatigue, uno stato di esaurimento emotivo causato dall’esposizione continua alla sofferenza altrui. Non è un trauma diretto, ma una condizione che può insorgere proprio nel prendersi cura di chi vive esperienze traumatiche;
- il trauma vicario, un fenomeno che deriva dal coinvolgimento empatico tra chi svolge una professione d’aiuto e coloro che sono effettivamente vittime di un trauma. Si tratta di un’esposizione indiretta che però può causare cambiamenti profondi e negativi nei pensieri, nelle convinzioni e nella visione del mondo dell’operatore.
Lo stigma del malessere
Uno dei grandi ostacoli per poter identificare ed aiutare a gestire tali situazioni è la cultura del silenzio: ammettere un disagio psicologico è ancora percepito come una debolezza. La pressione a “essere forti” – alimentata da società, media e spesso anche dai colleghi – genera frasi interiori ricorrenti come:
«Non posso crollare ora»,
«Se dico che sto male penseranno che non sono adatto»,
«Non posso permettermi di avere paura».
Questo atteggiamento di negazione o di vergogna del manifestare debolezza rappresenta uno dei principali ostacoli alla prevenzione e all’emersione di condizioni come il Disturbo da stress post traumatico (PTSD) riconosciuto dalla scienza medica come una condizione clinica che può svilupparsi in seguito all’esposizione a eventi traumatici. Il PTSD si manifesta attraverso diversi sintomi, raggruppabili in quattro grandi categorie:
- rivivere l’evento traumatico attraverso flashback, incubi o ricordi ricorrenti e involontari;
- evitamento, ovvero la tendenza a sottrarsi a situazioni, persone o oggetti che ricordano il trauma;
- iperattivazione fisiologica, cioè uno stato di allerta costante,come se il trauma o qualcosa di brutto stesse per accadere di nuovo;
- ottundimento o appiattimento emotivo, cioè una condizione psicologica caratterizzata da una significativa riduzione della capacità di provare e manifestare emozioni.
In alcuni casi si può avere la coesistenza di più condizioni psicopatologiche: questa viene definita comorbilità. Seppure non si dispone di dati generali sulla popolazione italiana delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate basati su formulari e questionari standard è evidente che la tipologia di servizio e la costante esposizione a eventi critici comportano un rischio di PTSD molto più elevato rispetto alla popolazione generale. Serve una cultura della prevenzione psicologica accessibile, non stigmatizzata e fondata su evidenze cliniche e una rilevazione sistematica del fenomeno con la diffusione di organi di sorveglianza sanitaria e comitati.
“Secondo dati forniti alla Commissione Difesa della Camera, fino al 2013 si contavano circa 30 casi di PTSD formalmente riconosciuti tra i militari italiani (fonte: documenti.camera.it)”.
La vera forza non è nel reprimere le emozioni, ma nel riconoscerle, affrontarle e imparare a gestirle.
Da alcuni anni si è deciso di affrontare situazioni di disagio e di elaborare strumenti e strategie per aiutare i soggetti più esposti ad eventi dolorosi/traumatici a ritrovare l’equilibrio ed il benessere personale, in particolare degli appartenenti alle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate.
L’approccio degli studiosi, i protocolli e le linee guida attuati dai Centri Sanitari della Polizia di Stato dedicati al personale in divisa si concretizzano con una duplice azione: individuale e collettiva.
- Strategie individuali:
Spazi di ascolto psicologico
Convenzioni con psicoterapeuti esterni
Formazione alla consapevolezza emotiva
- Strategie collettive:
Addestramento fisico e mentale
Tecniche di defusing e debriefing per elaborare le emozioni dopo eventi critici
La Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri hanno inoltre istituito la figura del “PARI”, un progetto dove operatori che hanno vissuto ed elaborato eventi traumatici vengono appositamente formati per offrire un primo supporto ai colleghi in difficoltà: un piccolo aiuto, una parola utile, un consiglio… per evitare che le situazioni di forte impatto emotivo possano divenire fonti di stress e disagio e far innescare un circolo vizioso che lede la psiche ed il benessere del soggetto protagonista diretto o indiretto dell’evento trauma.
Costruire una nuova cultura della cura
Il messaggio finale è chiaro: prendersi cura della salute mentale degli operatori delle Forze di Polizia e delle Forze Armate non è un lusso ma una necessità operativa. Favorire il benessere psicologico significa avere operatori più consapevoli, meno esposti ai fenomeno del burnout ele più efficaci sul campo.
«Il trauma non è quello che ci accade,
ma ciò che rimane dentro di noi dopo quello che ci è accaduto» (P.A. Levine)
Tale frase riassume l’essenza di un cambiamento culturale appena incominciato e sempre più urgente.
Per approfondimenti:
- Linee guida della psicologia dell’emergenza nella Polizia di Stato su www.polizidistato.it
- https://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-pubblica-sicurezza/direzione-centrale-sanita
Si ringrazia per la preziosa ed utile collaborazione:
d.ssa Carlotta Gentile, Commissario Capo Tecnico Psicologo della Polizia di Stato