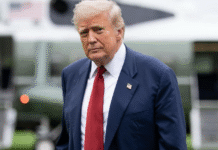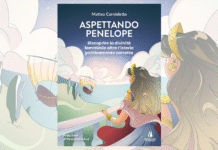In Italia si continua a discutere di estremismo. Il mondo dem ha sfoderato la sua consueta potenza di fuoco mediatica contro i cadaveri del passato fascista e i fantasmi del presente neofascista. A partire dai gravi fatti dello scorso sabato 9 ottobre, culminati nell’assalto alla sede della CGIL, il dibattito pubblico si è nuovamente incartato tra appelli alla vigilanza, mozioni di scioglimento e proposte varie, funzionali all’immediato utile elettorale, ma prive di un respiro politico lungimirante e realmente unitivo.
In Spagna, invece, in questi giorni si celebra un anniversario speciale, quello di una vera, possibile pacificazione nazionale: i dieci anni dalla fine dell’ETA.
Il 20 ottobrre del 2011, l’organizzazione terroristica ETA, sanguinario acronimo di Euskadi Ta Askatasuna, Paesi Baschi e Libertà, annunciò la deposizione delle armi dopo quasi cinquant’anni di lotta armata contro la Spagna (e la Francia). Espressione radicale del nazionalismo basco, innestatosi alla fine degli anni ’50 sul tronco tardo-ottocentesco della mitologia politica identitaria euskaldún, l’ETA nacque da una scissione interna al PNV, il Partido Nacionalista Vasco, il partito cattolico più antico di Europa e voce moderata dell’orgoglio attecchito in quella parte della Spagna atlantica, un tempo appartenente al regno di Navarra. Sorto come soggetto politico rivoluzionario di liberazione nazionale, l’ETA adottò l’ideologia marxista-leninista proprio quando il nazionalismo storico riunito nel PNV veniva piegato dalla centralizzazione di Franco e dalla vigorosa repressione messa in campo dal Generalísimo nei territori più ostili alla storica egemonia castigliana e al primato politico, istituzionale e simbolico di Madrid.
La caduta del regime franchista ha restituito a queste aree, caratterizzate da profonde solidarietà linguistico-culturali e da un forte senso di appartenenza locale, un significativo riconoscimento politico suggellato anche dalla Costituzione del 1978 che sanziona il sistema delle autonomie regionali, vero e proprio monumento alla forza simbolica e alla efficienza politico-istituzionale del “modello spagnolo”. La Comunidad Autónoma del País Vasco, che nell’arcaico idioma dei baschi rimane Euskadi, è tornata a ottenere quell’autonomia storica erede degli antichi fueros, gli ordinamenti locali tradizionali che la Corona iberica, nella sua biografia plurisecolare ha sempre rispettato.
Ai giorni nostri, dopo il suo esordio armato nel 1968 e un “curriculum” di 853 morti e oltre 6000 feriti in cinquant’anni di terrorismo antispagnolo, l’ETA è stata smantellata, decapitata nei suoi vertici politico-militari e duramente colpita nella sua organizzazione militante attiva nelle province di Álava, Vizcaya e Guipúzcoa e nei capoluoghi Bilbao e San Sebastián. Per finanziarsi e comprare armi, l’ETA ha vissuto di minacce ed estorsioni. Celebre è l’“impuesto revolucionario” che per decenni ha fatto pagare agli imprenditori baschi. Tra il 1964 e il 2011 ha realizzato oltre 3000 attentati, tra bombe, sequestri di persona e assassini. Nel 1973 uccise Luis Carrero Blanco, primo ministro e figura chiave del regime di Franco, facendone saltare in aria, vent’anni prima di Capaci e nel cuore di Madrid, la macchina con la scorta.
A partire dagli anni ‘80, l’ETA dichiarò ripetutamente tregue e “cessate il fuoco”. Ma I negoziati di pace con il governo spagnolo fallirono ripetutamente e gli attentati tornarono. All’interno dell’organizzazione diverse furono le voci che sostenevano l’abbandono delle armi e la via del dialogo. Sorse per questo il partito di Herri Batasuna, la cosiddetta “izquierda abertzale”, la “sinistra nazionalista” che tentò l’impossibile strada tra democrazia rappresentativa e fiancheggiamento del terrorismo.
Batasuna fu presto dichiarato illegale, ma i suoi attivisti continuarono, con vicende alterne, a sopravvivere in sigle minori comunque dotate di ampi consensi locali. Si giunse infine al settembre del 2010, quando l’ETA inviò un comunicato alla testata britannica della BBC in cui dichiarava di rinunciare alla violenza. L’anno successivo, il 17 ottobre del 2011, si celebrò la Conferenza di Pace di San Sebastián, con la partecipazione di mediatori internazionali e rappresentanti della società basca. Tre giorni dopo, l’ETA annunciò la fine della lotta armata.
A dieci anni dalla fine del conflitto tra questa costola impazzita del nazionalismo basco e la Spagna (con la Francia, la guerra fu meramente teorica, essendo spagnoli i territori rivendicati, ed essendo Franco il solo vero nemico), gli effetti sono ancora presenti nella società basca: da una parte, le famiglie dei detenuti dell’ETA rivendicano amnistie e la fine dei regimi penitenziari speciali; dall’altra, le associazioni delle vittime del terrorismo ritengono offensiva qualsiasi forma di manifestazione e rivendicazione a favore dei “prigionieri politici”.
Una parte dei familiari è però riuscita a perdonare gli assassini e si è sforzata di porre fine a odio e divisioni. Ne è esempio Maixabel Lasa, vedova del politico socialista Juan María Jaúregui, che ha accettato la richiesta di perdono inviatale dal carcere da uno degli assassini di suo marito; ne sono esempio, anche se soltanto in parte, le parole di scuse di Arnaldo Otegi, uno dei leader storici di Batasuna. In Parlamento, peraltro, ai voti e alle astensioni dei suoi eredi si appoggia non di rado il premier socialista Pedro Sánchez.
Nonostante questo e nonostante la ricorrente tentazione di processare il passato, in nome di una lettura parziale e non condivisa della Guerra Civile, la monarchia spagnola rimane una patria viva capace di sconfiggere il terrorismo e gli estremismi ideologici. Il regno di don Felipe VI di Borbone è ancora oggi un formidabile modello di unità politica in cui le divisioni, anche profonde, possono comporsi nel difficile cammino verso la pacificazione nazionale.