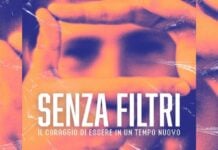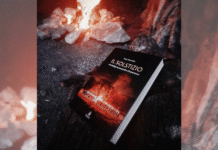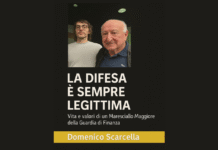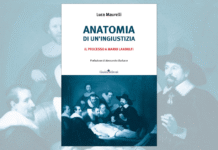Il recente upgrade del merito di credito sovrano dell’Italia da parte di Standard & Poor’s – da “BBB” a “BBB+”, con outlook stabile – rappresenta un segnale che, se letto in chiave puramente finanziaria, potrebbe apparire come una nota tecnica tra le pieghe dell’informazione economica. Ma è ben altro. Si tratta, in verità, di un passaggio critico nel processo di riposizionamento dell’Italia all’interno delle gerarchie della fiducia globale, un termometro politico e istituzionale prima ancora che contabile.
Le agenzie di rating, spesso tacciate di essere meri strumenti del capitalismo finanziario angloamericano, svolgono oggi un ruolo che travalica il perimetro della valutazione creditizia. Esse leggono il sistema-Paese, ne valutano la resilienza istituzionale, la coerenza delle politiche fiscali, la capacità di orientare risorse verso la produttività futura. Il miglioramento del rating da parte di S&P, a oltre due anni dall’insediamento del governo Meloni, non è solo un riconoscimento formale: è la certificazione che l’Italia non rappresenta più un’anomalia nell’eurozona, ma un soggetto capace di produrre stabilità sistemica.
Il contesto macroeconomico: crescita modesta, ma sostenuta
L’analisi di S&P si muove all’interno di uno scenario segnato da una persistente incertezza geopolitica, da tensioni commerciali inasprite (in particolare tra Stati Uniti ed Europa) e da un quadro monetario europeo ancora condizionato dal rialzo dei tassi avviato dalla BCE nel biennio 2022-2023. In questo contesto, la stima di crescita del PIL italiano per il 2025, fissata allo 0,6%, non può considerarsi né un fallimento né un traguardo.
È, piuttosto, l’espressione di una dinamica economica complessa, in cui la domanda interna risulta compressa da tassi reali ancora elevati, e la domanda estera viene frenata da fattori esogeni non controllabili dal governo nazionale. Tuttavia, a sostenere la crescita vi è un’intelaiatura di investimenti pubblici, in gran parte finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che – pur con ritardi e criticità attuative – contribuisce a preservare un minimo sentiero espansivo.
La questione del debito: oltre la soglia del 140% del PIL
Il cuore della valutazione S&P, tuttavia, non è tanto la crescita, quanto la gestione del debito pubblico, che si attesta ancora oltre il 140% del PIL. Ciò che conta non è tanto il livello assoluto, quanto la traiettoria attesa. Secondo S&P, l’Italia è oggi in grado di mantenere una dinamica di stabilizzazione del debito entro il 2028, a condizione che vengano confermate le politiche di contenimento della spesa primaria e che si continui a garantire un avanzo primario strutturale.
Questo è un punto essenziale: non siamo più nella fase dell’emergenza, in cui il debito cresceva fuori controllo, ma in un’epoca di consolidamento prudente. Non si tratta di “austerità espansiva”, formula ormai screditata, ma di rigore selettivo: ridurre ciò che non produce moltiplicatore economico, e rafforzare ciò che genera valore aggiunto, come infrastrutture, istruzione e manifattura 4.0.
Credibilità istituzionale e capitale politico
Un ulteriore fattore determinante nell’upgrade del rating è la tenuta politica del governo italiano. L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, pur con frizioni interne e opposizioni accese, ha mantenuto una linea di continuità nelle politiche economiche, evitando derive antieuropee e garantendo un interlocutore affidabile sui tavoli europei. È questo ciò che i mercati, e le agenzie, misurano più attentamente: non la retorica, ma la capacità di produrre effetti.
La stabilità istituzionale, in un contesto europeo in cui altri Paesi (si pensi alla Francia o alla Germania) stanno vivendo cicli di discontinuità politica e sociale, ha rafforzato il capitale politico italiano. Si è trattato, in sostanza, di una “credibilità guadagnata”, non di una fiducia automatica.
Il ruolo del sistema bancario e della moneta
Un aspetto raramente discusso, ma centrale per un’analisi sistemica, riguarda il ruolo del sistema bancario italiano. Le banche italiane, negli ultimi anni, hanno operato una profonda ristrutturazione, riducendo drasticamente i crediti deteriorati (NPL), ricostruendo le proprie riserve patrimoniali e riallineando il rapporto con la clientela produttiva. Questo ha aumentato la capacità del sistema di sostenere la domanda di credito in modo selettivo, orientandola verso l’innovazione, la digitalizzazione e la riconversione energetica.
Inoltre, in un quadro di moneta fiat emessa dalla BCE, l’Italia si è mostrata capace di utilizzare gli spazi di politica fiscale derivanti dal nuovo Patto di Stabilità in maniera più oculata rispetto al passato. Ciò ha rafforzato l’idea che il nostro Paese non sia più un soggetto passivo della governance europea, ma un attore in grado di interpretarla in modo costruttivo.
Conclusioni: rating come barometro della sovranità
Il miglioramento del giudizio di S&P non deve essere letto come una medaglia da esibire, ma come un’opportunità. Esso restituisce all’Italia un credito di fiducia, ma anche una responsabilità: quella di non ricadere nei vizi del passato, dove ogni margine veniva rapidamente eroso da promesse elettorali o da logiche clientelari.
È tempo di reinvestire questo capitale simbolico in un progetto Paese fondato su tre pilastri: equità fiscale, sovranità produttiva, e inclusione generazionale. Perché un rating non è solo una valutazione tecnica: è un giudizio sulla nostra capacità di restare uniti, coesi e prospettici.
In una parola: credibili.