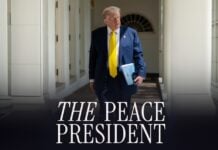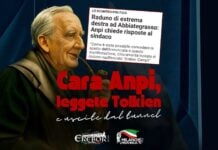Si è finalmente completato l’iter parlamentare che ha portato all’approvazione della proposta di legge relativa alla nuova disciplina dell’equo compenso che interessa i professionisti italiani e che serve a garantire una maggiore qualità delle prestazioni professionali, tutelando al contempo la dignità ed il decoro del lavoratore autonomo.
Già all’esito della scorsa legislatura sembrava che l’obiettivo fosse raggiungibile, ma così non è stato ed è stato il Presidente del Consiglio Meloni a riproporre la questione nell’attuale legislatura dove sono stati necessari tre passaggi parlamentari (Camera, Senato e poi di nuovo Camera), poiché nelle more della definitiva approvazione la c.d. riforma Cartabia del giudizio civile aveva abrogato il rito sommario al quale si faceva riferimento nel testo approvato in Senato.
I professionisti italiani, stretti nella congiuntura dovuta alla crisi sanitaria ed economica che ha colpito il Paese, attendevano da tempo un segnale forte – in linea con la disciplina di cui all’art. 35 Cost. che tutela il lavoro in tutte le sue forme e manifestazioni (e non soltanto quello dipendente) – che li ponesse al riparo da una concorrenza al ribasso, con conseguente svilimento dell’attività prestata, contribuendo ad aggravare il fenomeno oramai noto da tempo di c.d. proletarizzazione anche delle attività professionali.
Già il legislatore era intervenuto nel dicembre 2017 a dettare una disciplina di tutela per la parte debole del contratto professionale di fronte ai grandi committenti (banche, assicurazioni e poi anche e pubbliche amministrazioni), individuando un numero chiuso di clausole vessatorie che determinavano l’invalidità parziale del contratto (cfr. art. 19 quaterdecies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148), così sanzionando le imposizioni più pregiudizievoli spesso inserite nei contratti che i contraenti forti imponevano, senza possibilità di negoziazione, ai professionisti.
Anche talune Regioni virtuose erano intervenute successivamente per garantire l’applicazione in ambito territoriale della disciplina legislativa (per esempio, la Regione Lazio con la legge n. 6 del 2019 e, prima ancora, la Regione Toscana e la Regione Puglia).
L’epoca delle pseudo liberalizzazioni a beneficio dei forti
Dunque, pare che finalmente il legislatore nostrano abbia fatto tesoro della pessima esperienza delle presunte liberalizzazioni che nel 2006 (col DL 223/2006, c.d. decreto Besani) avevano determinato l’abrogazione dei minimi tariffari e poi nel 2009 (col DL 1/2012 c.d. Cresci Italia del governo Monti) l’abrogazione per intero del sistema tariffario, poi sostituito dai nuovi parametri ministeriali per la determinazione dei compensi in assenza di accordo tra le parti (da ultimo, per gli avvocati, il DM 13.8.2022, n. 127 che ha aggiornato il precedente DM 8.3.2018, n. 37 che aveva sostituito il primo DM 10.3.2014, n. 55).
In effetti, di tali presunti interventi non v’è dubbio che abbiano beneficiato in concreto esclusivamente i soggetti già forti sul mercato e perciò in grado di dettare ed imporre modalità e termini di ingaggio anche nei confronti dei professionisti, rimasti privi finanche di quel minimo di tutela che assicurava il sistema tariffario previgente.
L’opportuno dietro front del legislatore
Così negli ultimi anni abbiamo assistito ad un mutamento di rotta opportuno e doveroso da parte del legislatore con l’introduzione di tutele per il lavoro autonomo non imprenditoriale (la legge n. 81 del 2017 ovvero il c.d. jobs act degli autonomi) e della previgente disciplina sull’equo compenso del 2017 che, per quanto concerne l’avvocatura, aveva portato anche alla introduzione del “nuovo” art. 13 bis inserito nella legge di riforma professionale n. 247 del 2012.
Peraltro, l’intervento legislativo era necessario anche in ragione di una giurisprudenza sfavorevole ai professionisti (al riguardo basti menzionare quella amministrativa che predicava come fosse legittimo finanche il lavoro gratuito a beneficio delle pubbliche amministrazioni: Cons. St., sez. Quinta, sentenza n. 4614/2017 e Cons. St., sez. Quarta, sentenza 7442/2021, dove il valore patrimoniale della prestazione viene individuato nell’immaginario godimento di una sorta di “ritorno di immagine”).
Del resto, già la disciplina del codice civile del ’42 prevedeva che la misura del compenso dovesse essere adeguata “all’importanza dell’opera ed al decoro della professione” (cfr. art. 2233 co. 2 e, prima ancora, art. 2060 c.c.), ma da allora -evidentemente- per i professionisti italiani sono stati fatti molti passi indietro almeno fino alla lenta inversione di tendenza alla quale abbiamo fatto cenno e nell’ambito della quale si inserisce a pieno titolo la disciplina dell’equo compenso, con la previsione di sanzioni rispetto a fattispecie di evidente abuso contrattuale a beneficio del professionista, correttamente inquadrato (finalmente) come la parte debole del rapporto negoziale con la grande impresa e l’Amministrazione.
La nuova disciplina
Ebbene la nuova disciplina opportunamente amplia l’ambito di applicazione delle tutele nei confronti di imprese bancarie, assicurative, società da loro controllate, mandatarie e imprese che hanno impiegato l’anno precedente più di cinquanta lavoratori (o con ricavi annui superiori ai dieci milioni di Euro), nonché nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle società partecipate.
Restano ancora escluse le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione anche se questi ultimi devono comunque garantire compensi adeguati che tengano però conto della possibile ripetitività della prestazione.
Le clausole nulle sono finalmente tutte quelle che prevedono un compenso non equo e proporzionato all’opera prestata e, dunque, inferiore ai parametri vigenti, oltre che quelle espressamente elencate dal legislatore all’art. 3 co. 2 lett. da a) a l); la nullità opera a vantaggio del solo professionista che potrà giudizialmente fare valere le sue ragioni nel Foro domestico di residenza o domicilio.
Il ruolo pubblicistico dell’Ordine professionale viene rivalutato, laddove il giudice potrà rivolgersi all’ente pubblico non economico per chiedere un parere sulla congruità della richiesta del professionista, prima di accertare il carattere non equo del compenso, liquidare la differenza dovuta e finanche condannare la parte soccombente ad un indennizzo pari al doppio della differenza tra quanto già versato e quanto riconosciuto come dovuto, salvo l’eventuale maggior danno.
Inoltre, gli Ordini dovranno adottare nuove disposizioni deontologiche nei rispettivi codici per scongiurare vere e proprie corse al ribasso tra i propri iscritti, con evidente nocumento per la qualità delle prestazioni, nonché del prestigio e del decoro professionale.
I pareri di congruità resi dagli Ordini, la cui valenza era stata opportunamente riaffermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (con la sentenza n. 19427/2021), costituiranno d’ora innanzi titolo esecutivo, senza necessità di esperire il preventivo procedimento monitorio dinanzi al giudice, ma legittimando l’avvio immediato dell’azione esecutiva con l’atto di precetto.
I consigli nazionali poi potranno adottare modelli standard di convenzioni con le imprese che dunque potranno confidare nella presunzione di equità del trattamento riservato ai professionisti dei quali si avvalgono e gli stessi potranno opportunamente anche promuovere azioni di classe, insieme alle associazioni maggiormente rappresentative, per tutelare i diritti individuali omogeni dei propri iscritti.
Infine, il legislatore ha previsto opportunamente l’istituzione di un osservatorio nazionale, variamente composto, con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio in concreto sull’applicazione delle nuove disposizioni.
Le considerazioni finali.
Certamente la nuova disciplina avanza di molto la soglia di tutela del professionista laddove egli sia parte debole del rapporto contrattuale rispetto ai grandi committenti, ma restano delle criticità e, prima tra tutte, la prevista inapplicabilità ex tunc alle convenzioni in essere, col rischio perciò che i clienti forti continueranno ad avvalersi di queste, senza stipularne di nuove.
Tuttavia, per i nuovi incarichi, sia pure riferiti a convenzioni preesistenti, in via interpretativa, potrebbe estendersi l’applicazione della disciplina di nuovo conio e certamente resta vigente la tutela già offerta dal legislatore nel dicembre 2017 con la disciplina oramai abrogata espressamente con l’entrata in vigore del nuovo articolato normativo.
Spetterà ai professionisti, ai loro ordini e collegi professionali (territoriali e nazionali) ed alle associazioni di categoria attrezzarsi in fretta per difendere in tutte le sedi la portata applicativa della disciplina a breve vigente all’esito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per evitare che il tema resti una mera affermazione di principio (sia pure sacrosanto) ed oggetto di studio ed approfondimento solo in astratto nell’ambito di dibattiti e convegni di studi, laddove invece una importante difesa, soprattutto dinanzi ai competenti organi giurisdizionali, potrà scongiurare interpretazioni e prassi volte a sminuire l’effettività della tutela come comprovato, per esempio, dalla costante attività di contrasto e impugnativa giurisdizionale sostenuta meritevolmente da pochi ordini professionali nei confronti di bandi ed avvisi lesivi (cfr. TAR Campania, sez. Prima, sentenza n. 1114/2022 e TAR Campania, sez. Sesta, sentenza n. 7037/2022) durante la vigenza della previgente disciplina.