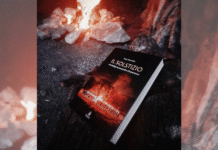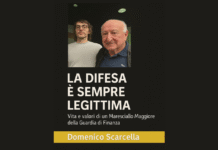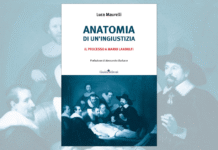Il voto odierno al Senato
Oggi, 22 luglio 2025, il Senato è chiamato a esprimersi sul disegno di legge costituzionale che intende introdurre la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti. Questa proposta, presentata dal governo Meloni, ha già ottenuto l’approvazione in prima lettura alla Camera il 16 gennaio 2024, con il sostegno della maggioranza e di alcuni partiti di opposizione. In caso di approvazione al Senato, il testo dovrà tornare alla Camera dopo almeno tre mesi per una seconda votazione, e successivamente di nuovo al Senato. Se nella seconda lettura non si raggiungono i due terzi dei voti in entrambe le Camere, potrebbe essere indetto un referendum popolare, un’opzione che sembra plausibile considerata la complessità del tema.
Il contesto del dibattito
Il tema della separazione delle carriere è al centro di un dibattito che dura da tempo nel sistema giudiziario italiano. Attualmente, i magistrati possono svolgere sia il ruolo di giudice, responsabile di valutare prove e pronunciare sentenze, sia quello di pubblico ministero (PM), che guida le indagini e rappresenta l’accusa. La carriera è condivisa: dopo una formazione iniziale comune, è consentito un cambio di funzione una sola volta nei primi dieci anni, come stabilito dalla riforma Cartabia del 2022, che ha limitato opzioni precedenti. Tutti i magistrati sono supervisionati da un unico organismo, il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), presieduto dal Presidente della Repubblica, che gestisce nomine, trasferimenti e aspetti disciplinari.
Le modifiche previste dalla riforma
La riforma proposta dal governo mira a trasformare questo modello, richiedendo a ogni magistrato di scegliere all’inizio della carriera se diventare giudice o PM, senza possibilità di variazioni successive. Questo cambio di paradigma ritenuto fondamentale per la maggioranza, tra cui il ministro Nordio, che ritengono che ciò aumenti l’indipendenza dei giudici, prevenendo che un ex PM porti con sé un’ottica accusatoria nel ruolo giudicante.
La creazione di due CSM autonomi
Un aspetto centrale della riforma è l’istituzione di due Consigli Superiori della Magistratura separati: uno per i giudici e uno per i requirenti. Entrambi saranno presieduti dal Capo dello Stato e includeranno figure di vertice della Corte di Cassazione, ma con una selezione dei membri basata sul sorteggio. I componenti togati saranno estratti da elenchi specifici di giudici o PM, mentre i laici (professori universitari o avvocati con esperienza) da liste redatte dal Parlamento. Questo approccio intende ridurre l’influenza delle correnti, gruppi con orientamenti ideologici che hanno condizionato nomine e scelte in passato. L’ANM ha criticato la proposta, sostenendo che comprometterebbe l’autonomia dei magistrati.
L’introduzione dell’Alta Corte disciplinare
Oltre alla separazione, i due CSM si occuperebbero solo di aspetti gestionali come assunzioni e promozioni, mentre le questioni disciplinari verrebbero affidate a un nuovo organismo, l’Alta Corte disciplinare. Questa corte, composta da 15 membri, includerebbe tre nominati dal Presidente della Repubblica tra esperti con almeno 20 anni di esperienza, tre sorteggiati da liste redatte dal Parlamento, sei sorteggiati tra giudici e tre tra PM con anzianità simile. In questo modo, si separa la funzione amministrativa da quella sanzionatoria, con il presidente della corte scelto tra i nominati più qualificati.
Le posizioni dei partiti
Le opinioni politiche sulla riforma rivelano divisioni trasversali. La coalizione di centro-destra – Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati – ha supportato il testo in modo unitario, in coerenza e in attuazione del programma elettorale sottoposto agli elettori nel 2022. Un referendum abrogativo per la separazione delle carriere, nel giugno 2022 aveva registrato una maggioranza di sì, ma era stato invalidato per mancato quorum. Nell’opposizione, PD, M5S e Alleanza Verdi-Sinistra hanno votato contro, criticando potenziali squilibri. Azione e Più Europa hanno invece approvato, richiamandosi a tradizioni radicali per una giustizia più bilanciata, mentre Italia Viva si è astenuta, concordando sul principio ma dissentendo sul sorteggio per i membri laici.
Il processo parlamentare
L’iter della riforma rimane articolato. Dopo il voto di oggi al Senato, seguirà un intervallo di tre mesi prima della seconda approvazione alla Camera e poi al Senato. In assenza dei due terzi dei voti, si procederebbe a un referendum. Anche in caso di approvazione definitiva, saranno necessari adeguamenti normativi: entro un anno, governo e Parlamento dovranno aggiornare leggi esistenti, inclusa quella del 1958 sul CSM, per allineare l’ordinamento giudiziario alle nuove regole.