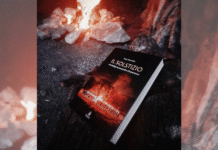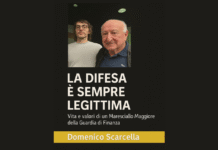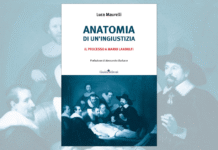A cura di Mariangela Coda
Ricorre, nell’anno 2021, il settecentenario della morte di Dante Alighieri, avvenuta a Ravenna, città in cui fu esiliato, la notte tra il 13 e il 14 settembre 1321. A fronte di tale anniversario, non possiamo esimerci dal ricordare le opere ed il pensiero del sommo poeta che ha rappresentato e ancora oggi rappresenta l’icona della cultura italiana nel mondo.
Tra le tematiche a lui molto care, che si insinuano costantemente nelle sue opere, vi è la giustizia, nonostante egli, a differenza di alcuni intellettuali suoi contemporanei, come il poeta e giurista Cino da Pistoia, non ebbe una vera e propria formazione giuridica.
Il significato che Dante attribuiva al concetto di giustizia è assai lontano dall’interpretazione attuale della stessa poiché, nella storia contemporanea, ha assunto un valore oggettivo e scevro da qualsiasi interferenza religiosa e morale. Infatti, si potrebbe dire che correntemente «la giustizia, da un lato, consiste nel riconoscimento e nel rispetto dei diritti altrui sia come consapevolezza sia come prassi del singolo e delle istituzioni e, dall’altro, si identifica nel potere o nell’autorità a cui è affidato il potere di realizzare il diritto con provvedimenti aventi forza esecutiva[1]».
Nell’universo dantesco, la giustizia, che affonda le sue radici nella tradizione cattolica e che trova la sua massima espressione poetica nella Divina Commedia, è il vero e proprio fulcro di un mondo proiettato alla trascendenza di Dio e da quest’ultimo ordinato e governato. Il sommo poeta, infatti, interpreta la giustizia come giustizia divina, posseduta in sommo e perfetto grado da Dio, di cui costituisce uno degli attributi. Più precisamente essa, alle volte citata con il termine drittura, è, per Dante, tra le virtù che guidano l’uomo la più nobile in quanto necessaria ed imprescindibile per garantire un retto ordine all’interno della società civile e nell’aldilà. Non a caso, l’Alighieri credeva fermamente che «il mondo è disposto nella maniera migliore quando la giustizia si trova al massimo grado[2]».
Oltre che divina, la giustizia illustrata dall’Alighieri è retributiva, in quanto Dio, che è Giustizia Amore e Sapienza, ha il potere di infliggere pene o donare ricompense agli uomini a seconda del loro agire in terra. E il viaggio che Dante racconta nella Divina Commedia è la perfetta raffigurazione dell’itinerario che conduce l’uomo dalla giustizia umana alla giustizia divina, e cioè dal peccato alla redenzione.
Alla luce di tali deduzioni, la giustizia dantesca è da considerare un concetto anacronistico, in quanto il sommo poeta le attribuiva un contenuto teologico che, invece, nel nostro sistema giuridico, essendo dichiaratamente laico, è stato completamente abbandonato con l’entrata in vigore della Costituzione, avvenuta il 1 gennaio 1948. L’unico esempio di continuità con la giustizia dantesca si rinviene, oggi, nel diritto canonico, poiché secondo la Chiesa Cattolica la giustizia incarna una delle virtù cardinali per la quale si riconosce e si opera il bene nella società.
In definitiva, la giustizia come illustrata dall’Alighieri non può che essere considerata un concetto antiquato, relegata nel diritto medievale perché intrisa di elementi extragiuridici. Risulterebbe, infatti, totalmente assurdo avanzare oggi l’idea secondo cui la giustizia rappresenta Dio stesso, nelle vesti di giudice, che giudica l’operato degli uomini e, sulla base di questo, li premia o li punisce.
Tuttavia, se la iustitia dantesca è ormai da considerare un concetto arcaico, nettamente superato, un elemento di discontinuità con la nostra epoca, lo stesso non può dirsi della drittura, seppur spesso utilizzata dall’Alighieri come sinonimo di giustizia. Tale costatazione deriva dal fatto che il significato di drittura non coincide sempre e perfettamente con quello di giustizia. E la mancata simmetria tra i due concetti ut supra citati si può cogliere anche da un’analisi squisitamente etimologica, per evidenziare le singole sfumature di ognuno, impercettibili agli occhi dei più.
Giustizia trae le sue origini dall’aggettivo latino iustus «giusto», che a sua volta deriva da ius, «diritto o ragione», mentre drittura deriva dal latino directus «diretto». Il confronto tra le due parole citate viene analiticamente illustrato da Zdenka Kolarova[3], in un articolo risalente al 1975, nel quale l’autrice evidenzia, tanto nella lingua francese che in italiano, le sinonimie e le digressioni semantiche: a) iustus – juste – giusto; b) directus – droit – direct – diretto – diritto – dritto.
Da tale valutazione si evince che directus assume l’accezione di rectus, ossia quel che è in ordine, in regola, diritto, mentre, iustus, da cui deriva giustizia e che appartiene per eccellenza alla sfera morale, viene comparato con aequus. L’analisi etimologica condotta dalla Kolarova dimostra una notevole differenza tra il concetto di giustizia e quello di drittura: i due termini hanno, infatti, radici e significati diversi.
Accertata la divergenza etimologica, è necessario ora procedere ad una valutazione del termine drittura nelle opere dantesche per verificare, in primis, se tra drittura e giustizia ci sia perfetta sincronia e, in secundis, per decretare se drittura sia un elemento di continuità o discontinuità tra il pensiero giuridico dantesco e il sistema giuridico attuale.
Un primo riferimento alla drittura intesa come giustizia divina si scorge in un passo della Divina Commedia, «tutto suo amor là giù pose a drittura[4]». In questo verso Dante narra le gesta di Rifeo, personaggio illustre dell’Eneide che compare tra i guerrieri unitisi ad Enea la notte della caduta di Troia e morto eroicamente nell’estrema difesa della città. Virgilio lo descrive come «il più giusto e il più osservante del diritto tra i troiani, anche se perì per volontà degli Dei[5]». Dante, sulla scia del pensiero virgiliano, colloca Rifeo tra gli spiriti giusti del VI Cielo del Paradiso pur essendo costui un pagano. In questo passo drittura è puro sinonimo di giustizia divina in quanto l’Alighieri alludeva al fatto che il valoroso troiano, quando era ancora in vita, indirizzò tutto il suo agire verso la giustizia, intesa come obiettivo a cui tende ogni uomo virtuoso per garantirsi l’aldilà.
Altro riferimento esplicito al termine drittura, si rinviene in un celebre passo delle Rime[6], scritto probabilmente nei primi anni dell’esilio (1302/1304), in cui si narra di un ipotetico dialogo tra Amore e Giustizia: «Oh di pochi vivanda, nostra natura qui a te ci manda: io che son la più trista son suora a la tua madre e son drittura». Anche in questo passo, drittura raffigura la Giustizia universale e divina: con esattezza essa impersona la dea della Giustizia poiché si presenta ad Amore come la sorella di sua madre che, nella mitologia classica, è Venere, figlia di Giove. Il dialogo tra i due protagonisti continua e drittura, dopo aver spiegato di essere stata esiliata dalla società («io che son la più trista»), presenta ad Amore altre due donne, belle e virtuose ma sconsolate: la figlia che incarna la Giustizia umana e la nipote, che rappresenta la Legge. Dunque, anche in questo passo è evidente la perfetta sinonimia tra drittura e giustizia dantesca.
Diverso è, invece, il significato di drittura nel Convivio, una sorta di enciclopedia sul sapere medievale redatta nei primi anni dell’esilio, tra il 1304 e il 1307. Nel Libro IV, Dante nel descrivere le virtù recita «l’undecima è la Giustizia, la quale ordina noi ad amare e operare drittura in tutte le cose[7]». In questo frammento, per la prima volta, il sommo poeta distingue i due concetti, inserendoli entrambi nella stessa frase e alludendo a significati diversi. Per quanto riguarda la giustizia, essa rappresenta una delle tante virtù «che rende l’uomo beato ovvero felice», mentre la drittura incarna il metodo da seguire in tutti gli aspetti della vita umana affinché si realizzi la giustizia. Pertanto, la drittura, in questo passo, non può essere banalmente interpretata come giustizia ma è da considerare, come la definisce Andrea Mariani nell’enciclopedia dantesca, «un fine di rettitudine e di equità cui deve tendere la quotidiana pratica del cristiano[8]».
Dunque, mentre nel Paradiso (XX, 121) e in Rime (CIV, 35) il senso di drittura equivale a quello di giustizia, intesa come divina iustitia, nel Convivio, invece, la drittura è da interpretare come rettitudine ed equità. Tale teoria prende le mosse da una linea di pensiero illustrata da Sant’Agostino nel De Ordine e da Sant’Anselmo d’Aosta nel De Veritate[9]. Questi ultimi definivano la rectitudo un elemento costitutivo della giustizia in quanto la rettitudine, ossia la legalità, consente un collegamento ontologico tra il piano individuale con quello sociale, tra l’essere con il dover essere, tra la libertà con il riconoscimento della verità[10]». Per Sant’Agostino e Sant’Anselmo, dunque, è attraverso la rettitudine, e cioè l’agire giusto, conforme ai principi morali ed al diritto, che si realizza la giustizia intesa come accettazione delle proprie libertà e dei propri limiti a fronte delle libertà altrui.
A tal proposito, la drittura, a cui Dante allude nel Convivio, è un esplicito richiamo alla rettitudine elaborata dalla filosofia cristiana secondo cui la giustizia si realizza pienamente mediante il rispetto ortodosso e costante dei principi e delle norme giuridiche da parte di ogni uomo.
La simmetria tra drittura e rettitudine si deduce anche dal fatto che entrambi i termini derivano dalla stessa parola latina «rectus», come illustrato dalla Kolarova nel 1975[11].
Orbene, in virtù della immedesimazione tra drittura e rettitudine, prospettata nel Convivio, si coglie un elemento di continuità tra il diritto medievale, interpretato dall’Alighieri, e il diritto contemporaneo. La drittura, infatti, qualificata come rettitudine, potrebbe risultare l’antesignano del diritto naturale come attualmente interpretato. Secondo la teoria giusnaturalista pura, il diritto naturale coincide con il complesso di norme non codificate, che appaiono evidenti, eterne e giuste, dalle quali, di regola, derivano le disposizioni positive. Mentre, secondo una più recente riflessione sul diritto naturale, esso appare come l’insieme dei principi inviolabili sui quali si strutturano gli Stati moderni. Pertanto, in virtù delle teorie novecentesche, il diritto naturale è l’insieme dei principi sanciti dalle Carte Costituzionali dei singoli Stati moderni e dalla CEDU.
La suddetta costatazione deriva dal fatto che entrambi, sia la drittura sia il diritto naturale, trovano il loro fondamento nei principi di giustizia e di equità. Infatti, come nel Convivio la drittura rappresenta lo strumento attraverso il quale si realizza la virtù della giustizia, così il diritto naturale, ossia l’insieme delle norme considerate universali e preesistenti al diritto positivo, incarna il mezzo necessario per addivenire alla giustizia intesa quest’ultima come «principio secondo cui si attribuisce a ciascuno ciò che gli è dovuto secondo la ragione e la legge[12]».
L’unico elemento di contrasto è rappresentato dalla diversa natura della finalità che la drittura e il diritto naturale perseguono: mentre la drittura è il metodo che ogni cristiano deve seguire per realizzare la giustizia divina[13], il diritto naturale, invece, persegue la giustizia umana, priva di qualsiasi richiamo alla religione.
C’è, dunque, una simmetria tra drittura e diritto naturale che, invece, non si ravvisa in riferimento al diritto positivo, in quanto quest’ultimo non sempre è conforme alla giustizia: lo sosteneva Dante, denunciando a gran voce la decadenza della legge del suo tempo, causa di gravi ingiustizie, e lo hanno sostenuto alcuni giuristi moderni e contemporanei, soprattutto in riferimento ad alcune norme discriminatorie[14]. È evidente, pertanto, una netta ed insanabile divergenza tra drittura e diritto naturale, da un lato, e diritto positivo dall’altro, sia in epoca dantesca che nella storia contemporanea.
Molteplici sono i passi in cui Dante, dopo essere stato esiliato da Firenze a Ravenna[15], critica aspramente la legge del suo tempo, ritenendola priva di morale e lontana dalla giustizia. Ad esempio, nel Canto V dell’Inferno in cui Virgilio e Dante incontrano i lussuriosi, tra i quali figurano Didone, regina e fondatrice di Cartagine, Cleopatra, la regina d’Egitto e Elena di Sparta, il sommo poeta arriva a sostenere che «A vizio di lussuria fu si rotta/ che libito fe licito in sua legge/ per torre il biasmo in cui era condotta[16]». In tale terzina si descrive il comportamento immorale e contra ius di Semiramide, la leggendaria regina degli Assiri che nel Medioevo era considerata il simbolo per eccellenza di corruzione e sfrenata lussuria. Ciò a cui Dante, in termini allegorici, allude nella terzina ut supra citata è esattamente il modus agendi, che egli disprezza, delle pubbliche autorità sue contemporanee. Infatti, come Semiramide, per cancellare il biasimo in cui era incorsa, rese lecito ciò che a ciascuno piaceva, attribuendo ai suoi sudditi libertà illimitate, spesso eccessive, così i pubblici poteri, tramite le leggi, hanno reso giusto, e dunque lecito, ciò che è, in natura, ingiusto e privo di equità.
E ancora, nel settimo cerchio dell’Inferno[17], Dante elenca alcuni dei tiranni più spietati della storia umana, tra i quali figurano Alessandro, Dionisio, Ezzelino e Obizzo d’Este che fecero violenza nei confronti dei propri sudditi, uccidendoli e depredandoli dei loro averi, in virtù di leggi, formalmente corrette ma prive di giustizia. Fuor di metafora, i tiranni elencati nel Canto XII dell’Inferno altro non sono che la rappresentazione dei politici e delle autorità giudiziarie del suo tempo, che il sommo poeta definiva malvagi e dannatamente capaci di emanare leggi spietate.
Un altro passo in cui il sommo poeta descrive l’inefficacia e l’ingiustizia delle leggi si ravvisa nel Canto XXII dell’Inferno, in cui il pellegrino giunge nella quinta bolgia dove sono puniti i barattieri. Nel Medioevo, la baratteria rappresentava, da un lato, l’insidia truffaldina, specie a livello popolaresco, ad esempio il piccolo imbroglio giocato nelle piazze ai danni degli ingenui e, dall’altro, la colpa di coloro che, ricoprendo cariche pubbliche, concedevano dietro pagamento o per ottenere altri vantaggi, condanne o assoluzioni. Proprio in virtù di questa seconda accezione, la baratteria altro non è che un richiamo esplicito alla prassi degradata del suo tempo, ossia alla corruzione e all’ingiustizia perpetrate dai pubblici poteri, a discapito della legalità e del senso del dovere. Infatti le funzioni esercitate dalle pubbliche autorità sono perfettamente legittime, in quanto dettagliatamente regolamentate da norme di diritto positivo, ma sono totalmente prive di giustizia e di equità in quanto le stesse vengono esercitate non per il bene comune bensì per perseguire interessi personali ed illeciti.
Nelle opere citate si assiste, in definitiva, ad una netta separazione tra norme superiori e leggi positive, o meglio ad una evidente contrapposizione tra diritto naturale e diritto positivo. Dante, in altri termini, non denunciava l’assenza di un ordine legale, poiché nella prassi la legge c’era, quanto piuttosto la sussistenza di una legge completamente slegata dalla giustizia, come più volte aveva sostenuto in merito alla sua condanna, tecnicamente legale ma ingiusta[18]. Egli, in particolare, considerava lo ius positum ingiusto perché emanato da un corpo politico incapace, corotto e malvagio.
Trasportando ai giorni nostri il giudizio dell’Alighieri sul diritto positivo, e soprattutto sulla mancata simmetria tra diritto naturale e diritto positivo, non si può non parlare di continuità visto che non mancano esempi di leggi, emanate dallo Stato o dalle Regioni, che cozzano con il diritto naturale e cioè con i principi inviolabili sanciti dalle Carte Costituzionali.
Se si va poco più a ritroso nel tempo, possono essere citate come esempio lampante di leggi ingiuste, e dunque di diritto positivo in netto contrasto con il diritto naturale, le leggi razziali emanate, rispettivamente, dal regime nazista nel 1933 e dal regime fascista nel 1938.
Volgendo lo sguardo ai nostri giorni, ci sono ancora leggi, forse poche numericamente ma molto rilevanti dal punto di vista qualitativo, che entrano gravemente in contraddizione con il giusto naturale. Basti pensare, tanto per fare un esempio, ad alcune leggi che negano o svuotano il diritto alla vita di alcune categorie di persone, come la legge sull’aborto oggi ampiamente accettata in Occidente ma ancora profondamente criticata in Oriente, ovvero la legge sulla pena di morte, ancora in vigore in numerosi Stati, quali la Cina, il Giappone, la Corea del Nord, l’Iran e gli Stati Uniti d’America.
Gli esempi sin qui elencati dimostrano a chiare lettere che il diritto naturale, o la drittura come citata dal sommo poeta, non si esaurisce nella positività della legge poiché esso è il substrato fondamentale su cui le pubbliche autorità emanano la legge. «E, nonostante il diritto naturale sia preesistente e originante rispetto al diritto positivo, non è detto che quest’ultimo sia perfettamente conforme al giusto naturale, dato che ci sono relazioni sociali e comportamenti ingiusti per natura che invece vengono considerati giusti per convenzione di legge»[19]. E tale triste realtà era tanto presente nel periodo storico dantesco quanto nel nostro.
In conclusione, se la giustizia dantesca, intesa come giustizia divina, va relegata nella storia medievale perché è ormai un concetto anacronistico per i nostri giorni, la drittura, che incarna il diritto naturale, rappresenta invece un elemento di continuità con il diritto contemporaneo. Come era già stato sottolineato da Dante, il diritto naturale assume oggi come allora il duplice ruolo di faro e di limite invalicabile per la legge ordinaria.