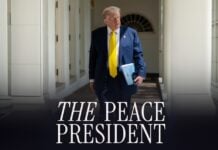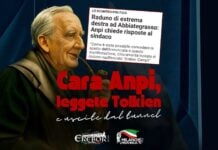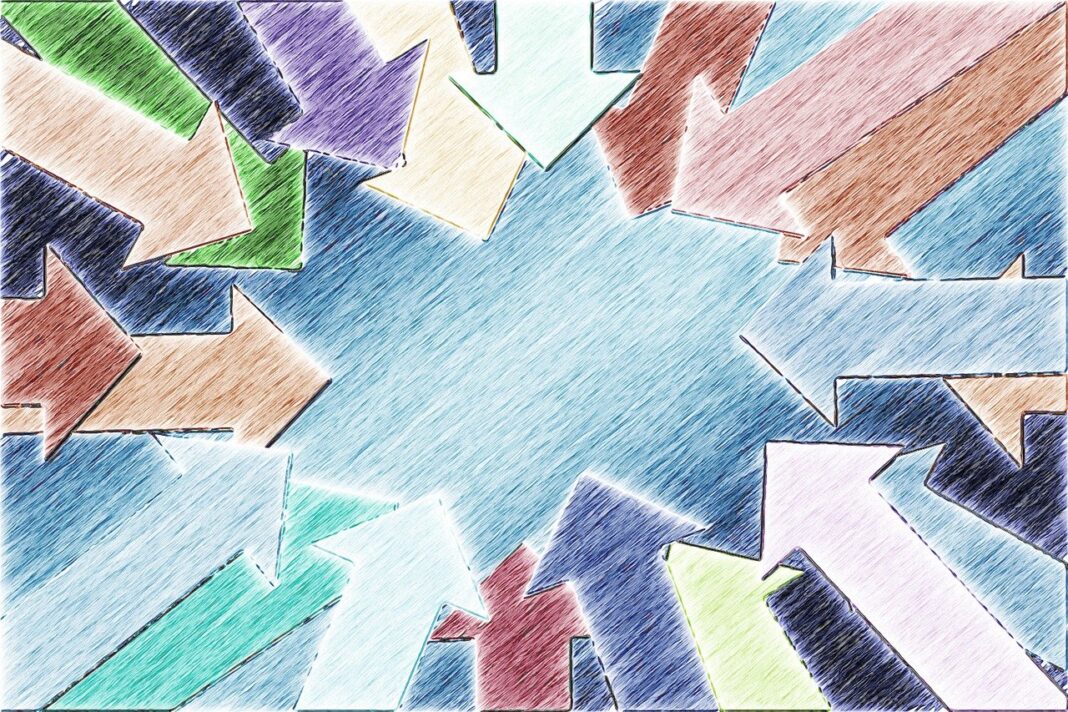Il tema della partecipazione dei lavoratori agli utili e alla gestione delle imprese (art. 46 della Costituzione) riaffiora spesso nel dibattito politico e culturale italiano. Le idee di cogestione, democrazia economica, partecipazione, con tutte le loro particolarità e differenze, fanno parte a diversi livelli del patrimonio di diverse socialdemocrazie europee quanto del cattolicesimo sociale. L’Italia in questo senso rappresenta un caso peculiare, in quanto l’idea partecipativa ha trovato i più accesi sostenitori nella storia repubblicana a destra, all’interno del Movimento sociale Italiano e del sindacalismo nazionale della Cisnal in primis. Ambienti politici che raccoglievano tanto gli sforzi disperati della Repubblica Sociale Italiana (il cui decreto sulla socializzazione delle imprese del 1944 fu studiato sia in Germania che negli Stati Uniti), quanto una lezione ancora più lontana e profonda: dall’afflato etico di Giuseppe Mazzini con le sue idee di collaborazione di classe fino alla Carta del Carnaro di D’Annunzio e De Ambris, passando per il sindacalismo rivoluzionario della prima metà del ‘900, il nazionalismo sociale di Filippo Carli e la Democrazia Futurista di Filippo Tommaso Marinetti.
Queste radici storiche hanno contribuito ad allontanare la concreta applicazione dell’art. 46, perché sostanzialmente incompatibili con le culture politiche dominanti nel secondo dopoguerra. In particolare, le idee marxiste e la centralità della lotta di classe che caratterizzavano il Pci e il sindacalismo di sinistra erano troppo lontane da qualsiasi tentativo di coinvolgimento dei lavoratori nelle alte sfere aziendali: sarebbe stato un compromesso inaccettabile con i “padroni”. Dall’altro lato, il mondo industriale e finanziario rimaneva restio ad accettare la partecipazione delle maestranze alla gestione delle imprese.
In questo scetticismo, la sinistra classista e il mondo padronale trovavano “paradossalmente” un punto d’incontro, come testimonia l’incontro nel 1973 tra Umberto Agnelli e Giorgio Amendola nel contesto della Tavola Rotonda sullo sviluppo economico, riportato da Giano Accame nel libro La Destra Sociale. Alcuni ambienti della Democrazia Cristiana, cresciuti nella palestra del dibattito economico tra le due guerre e del corporativismo cattolico, cercarono al contrario di mantenere alta la bandiera della terza via e della partecipazione. Tra gli altri si distinse Amintore Fanfani, che negli anni ’70 scrisse un libro dal titolo Capitalismo, Socialità, Partecipazione, in cui sottolineava che: «Una società come quella capitalistica che tanto protegge e tanto riconosce i diritti del titolare della proprietà dei beni deve per coerenza e per gli stessi motivi proteggere e riconoscere i diritti del titolare della proprietà della capacità di lavoro.
Tra questi diritti v’è anche quello della continuità dell’impiego dei beni posseduti. (…) Ne deriva che ogni decisione presa senza la partecipazione e quindi l’adesione implicita od esplicita dei titolari delle capacità di lavoro è assimilabile ad una sospensione (…) della libertà e dello sviluppo di ogni persona (…) sul piano dell’azienda, del sistema economico, del sistema sociale, del sistema politico».
La Destra sociale. Come si accennava, fu la destra che più di ogni altro portò avanti l’idea partecipativa, con uno slancio arrivato fino ai giorni nostri. Dal 1955, il Movimento sociale promosse ben 8 documenti e proposte di legge per l’attuazione dell’articolo 46 della Costituzione (1955, 1971, 1972, 1973, 1975, 177, 1979, 1991). Nel 1991, una commissione di esperti elaborò la «Proposta di legge per l’Istituzione dell’Impresa Partecipativa» di altissimo livello, sotto la direzione di Gaetano Rasi e dell’Istituto di Studi Corporativi. Quest’ultimo ente elaborò per 20 anni (1972-1992) una serie di riflessioni e proposte organiche che collegavano la partecipazione a una serie di riforme quali il presidenzialismo e l’istituzionalizzazione delle competenze (attraverso la valorizzazione del Cnel e la modifica della seconda Camera) per superare i limiti della partitocrazia e del parlamentarismo. L’idea corporativa veniva rilanciata in chiave pluralista e moderna, senza dimenticare le idee di sacrificio, di selezione e responsabilità politica. Rasi sottolineò: «La partecipazione è un elemento essenziale del corporativismo, ma non è tutto il corporativismo. Perché? Perché il corporativismo non è solo partecipazione paritaria (pari dignità, pari diritto) ma è anche impegno ad assumere il ruolo che ciascuno deve avere nella società, così come lo si deve assumere all’interno dell’impresa. Quindi per alcuni è impegno superiore a quello degli altri. I più dotati, i più capaci, i più competenti debbono avere delle responsabilità maggiori e quindi essere trainanti. Quando noi agiamo in sede politica, in sede di partito politico, non possiamo accettare esclusivamente il concetto del “partito che interpreta la gente”, che “dà più forza alla gente”. Questo è un concetto limitativo. (…) Il partito politico esiste e può esistere solo in quanto deve guidare al mutamento, deve guidare in direzione di una società migliore di cui si ha consapevolezza. Deve guidare in direzione di una società organizzata a Stato e questo Stato deve essere uno Stato con una natura superiore a quella precedente».
Gli spunti, seppur attenuati, in direzione dell’applicazione dell’art. 46 non sono venuti meno né in Alleanza Nazionale né in Fratelli d’Italia, che ha presentato un significativo disegno di legge su iniziativa dei senatori Iannone e La Pietra nel 2018 per «l’adozione di un Statuto partecipativo delle imprese». Nel pieno della crisi sanitaria, economica, sociale e delle dinamiche della globalizzazione odierna, che sembrano accelerare i cambiamenti nel mondo del lavoro in maniera impressionante, appare vitale riprendere in mano questo filone culturale. La partecipazione correttamente intesa potrà essere un’arma per governare e promuovere l’innovazione (si pensi al tema della robotica) ed evitare le delocalizzazioni che tanto hanno pesato negativamente sull’economia nazionale dagli anni ’90 a oggi. Persino ambienti vicini alla Cgil e alla sinistra stanno negli ultimi tempi riconoscendo il valore della partecipazione quale “arma” per un futuro diverso, si vedano le recenti dichiarazioni di Enrico Letta, Susanna Camusso e i volumi di Grazzini e Pennacchi sulla «Democrazia Economica».
È l’occasione quindi per una destra che sia comunitaria e sociale di portare a frutto anni di battaglie, riflessioni e documenti. La valorizzazione della conoscenza, la maturazione dei lavoratori attraverso la partecipazione alla gestione e agli utili, così da superare visioni conflittuali e creare un “destino comune” che rivitalizzi i singoli, i territori e la stessa Nazione, sembrano sempre più i passaggi obbligati per opporsi al declino dell’Italia.