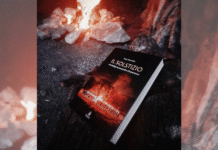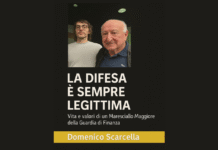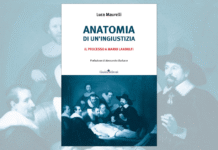Il 23 maggio 1973 alla Camera dei deputati Giorgio Almirante venne chiamato a difendersi dall’accusa di apologia di fascismo, enunciando un lungo e celebre discorso contro la richiesta di autorizzazione a procedere per l’incriminazione di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista del “solo” Segretario del Msi. Il parlamento votò favorevolmente alla richiesta del giudice. Infatti nelle intenzioni dei partiti “dell’Arco costituzionale” (Dc, Pci, Psi, Pri, Pli, Psdi) c’era il malcelato desiderio di sciogliere il Movimento Sociale Italiano, o almeno di silenziare la magnifica e pericolosa oratoria di Almirante; fortunatamente non si è mai andati oltre le richieste di autorizzazioni e le feroci campagne di stampa dei giornalisti di sinistra. Il segretario missino non solo si difese strenuamente dalle faziose accuse, ma in quel bellissimo discorso contrattaccò efficacemente, rivolgendosi direttamente contro l’assemblea del “Sistema”. Ripercorriamone i passaggi più significativi. Almirante iniziò la sua arringa con un’autodifesa accorata contro le ingiuste accuse di “apologia di regime e di riorganizzazione del disciolto partito fascista”, stabilite dalla Legge Scelba del 1952, già previste dalle clausole politiche del Trattato di pace del 1947. Egli imputò invece i partiti “dell’Arco” di tradimento della Costituzione nel vano tentativo di sciogliere un partito democratico e la libertà del suo segretario eletto. Proseguì denunciando la continua e tremenda campagna di stampa, contrapponendo le dichiarazioni di molti esponenti politici che a suo tempo criticarono fortemente la Legge Scelba e la cosiddetta “Legge Truffa”, che vide anche il Movimento Sociale Italiano sulle barricate: Umberto Terracini e Palmiro Togliatti del Pci; Giulio Andreotti, Alcide De Gasperi della Dc, il sardo Francesco Cocco Ortu, Pli: «fu il liberale Cocco Ortu a prendere le pubbliche difese del Msi. […] era un vecchio antifascista, non apparteneva a quella copiosa schiera di liberali che hanno versato incenso, mirra e profumi di ogni genere al defunto partito fascista e al defunto regime fascista». Almirante ricordò come la responsabilità penale fosse personale, e che non si poteva attribuirla di certo ad intero partito politico; né egli poteva essere giudicato per fatti commessi da altri, anche militanti missini; né se avesse lui stesso compiuto un reato, si sarebbe potuto condannare l’intero partito. Affermò di non aver mai agito per vilipendere la Costituzione e la Resistenza e citò le frasi di Palmiro Togliatti, pubblicate su Rinascita del 18 gennaio 1952: «È comprensibile e giusto che in questa nuova società comunista l’esistenza di diversi partiti scompaia e i cittadini più avanzati si raccolgano in una sola organizzazione politica, alla quale è affidato il compito di educare tutta l’umanità nella pratica e nello spirito del socialismo». Secondo la Legge Scelba, continuò Almirante, queste opinioni di Togliatti avrebbero potuto costituire ipotesi di reato. A quel punto i parlamentari comunisti cominciarono a strepitare ed interrompere l’orazione. Almirante proseguì con coraggio ed elencò la collaborazione missina nelle istituzioni: 1947, elezione sindaco di Roma; 1953, Governo Pella; 1955, elezione del Presidente della Repubblica Gronchi; 1957, Governo Zoli; 1960, Governo Tambroni; 1962, elezione Presidente della Repubblica Segni. Affermò quindi che il Movimento Sociale Italiano nei primi quindici anni del regime democratico era stato pienamente inserito nelle dinamiche politiche. Tutto cambiò quando “l’apertura a sinistra” dei primi anni Sessanta, fece del regime fascista, non un episodio della storia italiana, ma un “buco nero” nel quale si erano divisi il Bene ed il Male. Garante di ciò fu il più forte Partito comunista d’Occidente, campione di un anti-totalitarismo che seguitava “l’altro” totalitarismo, dove il rosso si sostituiva al nero. Continuiamo con l’orazione di Almirante: a metà del suo ragionamento avvenne il clou. Almirante cercò di dimostrare il tentativo dei partiti dell’Arco di colpire un partito «ritenuto (da loro stessi) fascista», difese il Msi dall’accusa di essere un partito illiberale e ribadì con decisione che egli era stato eletto democraticamente e pubblicamente in due congressi nazionali, cosa che non tutti i segretari di partito potevano vantare. «Volete colpire un partito da voi ritenuto fascista nel significato che voi date a questa parola, che io certamente non condivido […] cioè un partito totalitario, il partito che si avvia a diventare o tenti di diventare o minacci di diventare partito-Stato? Questo è, secondo la vostra accezione, il partito fascista: il partito che si sostituisce a tutti gli altri, che vuole incarnare, interpretare esso solo lo Stato. Bene, allora cercate di individuare i partiti all’interno dei quali non esiste libertà di parola o di organizzazione. Io mi onoro di dirigere un partito libero». Almirante lanciò a questo punto il suo atto di controaccusa, affermando che la «partitocrazia» e la «correntocrazia» (dei partiti dell’Arco) uccidevano la democrazia parlamentare, mostrando l’inchiesta del New York Times sugli ingenti fondi americani ricevuti dalla Democrazia Cristiana nel dopoguerra, tant’è che anche i parlamentari democristiani rumoreggiarono, costringendolo ad interrompere il discorso. Riprendendo subito la parola, intese ribaltare l’accusa di istigazione alla violenza, elencando i giovani missini uccisi in quegli anni: a Genova, a Salerno, a Parma, ecc.; ma soprattutto ricordò il tragico episodio del Rogo di Primavalle, dove morirono i Fratelli Mattei, evidenziando come il Movimento Sociale Italiano non travalicò mai nel desiderio di vendetta contro gli avversari politici e che il suo partito espresse sempre la propria solidarietà alle vittime altrui. Continuò citando l’onorevole Generale De Lorenzo, esponente della Resistenza e nonostante ciò deputato missino: «basta anche e prima di tutto nelle nostre file alla polemica fascismo-antifascismo, basta alla perdurante guerra civile e al clima di perdurante guerra civile». Ricordò ancora le dichiarazioni dell’onorevole Scelba che aveva denunciato le violenze del Pci e rifiutò la struttura organizzativa di democristiani e comunisti: «Che vale che un partito si dichiari fedele cultore del pluripartitismo o di tutte le democrazie di questo mondo se al suo interno mostra una compagine ferrea, se al suo interno e al suo vertice non si discute, se i segretari di partito sono capi clientela, capi cabila o capi casta o capi tribù? Che importa garantire agli italiani tutte le libertà, se poi la partitocrazia uccide la democrazia parlamentare, e la correntocrazia […] anch’essa uccide». Si scagliò contro l’incitazione alla violenza della “Sinistra Extraparlamentare” e rifiutò l’aggettivo “di Destra” alla cosiddetta “Destra Extraparlamentare”. Propose dure misure anti-violenza contro i vandali e contro chi provocava disordini, concludendo con un incitamento alla libertà. «Ho pronunziato la parola libertà. […] Pronunzio questa parola concludendo e vi ringrazio, onorevoli colleghi, per avermi dato l’onore, di fronte al popolo italiano, di poterla pronunziare, da stasera e da domani in poi, sempre più altamente e largamente». Nel magistrale discorso di Giorgio Almirante “l’antifascismo di regime” tendeva ad eliminare in maniera illiberale e totale la Destra dalla rappresentanza politica, l’obiettivo non si raggiunse mai. Nelle parole del segretario del Msi si scorgeva il vero scopo del progetto della Destra Nazionale che «al di là dei programmi politici, al di là dei programmi sociali ed economici» aveva la volontà di formare una nuova coesione «per gli italiani e tra gli italiani». Almirante immaginò il futuro, guardando lontano e anticipando i tempi, come Dante disse di Virgilio: «Facesti come quei che va di notte/ che porta il lume dietro e sé non giova, ma dopo sé fa le persone dotte». Il progetto politico vedrà la sua realizzazione con la cosiddetta “Svolta di Fiuggi”, sarà interrotto erroneamente nel 2006 e ripreso da Giorgia Meloni nel 2012. Il tema del pregiudizio nei confronti di una destra ormai democratica resta ancora attuale, in particolare dopo l’approvazione della Legge Fiano del 2017 che intende colpire e punire a livello penale, come reato comune, la libertà di pensiero. Si afferma che il ventennio fascista e l’intera classe dirigente di destra non debba far parte della storia italiana, se non in un’ottica ideologico-religiosa di Male assoluto; così facendo si impedisce ogni comprensione del passato. A oltre settant’anni dalla fine del fascismo, esso non risulta passato, ma presente, e non tanto come realtà storica, ma nella sua variante di “fascismo antifascista”. La damnatio memoriae del segretario del Movimento Sociale Italiano ha riguardato in particolare le vicende del razzismo e della Repubblica Sociale Italiana, eliminando il fatto che fu un politico di grande levatura morale, che sedette a lungo in Parlamento nel rispetto degli avversari, che alla fine della sua vita si presentò ai funerali di Berlinguer e quando anch’egli spirò, i suoi stessi avversari espressero il loro commosso e sincero cordoglio. Recentemente lo storico Galli Della Loggia ha affermato che ciclicamente la sinistra italiana scopre che il Paese non è antifascista quanto vorrebbe, imputandone la colpa in particolare a chi si dichiari «di destra» e ai «moderati» che non esprimono l’adesione o la simpatia per l’antifascismo. Ma ha anche ricordato che la particolarità italiana sta nel fatto che l’antifascismo non ha mai voluto rappresentare un valore comune tra destra e sinistra, ma ha contribuito a dividerle sempre di più. Questo si può storicamente imputare al Partito comunista, che ha sfruttato la sua partecipazione alla Resistenza, identificandosi con essa, nascondendo le sue scarse qualità democratiche; perché i comunisti avevano in uso accusare, chi fosse stato «di destra» e «i moderati» contrari alle loro politiche, di «fascismo».
giovedì, Settembre 18, 2025
Create an account
Welcome! Register for an account
A password will be e-mailed to you.
Password recovery
Recover your password
A password will be e-mailed to you.
© La Voce del Patriota 2018 - 2025 | www.lavocedelpatriota.it - testata registrata presso il Tribunale di Roma al nr. 65/2023 | Direttore Responsabile: Ulderico de Laurentiis