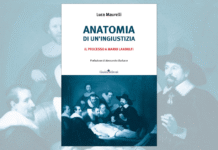Nel marzo del 2025, il mercato del lavoro italiano si presenta come un campo di tensioni incrociate, un terreno instabile su cui si confrontano vecchie fratture e nuove ambizioni di equità. Da un lato, i dati Istat fotografano una contrazione occupazionale modesta ma significativa: 16.000 unità in meno, un tasso di disoccupazione che risale al 6,0% e una disoccupazione giovanile che sfiora il 19%. Dall’altro, segnali di stabilizzazione si fanno strada grazie all’aumento dei contratti a tempo indeterminato, sostenuto dagli incentivi statali alla stabilizzazione.
Ma in questa cornice apparentemente contraddittoria si staglia un interrogativo che il Paese non può più eludere: perché, a parità di lavoro, si osservano differenze retributive così marcate tra settori, territori e categorie professionali? Perché la retribuzione del lavoro non rispecchia più, in modo equo, il valore sociale e umano dell’attività svolta?
Le radici delle divergenze retributive
Nel cuore della questione c’è la rottura del patto sociale tra capitale e lavoro. Il principio classico del salario come remunerazione proporzionata alla produttività e al tempo impiegato si è andato erodendo sotto l’urto della globalizzazione e dell’automazione. Il valore attribuito a un’ora di lavoro non dipende più tanto dall’impegno o dall’utilità sociale, quanto dalla posizione negoziale, dal grado di sostituibilità con macchine o algoritmi, e da variabili speculative che nulla hanno a che fare con la giustizia economica.
Un infermiere guadagna meno di un programmatore blockchain; un docente precario viene retribuito meno di un rider che lavora per tre app contemporaneamente; e un operaio metalmeccanico in Emilia-Romagna ha condizioni salariali radicalmente diverse da un pari grado in Sicilia. Le differenze non sono frutto del merito, ma di un sistema che ha sostituito l’equità con l’efficienza, il bene comune con l’utile immediato.
La settimana corta: panacea o illusione?
In tale contesto si innesta il dibattito sulla settimana lavorativa corta, proposta come una rivoluzione culturale capace di riequilibrare tempi di vita e tempi di lavoro, con la promessa di “vivere meglio” e “produrre di più in meno tempo”.
L’idea non è nuova. Già negli anni ’30 Keynes ipotizzava un futuro in cui si sarebbe lavorato 15 ore a settimana grazie all’automazione. Oggi, tuttavia, la settimana corta rischia di essere una soluzione parziale a un problema strutturale: senza un adeguamento salariale, ridurre l’orario di lavoro significherebbe, per molti, accettare stipendi più bassi. Inoltre, la misura può essere adottata solo da aziende in grado di assorbire la riorganizzazione dei processi produttivi senza ricadute sulla competitività.
Il risultato? Una frattura tra chi può permettersi la settimana corta e chi resta intrappolato in logiche di sfruttamento, con turni frammentati, lavoro intermittente e redditi insufficienti. Le disparità si ampliano, proprio laddove si vorrebbe sanarle.
L’intervento di Papa Leone XIV: verso una “Rerum Digitalium”
In questo scenario, le prime parole di Papa Leone XIV risuonano come un richiamo potente alla coscienza collettiva. Scelto il nome in onore di Leone XIII, autore della Rerum Novarum (1891), il nuovo Pontefice si è rivolto al mondo lanciando un monito: la questione sociale è ancora aperta, ma oggi assume forme inedite, legate all’avvento dell’intelligenza artificiale.
Secondo Papa Leone XIV, l’IA rappresenta una nuova rivoluzione industriale, e come tale richiede una nuova enciclica sociale. Non a caso, ha evocato la necessità di una Rerum Digitalium, una rilettura moderna dei diritti del lavoratore alla luce delle sfide tecnologiche. L’algoritmo – ha affermato – non può decidere chi lavora e chi viene escluso. La macchina non può trasformarsi in criterio di giudizio della dignità umana.
Il lavoro, ha ribadito il Pontefice, non è una merce: è l’espressione della persona, del suo valore, del suo contributo alla comunità. Se l’innovazione servirà a disumanizzare il lavoro, allora non avremo conquistato il progresso, ma solo un dominio tecnico senza anima.
Quale futuro per il lavoratore?
Il rischio non è solo teorico. I primi effetti dell’IA generativa si osservano già: professioni intermedie (dalla contabilità alla grafica, dalla traduzione alla consulenza legale) sono minacciate da sostituzioni algoritmiche. A ciò si aggiunge una polarizzazione salariale: da una parte, lavoratori ad altissima specializzazione con retribuzioni in ascesa; dall’altra, mansioni precarie, facilmente sostituibili e sottopagate.
L’economia digitale rischia di creare una nuova classe di “inutili sociali”, persone escluse non per colpa o negligenza, ma perché semplicemente non “compatibili” con il nuovo sistema produttivo.
Una proposta: lavoro come bene comune
La vera sfida è dunque politica e culturale. Bisogna riconoscere il lavoro come bene comune, non come semplice fattore produttivo. Occorre ripensare il salario non solo in funzione del tempo impiegato o della produttività, ma come forma di riconoscimento della partecipazione sociale.
In questo, la dottrina sociale della Chiesa può fornire una guida: diritto a un lavoro stabile, giustamente retribuito, compatibile con la vita familiare; responsabilità dell’impresa verso la comunità; e centralità della persona rispetto al profitto.
La rivoluzione tecnologica non può essere lasciata al libero arbitrio dei mercati. Serve una governance pubblica dell’innovazione, che tuteli i lavoratori e redistribuisca i benefici dell’automazione. Come ha detto Papa Leone XIV: “Non basta saper fare: occorre sapere perché, per chi e a quale prezzo.”
Conclusione
Se vogliamo evitare che la settimana corta diventi un privilegio di pochi e che l’IA si trasformi in uno strumento di esclusione, occorre un cambio di paradigma. Serve una nuova alleanza tra Stato, impresa e società civile. Serve una nuova Rerum Novarum, che riconosca la centralità del lavoro nella costruzione di un ordine economico giusto e umano.
Solo così potremo rispondere alla domanda più urgente del nostro tempo: quale posto avrà l’uomo nel mondo che sta arrivando?
Nel new world dello share occorre tornare a riappropriarsi dei mezzi, anche del lavoro…essere proprietari del lavoro per evitare nuove tensioni sociali.