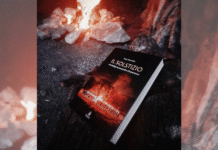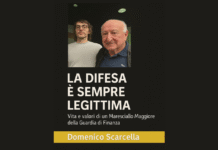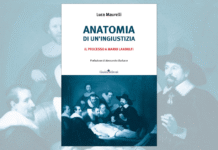Guerino Nuccio Bovalino viene intervistato da La Voce del Patriota.
Il professore accademico e scrittore di libri quali “Imagocrazia. Miti, immaginari e politiche del tempo presente” ci parla dell’Intelligenza Artificiale e della portata socio-antropologica di questo nuovo fenomeno, sempre più pervasivo nelle nostre vite. Come guardare all’IA? E come intenderla oggi e in futuro? Questi alcuni degli spunti che ritroveremo di seguito sui quali abbiamo riflettutto insieme al professore.
Quando nasce una nuova tecnologia cambia tutto l’ambito sociale. Perché la tecnologia crea un nuovo ambiente, delle trasformazioni antropologiche.” Questa è una frase che lei ha detto durante una delle sue ultime interviste. Oggi il cambiamento derivante dall’intelligenza artificiale è da intendere più come una rivoluzione o come una involuzione?
Il più importante studioso dei media è stato Marshall McLuhan. Il sociologo canadese intuisce già negli anni 60 che la televisione avrebbe trasfigurato il mondo. McLuhan con il concetto di villaggio globale evidenzia plasticamente la riconfigurazione dei concetti di spazio e tempo causata dal tubo catodico. Ancor di più, il sociologo giunge alla conclusione che ogni innovazione tecnologica determina la trasformazione di ogni ambito della vita. Finanche mutazioni antropologiche. La nuova tecnologia crea infatti un nuovo ambiente dentro cui l’uomo si ritrova improvvisamente ad abitare e da cui è condizionato nelle più intime modalità di esperire la vita. L’invenzione della stampa, la nascita del cinema, la televisione, Internet e oggi l’intelligenza artificiale, sono tecnologie che con il loro avvento hanno creato delle fratture nella storia dell’umanità, provocando dei cambiamenti epocali: la diffusione della cultura venne favorita dall’invenzione di Gutenberg, funzionando da elemento seminale per l’Umanesimo; il grande schermo contribuì alla propaganda dei totalitarismi del Novecento, moltiplicandone gli effetti persuasivi; la tv fu il medium che diede la percezione reale ai soggetti di essere parte di un contesto globale e interdipendente; le reti digitali hanno rimodulato i rapporti di potere, le relazioni umane e addirittura la nostra idea di soggettività e di identità. Anche l’IA trasformerà noi e il mondo che abitiamo, ma, essendo ancora immersi nella fase aurorale delle forme applicative della medesima, possiamo solo fare delle supposizioni sul suo sviluppo futuro e sulle conseguenze per l’uomo.
L’IA riproduce ragionamenti, meccanismi della mente umana. Quanto è labile il confine tra l’IA e l’uomo? E quanto è alta la possibilità che una mente non umana si sostituisca a quella propria dell’uomo?
A volte ciò che si prefigura come l’apocalisse finisce per essere, come l’etimologia del termine cela, solo una nuova rivelazione. Nel caso della IA, è forse solo l’annuncio di un nuovo mondo che impareremo ad abitare. In fin dei conti, l’IA è l’ennesimo prodotto dell’uomo. Una proiezione del suo genio. Il problema è che le potenzialità di tale tecnologia si immagina siano tali da poter sfuggire di mano. È una questione di potenza che si teme di non saper gestire. Quando nacque il cinema, durante la proiezione dei primi film, la gente aveva paura di quei fantasmi che abitavano lo schermo. Alcuni spettatori credevano che i treni potessero entrare nelle sale direttamente dalla superficie dove essi venivano proiettati. Quando la tv iniziò a diffondersi nelle case, i più anziani credevano che essa li potesse spiare nell’intimità attraverso il vetro dello schermo. Come ogni innovazione imponente, credo che anche l’AI non metterà in discussione la mente umana, ma provocherà delle trasformazioni profonde nella gestione di noi stessi e nella concezione della vita. Nessuna tecnologia potrà sostituire l’uomo, poiché la tecnologia è solo uno strumento, l’ennesimo, con cui ci illudiamo di farci piccoli dèi capaci di padroneggiare il mondo. L’IA ci faciliterà molte attività rendendo semplice il complesso. Ma di certo non ci renderà né divinità né schiavi delle macchine. “Il giorno della fine non ti servirà l’inglese”, cantava Battiato ne Il Re del Mondo. Non ci servirà neanche l’AI. Parafrasando il Maestro, nel momento del dolore nessuna tecnologia potrà saziare la nostra sete di assoluto, di eterno, di Dio. Di un Dio. Qualsiasi forma a esso ognuno di noi assegni e immagini per Lui. E la tecnologia si mostrerà ancora una volta per quello che è: un placebo che trasfigura ed eleva illusoriamente l’esistenza ma continuando a non dare le risposte alle nostre domande sul senso della vita, essendo la tecnologia solo un medium moltiplicatore di potenza privo di ogni afflato mistico capace di quietare lo spirito dell’uomo.

Considerando che l’IA sta avendo ripercussioni sempre più importanti sulla nostra quotidianità, ci sarà anche uno slittamento dei valori all’interno di questa nuova società in cui l’intelligenza artificiale è entrata a pieno titolo?
L’IA ricalca perfettamente, estremizzandoli, i valori della nostra società: velocità, efficienza, semplificazione, funzionalità. Essa porterà al livello successivo ed eccessivo tutto ciò che caratterizza l’attuale forma che definisco ultracapitalismo e che associa alla finalità del guadagno economico anche una dimensione inquietante di controllo iperstatalista.
È un capitalismo antilibertario costruito su un patto iniquo fra il singolo che elemosina illusioni social tecno-utopiche e le grandi aziende che gliele forniscono chiedendo in cambio di poter nutrirsi dell’intimità del soggetto sotto forma di dati, materia che usano per rendere più efficienti le loro macchine disumanizzanti. È un processo surreale per cui l’uomo cede alle aziende ciò che consente alle medesime di tenerlo sotto scacco. Ma, come nel film “Il Buono, il Brutto e il Cattivo”, c’è un cortocircuito. Nel film di Sergio Leone, il Cattivo pur avendolo catturato, non può uccidere Clint Eastwood, il Buono. Per recuperare una cassa piena d’oro nascosta in una tomba, al Cattivo non basta sapere il nome del cimitero. Gli serve infatti anche il nome del morto nella cui tomba il bottino è sotterrato. Ed è il Buono a saperlo, quel nome. C’è fra il Buono e il Cattivo una dipendenza. C’è una dipendenza anche fra ognuno di noi e coloro che stanno costruendo e alimentando un futuro postumano convinti di poter speculare sul medesimo. Gli sviluppatori dell’IA col tempo comprenderanno infatti che la tutela dell’uomo e dell’umano è l’obiettivo naturale e logico di uno strumento così potente come l’IA poiché se essa finisse per danneggiare l’uomo e l’umanità non avrebbe senso di esistere e di essere applicata.
Affrontiamo anche un altro aspetto, sotto una lente antropologica e relazionale. Abbiamo già sperimentato durante il Covid il crescente fenomeno per cui, soprattutto i ragazzi, si sono rinchiusi e hanno fondamentalmente deciso di non avere una vita sociale, il tragico fenomeno degli Hikikomori. Ora cosa accadrebbe se a creare legami, sebbene attraverso uno schermo, non fossero più le persone tra loro, ma se le persone andassero a costruire delle vere e proprie relazioni con una intelligenza artificiale. Dobbiamo aspettarci l’estinzione della società? O meglio, dell’umanità?
Notiamo un paradosso: tutti i grandi film di successo che hanno affrontato il tema della AI, ossia dei robot senzienti e degli androidi, hanno rappresentato una riproposizione del mito di Pinocchio. Terminator, Robocop, L’uomo bicentenario, il bambino di AI portato sullo schermo dal regista Spielberg ma ideato da Kubrick: sono tutte figure cinematografiche che, pur essendo ibridazioni fra l’umano e il tecnologico, prive delle fragilità insite nella condizione umana, finiscono per desiderare di diventare o tornare a essere “solamente” degli umani. Semplicemente uomini. Perfetti perché mortali, capaci di assaporare la vita perché non eterna. È come se l’uomo non fosse realmente in grado di immaginare qualcosa totalmente fuori dall’umano. Perché l’uomo conosce solo l’umano, e ad esso tende ed è destinato. È la “casa”. Perciò, proprio l’estremizzazione della virtualizzazione delle relazioni cui assistiamo, finirà per alimentare come reazione naturale un ritorno della dimensione carnale, dei sensi e del desiderio tattile dell’altro.

Invece per quanto riguarda le relazioni tra Stati? Si potrà ancora parlare di sovranità in termini territoriali o, più probabilmente, la partita si giocherà sul campo della “sovranità digitale”?
Noi stiamo vivendo già la moltiplicazione delle piattaforme esistenziali. Siamo soggetti riconducibili a uno Stato, che abitano piattaforme digitali, ambienti dentro cui ci muoviamo come cyber-cittadini. Siamo nomadi digitali che attraversano le varie Comunità presenti nei meandri della rete: facciamo compere fra le vetrine di Amazon, incontriamo amici su Instagram, diamo sfogo alle nostre voglie peccaminose su Pornhub e sulle webchat porno, ci confrontiamo con i colleghi su Linkedin. I social hanno addirittura un proprio immaginario politico di riferimento: le piattaforme di Zuckerberg vengono considerate liberal mentre Musk ha ripensato Twitter, oggi X, come una zona franca dalle follie del politicamente corretto. Trump con Truth si è addirittura costruito il proprio alter-mondo virtuale, la propria comunità tribale-digitale. Siamo destinati a essere soggetti con una propria appartenenza identitaria, nazionale e culturale ma contemporaneamente dislocati in pluri-versi di senso che ci (ri)-costituiscono come post-soggetti, mosaici composti da più tasselli esistenziali e virtuali. Ecco perché è così importante mantenere una costante identitaria che riesca a darci un equilibrio concreto dinanzi a tale inevitabile frammentazione delle esperienze e moltiplicazione identitaria, che è frutto del desiderio di soddisfare la voglia di perdersi nel magma indistinto dei metaversi digitali.
In conclusione: l’intelligenza artificiale è più opportunità o minaccia?
L’IA fa paura. È vero. Perché ne percepiamo la forza distruttiva, ma anche quella costruttiva, creatrice. Perché l’uomo non teme solo la sua fine, ma anche le trasformazioni epocali, profonde. L’IA prefigura però anche delle opportunità. Essa consentirà di misurare i parametri vitali a distanza aiutandoci ad affrontare una delle criticità del futuro: l’ageing. L’IA permetterà di compiere importanti passi avanti nel campo medico, dando la possibilità di operare utilizzando le tecnologie avanzate migliori e meno invasive, di farci scoprire nuove cure e di migliorare alcuni aspetti della disabilità. Con l’IA potremo visitare luoghi mai esistiti, avremo modo di stimolare la nostra curiosità e la nostra creatività, e renderà il lavoro meno duro. Molto dipenderà da come la utilizzeremo e verso quale direzione spingeremo l’innovazione tecnologica.
L’IA è ciò che l’uomo deciderà essa diventi. Con le proprie azioni e attraverso le politiche che le cucirà addosso.