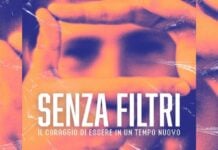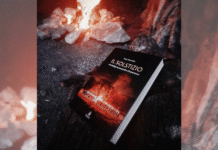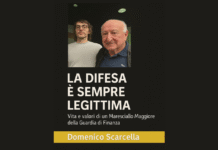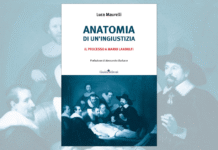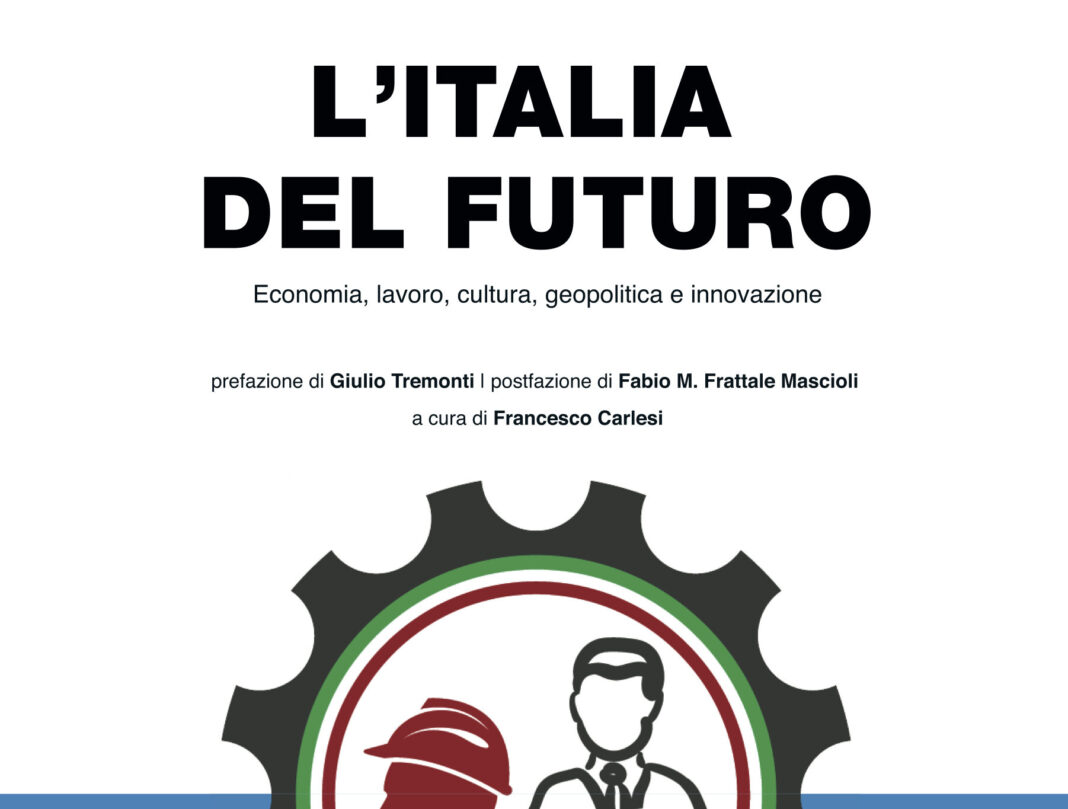di Andrea Scaraglino
Non sembra esserci risposta – o meglio – soluzione, alla domanda postaci da Cristopher Lasch nel suo «Il Paradiso in terra»: “Come può accadere che delle persone serie continuino a credere nel progresso?”. Lo storico americano fu forse troppo lapidario nell’impostare la sua domanda così perentoriamente, diciamo che se si proseguisse il quesito con un “fine a se stesso”, il discorso di fondo non risulterebbe stucchevole e soprattutto non si presterebbe alle sicure critiche del mondo positivista e liberal.
Ora, la domanda così composta risuona come un leitmotiv nella mente del lettore che si appresta a leggere i vari contributi che hanno dato alla luce il primo libro dell’Istituto Stato e Partecipazione. “L’Italia del Futuro” (Eclettica Edizioni), curato da Francesco Carlesi e con un’introduzione dell’ex ministro Giulio Tremonti, sembra darsi proprio questo compito. Fornire spunti e soluzioni per il futuro della Nazione ma con un approccio ciclico del tempo, andando, quindi, a ripescare nel nostro passato nazionale le soluzioni per le sfide del futuro e dismettendo, una buona volta, quel “processo generalmente in moto verso l’alto” che ci ha impedito di guardarci alle spalle.
Nel libro, ogni aspetto della vita nazionale viene sviscerato: economia, lavoro, cultura, politica estera e interna sono abbondantemente analizzati secondo canoni ben precisi. Oltre la già citata critica al progressismo in senso lato, un’altra caratteristica dei diciannove saggi che compongono il libro è la centralità che questi ultimi concedono alla visione comunitaria della società. Già nel primo capitolo a firma del succitato Carlesi si legge: “Disegniamo e sogniamo quindi una nuova rivoluzione culturale, che disarticoli l’anti-italianità che serpeggia nella magistratura, nei ministeri, nel mondo della cultura. Ravviviamo i nostri miti, indichiamo strategie a lungo termine e mete ambiziose: la libertà va conquistata sul campo e ha senso solo se è costruttiva e comunitaria, la libertà è un contenitore, non un contenuto.”
Un altro degli interventi che hanno colpito chi scrive è quello di Augusto Grandi inerente la filiera alimentare. Del resto, parlare d’Italia senza menzionare il cibo è impossibile oltre che stupido, a meno che non si sia un “fan dell’alimentazione alternativa”, ovvero un‘altra branca del progressismo di cui sopra, che ci ha portati sul l’orlo del baratro. La situazione del primo settore italiano è, si sa, drammatica. Stretta tra le imposizioni della grande distribuzione e la concorrenza sleale dell’estero, rischia di scomparire o di essere profondamente snaturata. Un pericolo quest’ultimo molto più che in divenire. Tristemente caratterizzato dallo sfruttamento della manodopera extracomunitaria e non, rappresenta una delle sfide maggiori che la Nazione si vede costretta a vincere per non scadere in logiche neo-colonialiste che striderebbero enormemente con la nostra tradizione sociale. Cosa fare, dunque? “È evidente che la grande distribuzione organizzata pretende produzioni standard con flussi constanti e quantità consistenti di merce. Dunque o ci si consorzia per fornire, tutti insieme, il prodotto richiesto e, con la forza dei numeri, si contrattano condizioni economiche accettabili, oppure si cercano circuiti alternativi.”
Continuando nella lettura del libro ci si imbatte in un altro saggio molto importante: quello a firma di Francesco Guarente. In questo caso la materia sindacale la fa da padrona, senza giri di parole il giovane sindacalista punta il dito contro la svendita dei diritti dei lavoratori. Una svendita che troppe volte ha visto anche le sigle sindacali sedute a tavoli indecorosi – La Camusso a pranzo con Monti – santificando scelte di deregolamentazione dei rapporti produttivi che hanno avvantaggiato solo il capitale.“La riforma dl lavoro varata dal governo Renzi, il già citato Job Act, ha depauperato il nostro sistema giuridico ed ha sostanzialmente fallito. In primis non è diminuita la disoccupazione, nonostante sia stato completamente svuotato il sistema delle tutele reali, allo stesso tempo non si è incentivata la stabilizzazione dei contratti di lavoro. I dati dell’osservatorio sul precariato dell’INPS hanno certificato un calo costante dei rapporti a tempo indeterminato dal 2015 al 2019, dai 2.007.449 al 1.341.614, in secondo luogo un aumento dei contratti di lavoro a termine del 27,3% […] sono aumentati dal 2016 al 2019 del 229% i contratti di lavoro a chiamata.” Anche in questo caso la scelta di campo è più che netta, difesa dei diritti dei lavoratori per rendere quest’ultimi “cittadini partecipi del destino dello Stato”, conditio sine qua non: ritorno alle condizioni di tutela reale del lavoro ante riforma Fornero e abrogazione del decreto legislativo 23/2015.
Altro saggio interessante è quello dedicato alla libertà di stampa. L’autrice Flaminia Camilletti descrive mirabilmente il servaggio di quest’ultima, ridotta a mero inchiostro sulla carta costituzionale e ostaggio di pochissimi gruppi editoriali collegati a tutt’altri interessi.“Come è possibile essere davvero indipendenti quando devi portare a casa lo stipendio? Ogni lavoratore ha nel proprio datore di lavoro, nei propri clienti, il proprio padrone. Il che può andar bene, ma per il giornalismo non dovrebbe essere così”. Il discorso è delicatissimo e molto articolato, rimane comunque un dato di fatto; la stampa italiana non è libera poiché lo Stato (attenzione, lo Stato e non il governo) non l’ha mai considerata una sua sfera di pertinenza. Regolamentare, dosare pubblico e privato rimane l’unica speranza per tornare a vedere l’informazione libera e al servizio della Nazione.
L’ultimo campo di interesse affrontato dal libro è quello della moneta. Di questa sezione, il saggio che risalta di più è sicuramente quello di Francesco Filini. L’autore tratteggia con dovizia di particolari la storia e l’evoluzione della moneta all’interno dei rapporti societari. Di evidente stampo Auritiano, il saggio ci domanda: “di chi dovrebbe essere la proprietà della moneta all’atto dell’emissione?”. Della banca centrale – ente privato – che ha pian piano spodestato gli Stati dall’emissione, o dei cittadini che gli danno valore accettandone il corso legale? Domande all’apparenza banali ma che sottintendono la prima e unica risposta per comprendere il motivo del declino occidentale: la perdita di sovranità da parte degli stati nazionali. Filini scrive: “Il monopolio della gestione della moneta e l’emissione a debito rappresentano il cuore delle distorsioni sociali del nostro tempo, sono questi gli strumenti che permettono alla vera casta – che è appunto quella bancaria e finanziaria – di dettare le regole del gioco, di stabilire il diritto di vita e di morte su famiglie, imprese e intera comunità nazionale. La loro è una tecnica sopraffina, collaudata e sperimentata nel corso dei secoli, con la quale espropriano la collettività di tutto ciò che essa stessa produce. La politica è la forza che dovrebbe contrastare questo processo, ma nei tempi drammatici dei giorni nostri è diventata la loro più fedele alleata.”
“L’Italia del futuro” è un testo importante, uno strumento per comprendere appieno lo storture del nostro tempo e per non subirle passivamente, un libro in cui è condensata molta della professionalità italiana che non si è voluta piegare a umilianti scelte deontologiche per meri calcoli carrieristici, una miscellanea di saggi “ispirati da una passione politica che è altrimenti ed altrove calante.”