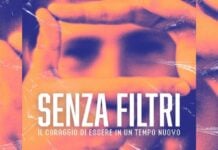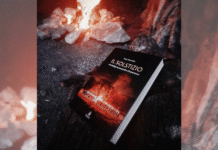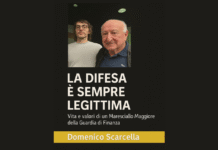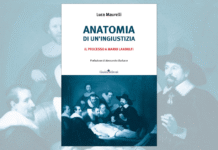La vittoria italiana per i giochi olimpici invernali del 2026 – assegnati a Milano e a Cortina con 44 voti a 37 nei confronti della Svezia – è un messaggio potente e influente che scavalca il vocìo, la vulgata sulla presunta “Italietta” e restituisce, invece, la dimensione naturale dell’Italia dinanzi alle sfide (quando giocate su un campo regolare e con le regole condivise) e agli incroci di destino internazionali.
Le espressioni festanti delle istituzioni a Losanna, così come quelle della piazza che a Milano attendeva la decisione del Comitato olimpico, imprimono nell’immaginario non solo una semplice (seppur importante) fotografia di unità ma una più profonda e alchemica sintesi nazionale: la concordia utilizzata come dispositivo per raggiungere uno scopo. Per Joseph Ernest Renan il senso della Nazione si riconosce proprio in queste forme di plebiscito, nell’«avere delle glorie comuni nel passato» e «una volontà comune nel presente»; nell’aver fatto «delle grandi cose insieme, volerne fare ancora…». La storia come un romanzo comunitario dunque, una volontà – prepolitica – che riecheggia familiare per la grammatica sovranista perché sostanza di un adagio missino, quello che voleva «la nazione in luogo della fazione».
Sì, è una vittoria della nazione e del suo sistema quella delle olimpiadi invernali in Italia: del comitato promotore, del governo nazionale e di quelli locali così come del progetto dell’evento, sul suo impatto territoriale, sociale e finanziario. Ma è anche una vittoria su una fazione, non indifferente, della società “politica” che per anni ha soffiato demagogia contro ogni grande evento così come ha fatto contro ogni grande opera od operazione che fosse.
È questo, si sa, il leit motiv decrescista del Movimento 5 Stelle che ha tuonato – a Roma come a Torino – contro le olimpiadi (invernali ed estive) sventolando la cantilena dei «grandi interessi», della «lobby del mattone» e degli sprechi. Uno stratagemma per giustificare la propria accidia dinanzi a un dossier che in tutto il mondo è considerato imprescindibile, non solo in termini finanziari e di visibilità ma proprio come strumento di soft power all’interno di un meccanismo multipolare in continua evoluzione.
Non poteva essere diversamente, del resto, dato che l’Italia immaginata da Di Maio, “Dibba” e Casaleggio è sostanzialmente una nazione “di servizio”, dedita per lo più al terziario (i precari assunti per cercare lavoro ad altri precari…), con l’Ilva magari trasformata in un «parco», come nella mente di Beppe Grillo. Una nazione dipendente dal punto di vista energetico, che vive il dibattito tecnologico non sul piano della concretezza e del realismo ma come una “terra promessa” proiettata in un tempo inafferrabile, con il presente gestito – lo dimostra il caos rifiuti a Roma – nel peggior modo del passato.
Una nazione così, a vocazione pessimista e atomizzata, è composta – come ha spiegato lo stesso Di Maio parlando dei suoi provvedimenti-manifesto – da tanti contratti sociali per tante “società” per loro natura necessariamente confliggenti. Non a caso già agli inizi del ‘900 Ferdinand Tönnies spiegava che la «concordia» poteva esprimersi solo dentro il vincolo comunitario, perché «mentre nella comunità gli esseri umani restano essenzialmente uniti nonostante i fattori che li separano, nella società restano essenzialmente separati nonostante i fattori che li uniscono».
Ecco dunque perché l’assegnazione olimpica all’Italia assume un valore cruciale e rivelatore proprio nel momento in cui le azioni “di disturbo” più che interessate tendono a minare la nostra credibilità internazionale. Continuare a cedere al minimalismo e all’autoflagellazione insomma, rifiutando a prescindere come condanna accessoria le sfide, è qualcosa di più di un atteggiamento antisportivo.
È il più anti-italiano degli autogoal.