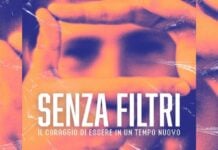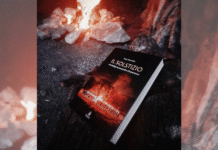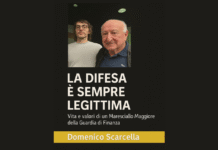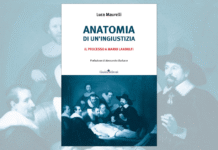di Enrico Petrucci
Per i tipi di GOG Edizioni è da poco disponibile il volume Oltre il reale che raccoglie cinque saggi monografici
dedicati a cinque grandi della letteratura fantastica: J.R.R.Tolkien, H.P.Lovecraft, A.Machen, G.Meyrink e
C.A.Smith. L’opera, che si presenta colta e divulgativa allo stesso tempo, si pone sia l’obiettivo di mostrare
come in questi autori il fantastico nasca come reazione ai limiti imposti da Positivismo e Razionalismo, sia di
ampliarne lo studio critico, che per il fantastico rimane spesso vincolato a una nicchia superspecializzata più
interessata agli aspetti narratologici e alla suddivisione del fantastico in sottogeneri spesso tralasciando il
quadro d’insieme dell’imperativo mitopoietico che accomuna questi autori.
Tolkien rappresenta una felice ma comunque parziale eccezione. Complice il successo costante e
trasversale negli anni, la saggistica e la critica hanno saputo avvicinare il grande pubblico agli elementi
costitutivi dell’opera tolkieniana ma resta un autore incasellato nella letteratura fantastica e quindi
inevitabilmente relegato nel mondo della “letteratura di genere” sempre guardata con sospetto (quando
non disprezzo) dai gatekeeper della “cultura alta”.
E gli stessi appassionati del fantastico e della fantascienza talvolta dimenticano che le considerazioni
simboliche e mitopoietiche che vengono fatte per Tolkien e, in misura minore per Lovecraft e Meyrink,
possono essere estese a molti altri autori “di genere” che nel creare nuovi mondi letterari si sono cimentati
con mitopoiesi e allegoria.
Il volume curato da Lorenzo Pennacchi contribuisce a spazzare via i preconcetti nei confronti della
letteratura di genere dimostrando come l’imperativo di andare Oltre il reale fosse una necessità comune di
andare oltre Positivismo e Razionalismo.
Il presupposto metodologico di Oltre il Reale è nell’individuare cinque autori di narrativa fantastica a cavallo
tra Ottocento e Novecento (i cinque sono nati tutti nell’Ottocento, ma attivi nei primi anni del XX secolo
con la parziale eccezione di Machen attivo già alla fine del secolo) e mostrare come la loro scelta di
dedicarsi alla letteratura dell’immaginario, pur se con generi e stili molto diversi, sia stata una precisa
reazione alla comprensione dei limiti del proprio tempo.
Insoddisfatti dallo zeitgeist questi autori si cimentano col creare e declinare nuovi mondi secondo le proprie
sensibilità. Andrea Scarabelli mostra come Lovecraft fosse un grande appassionato di scienza, chimica e
astronomia in primis, e che la sua cosmogonia orrorifica e caotica nasca proprio dalla comprensione dei
limiti della scienza a fornire una spiegazione razionale dell’uomo e dell’universo. Francesco Lo Manno
racconta come C.A.Smith porti all’estrema conseguenza il decandetismo baudelairiano (di C.Baudelaire
Smith fu anche traduttore) come critica alla modernità. Pur pubblicando sulla stessa rivista che ospitava
Robert E.Howard (classe 1906) e Lovecraft la visione di Smith fu quella di raccontare di civiltà fantastiche
arrivate alla naturale consunzione e in cui anche per i protagonisti diventa impossibile sfuggire all’anelito
autodistruttivo. Tra le molteplici prospettive che ci può offrire Tolkien Lorenzo Pennacchi sceglie la via
dell’ecologismo come contestazione alla modernità industriale.
 Per Machen, raccontato da Marco Maculotti, la chiave è invece la riscoperta del mito e del folklore della
Per Machen, raccontato da Marco Maculotti, la chiave è invece la riscoperta del mito e del folklore della
propria terra, una tradizione sovrannaturale ancestrale che si oppone alla dea Ragione illuminista. Sebbene
Machen nella sua letteratura horror la declini generalmente in negativo, vale la pena ricordare che fu
proprio lo scrittore britannico, corrispondente di guerra, a creare nel 1914 la leggenda degli Angeli di Mons
che avrebbero salvato il corpo di battaglia britannico dalle preponderanti forze britanniche. Angeli che
nell’intenzione del’autore erano gli spiriti degli arcieri inglesi caduti cinque secoli prima nella battaglia di
Agincourt nel 1415.
Nel saggio su Meyrink Roberto Cecchetti mostra l’autore viennese nella sua cifra esoterico-alchemica, alla
luce di Evola, che portò Meyrink al pubblico italiano, e delle opere di Carl Gustav Jung, che citò Meyrink in
diversi scritti.
A conclusione dell’opera il saggio di Adriano Monti Buzzetti dal titolo Oltre il reale: la letteratura fantastica
tra magia e modernità come ulteriore raccordo teso a ribadire come il fantastico sia «corale e fisiologica
reazione emotiva anzitutto alle nuove liturgie positiviste del Secolo dei Lumi e della nascente Rivoluzione
industriale».
In conclusione Oltre il Reale è un testo determinante nel portare a un pubblico più ampio la critica
specializzata della letteratura fantastica mostrando al contempo come l’imperativo mitopoietico di autori,
vicini nel tempo ma diversissimi come stile, nasca dalla volontà comune di restituire all’uomo la sua
dimensione mitica in tempi in cui questa era negata.