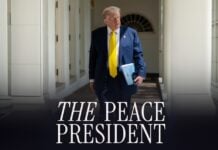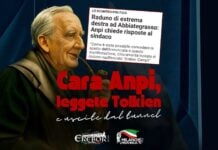Come promesso, torniamo al binomio fascismo-comunismo, per capire se sia giusto o no che entrambi vengano rifiutati e respinti in blocco o se, invece, sia lecito chiedere solo patenti di antifascismo (o di anticomunismo).
Di chiacchiere se ne sentono tante e molte provengono da fonti autorevoli delle quali non si può non pensare che conoscano ciò di cui si sta parlando: esiste, tuttavia, un solo luogo fisico al mondo visitando il quale è possibile, anche per i più sprovveduti, toccare con mano la sostanza dei due opposti estremismi politici che hanno caratterizzato il secolo scorso, suscitando ondate di adorazione fanatica alternate a risacche di opposizione sanguinosa.
Non sto parlando di luoghi della memoria, tipo lager o sacrari sparsi un po’ per tutta Europa: sto parlando dell’unico luogo al mondo, l’unico in assoluto nel quale l’equiparazione nazifascismo-comunismo sia non simbolica, ma tangibile, monolitica, priva di sottigliezze ideologiche, e soprattutto terribilmente “storica”: in altre parole, totale e percepibile coi cinque sensi, prima ancora che con l’intelletto e del tutto estranea a qualsiasi negazione reciproca di legittimità.
Questo posto si trova in Andrassy Boulevard, nel centro di Budapest, capitale dell’Ungheria: la sua denominazione è tutto un programma; si chiama Terror Haza Museum, cioè Museo della Casa del Terrore, eufemisticamente soprannominato La Casa della Lealtà. Come avrete intuito, si tratta di un museo dedicato alla storia tormentata dell’Ungheria, ma la sua caratteristica principale consiste nel fatto di essere stato allestito negli stessi appartamenti che avevano ospitato, prima, la sede centrale del Partito Nazista Ungherese (le cosiddette Croci Frecciate), e poi quella del Partito Comunista. L’appellativo di Casa della Lealtà le fu dato dai nazisti ma siccome si prestava perfettamente alla faccia opposta della medaglia, le fu lasciato dai comunisti.
Qualche anno fa, ho pubblicato con Aracne un saggio dal titolo, appunto, “La Casa della Lealtà”: si tratta, in sostanza, di una guida commentata ai vari saloni del museo in ciascuno dei quali sono esposti i cimeli materiali relativi ad entrambi i periodi vissuti dalla struttura, quello delle Croci Frecciate naziste e quello della dominazione comunista durante la quale Andrassy Boulevard ospitò, tra l’altro anche il Tribunale Speciale destinato a giudicare i “crimini” anticomunisti. Alcune sale ospitano cimeli comuni ai due estremismi e molto cari ad entrambi: nel seminterrato, ad esempio, ci sono le celle destinate ad accogliere i prigionieri politici in attesa dell’interrogatorio, della tortura o dell’esecuzione capitale e ci sono anche, in locali attigui, gli strumenti di interrogatorio forniti di cavi elettrici, punzoni ed altre piacevolezze destinate a sollecitare confidenza memoria nei prigionieri.
In questi locali, per un soprassalto di pietosa discrezione, è vietato fotografare e così, tra le illustrazioni del mio saggio, ho dovuto inserire, oltre alle foto degli ambienti neutri dal punto di vista della malvagità umana, alcuni disegni da me eseguiti, riproducenti gli strumenti di tortura e un capestro per l’impiccagione dalla forma piuttosto insolita.
Questi strumenti non riconoscono alcuna paternità politica specifica perché furono usati prima dagli aguzzini nazisti, poi da quelli comunisti, per cui l’impressione finale, quando si esce dal museo, è quella di aver ricevuto una martellata violenta in testa le cui conseguenze prescindono completamente dalla fede politica di chi l’abbia sferrata. Dopo un’ultima occhiata all’aula del Tribunale Speciale spacciata per un archivio tramite una tappezzeria riproducente le coste di falsi faldoni inseriti negli scaffali, si torna finalmente fuori, ripassando davanti al carro armato sovietico posto a guardia dell’ingresso in mezzo alla simulazione di un enorme lago di sangue.
E solo a questo punto ci rendiamo conto di una cosa strana: di fronte all’ingresso del museo, si erge un grosso palazzo in stile fine ottocento: potrebbero essere uffici statali o abitazioni di pregio, ma si tratta soltanto di uno spettro: del vecchio palazzo sopravvive solo l’involucro esterno, una parete di cinque piani costellata di finestre prive di infissi, alternate a buche sbrecciate aperte dai colpi di cannone dei carri armati comunisti che spararono in pieno centro contro una popolazione pressoché inerme, durante la rivolta antisovietica del 1956.
Di questa ricordo soltanto le immagini sfocate alla televisione in bianco e nero e la disperazione di mia madre che chiedeva a mio padre per quale motivo nessuno alzasse un dito in difesa del popolo ungherese.
Una domanda rimasta tuttora priva di risposta.