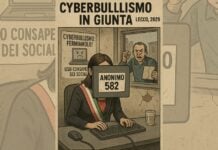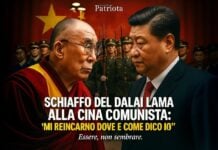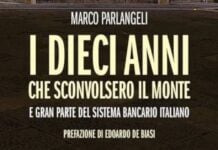Il 2024, tra poche ore, volge al termine. Tirando le somme si può dire senza timor di smentita che è stato un anno che ha segnato l’inizio di un nuovo ciclo politico a Bruxelles, con le elezioni europee del 9 giugno e le conseguenti nomine dei vertici Ue, nonché con l’entrata in carica del nuovo segretario generale della Nato dal 1° ottobre. Sullo sfondo del conflitto ucraino, che è entrato nel suo terzo anno, e di quello in Medioriente, con l’invasione israeliana di Gaza e gli attacchi in Libano, si sono aggiunte nuove sfide: la caduta del regime di Assad in Siria e la crisi politica in Georgia.
L’elezione di Donald Trump in Usa è l’elefante nella stanza per il Vecchio continente, che dovrà definire il suo futuro sulla scena globale e in rapporto al partner transatlantico.
La gestione comune del fenomeno migratorio con regole più stringenti invocate dagli Stati membri, la perdita di competitività, l’attuazione del Green Deal con l’appello del settore auto a rivedere il passaggio all’elettrico sono altri nodi che l’Ue sta cercando di sbrogliare. Le elezioni europee hanno riconfigurato il Parlamento, con uno spostamento verso destra. Il Partito popolare europeo (Ppe) ha mantenuto la posizione di primo gruppo, seguito dai Socialisti e Democratici (S&D). I gruppi di destra, Conservatori e Riformisti Europei (Ecr) e Identità e Democrazia (Id), quest’ultimo disciolto nel nuovo raggruppamento ‘Patrioti per l’Europa’, hanno registrato una crescita significativa.
Il 27 giugno i capi di Stato e di governo riuniti nel Consiglio europeo hanno trovato un accordo sulle nomine delle tre massime cariche Ue. I negoziatori delle tre famiglie politiche che compongono la maggioranza uscente hanno concordato il pacchetto di nomi per i cosiddetti ‘top job’: la popolare Ursula von der Leyen resta al suo posto alla guida della Commissione europea, il socialista portoghese Antonio Costa diventa presidente del Consiglio europeo e la liberale estone Kaja Kallas Alta rappresentante per la politica estera.
Il 18 luglio il Parlamento europeo conferma la nomina di von der Leyen, con 401 sì (su una soglia di maggioranza di 360 seggi). La votano anche i Verdi europei, assieme a popolari, liberali e socialisti. Tra gli italiani si esprimono a favore Forza Italia, il Pd e i Verdi, mentre Lega, FdI, SI e M5s hanno votato contro. La seconda Commissione targata von der Leyen passa per la fiducia del 27 novembre, con il voto di fiducia a Strasburgo che questa volta ha visto 370 favorevoli su 688 votanti, una maggioranza risicata che ha messo in luce le tensioni interne alla coalizione di maggioranza. Decisivo è stato il ruolo di Fratelli d’Italia, il cui appoggio ha compensati le defezioni all’interno del Partito popolare europeo e il venir meno del supporto dei Verdi. Il nuovo ciclo politico della Commissione europea è iniziato ufficialmente il 1° dicembre.
Von der Leyen ha annunciato un ambizioso programma di riforme e misure nei primi 100 giorni. In casa Nato, il 1° ottobre ha visto un cambio di leadership con l’ingresso di Mark Rutte, ex premier olandese, che ha sostituito Jens Stoltenberg come segretario generale.
Il 6 novembre invece Bruxelles si è risvegliata con lo shock del voto Usa. La rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca ha scosso l’Unione europea, costringendo i leader di Bruxelles a prepararsi per un periodo di incertezza e possibili cambiamenti nelle relazioni transatlantiche. I giorni che separano dall’insediamento, il 20 gennaio, del nuovo inquilino alla Casa Bianca sono segnati da incertezza e smarrimento. L’Europa vorrebbe fare da sola, aumentare la sua autonomia strategica ed ergersi a potenza mondiale autonoma. L’annuncio di possibili dazi Usa potrebbero aprire a una guerra commerciale dannosa anche per gli Stati Uniti. Non a caso von der Leyen ha accelerato, dopo 25 anni di negoziati e una prima intesa nel 2019, sulla chiusura dell’accordo di libero scambio con i paesi del Mercosur.
Sul fronte militare, invece, l’Ue non può emanciparsi dalla sponda transatlantica: gli Usa contribuiscono per oltre i due terzi alle spese per la Nato. Trump intende spingere gli alleati a spendere di più, e vorrebbe portare il presidente russo Vladimir Putin a negoziare per fermare la guerra in Ucraina, ma non si sa a quali condizioni. Il presidente Volodymyr Zelensky non nasconde i timori e le difficoltà sul campo e sulla tenuta della sua opinione pubblica, a quasi tre anni dall’inizio dell’occupazione. Si dice fiducioso in Trump, ma insiste sul fatto che nessun congelamento della guerra metterà al sicuro Kiev da Mosca, e nemmeno le garanzie di sicurezza dei singoli alleati occidentali: solo l’ingresso nella Nato, è il suo messaggio. Anche se dall’inizio dell’invasione russa l’Unione europea ha fornito all’Ucraina sostegno economico, umanitario e militare per oltre 88 miliardi di euro, l’exit strategy della guerra con la Russia sembra lontana dal poter essere decisa a Bruxelles.