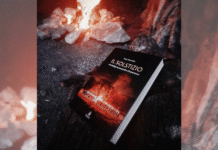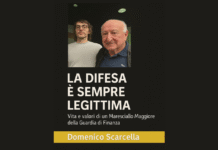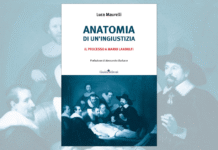In queste ore la capitale d’Italia è chiamata al voto per il ballottaggio tra i due principali candidati alla carica di Sindaco. Che negli ultimi anni Roma sia divenuta “nave sanza nocchiero in gran tempesta” è sotto gli occhi di tutti. Il degrado del paesaggio urbano, il dramma della gestione dei rifiuti, l’insufficienza dei trasporti, le strade fatiscenti e la carenza di infrastrutture hanno peggiorato la qualità della vita di chi vi abita e pregiudicato l’autostima di una Città Eterna ma mai così depressa e rassegnata.
Roma è ancora la capitale d’Italia? Milano rinasce con l’Expo e le Olimpiadi invernali e Roma rinuncia a ogni candidatura; il prossimo Eurovision Song Contest sarà ospitato da Torino, dopo la clamorosa bocciatura ottenuta dall’amministrazione Raggi.
E a proposito dei grandi eventi: Roma sarà in grado di ospitare il prossimo Giubileo del 2025? Riuscirà ad aggiudicarsi l’Expo 2030? Le risposte si avranno, almeno in parte, anche dai risultati delle amministrative.
Ma intanto, in attesa del futuro, Roma deve guardare al passato. E nell’oblio generale, quest’anno si celebra un compleanno speciale: i 150 anni di Roma capitale d’Italia.
La Città Eterna diviene capitale di quel che fu il Regno d’Italia con la legge n. 33 del 3 febbraio 1871. Come è noto, il 17 marzo 1861 il Regno di Sardegna cessò di esistere e nacque il Regno d’Italia che comprendeva i vecchi territori del Regno sabaudo e quelli conquistati con la Seconda Guerra d’Indipendenza e la spedizione dei Mille di Garibaldi. Tra questi territori, però, non figurava Roma che rimase per un altro decennio parte dello Stato pontificio.
La prima capitale d’Italia fu Torino. Nel settembre del 1864 la capitale fu spostata a Firenze, a seguito della Convenzione siglata tra il governo Minghetti e la Francia che ne chiedeva il trasferimento come rinuncia definitiva da parte del Regno italiano all’annessione di Roma.
Ma che l’Italia non volesse che quest’ultima come capitale era chiarissimo sin dal famoso discorso pronunciato da Cavour alla Camera dei Deputati il 25 marzo del 1861: «Ora, o signori, in Roma concorrono tutte le circostanze storiche intellettuali, morali, che devono determinare le condizioni della capitale di un grande Stato. Roma è la sola città d’Italia che non abbia memorie esclusivamente municipali; tutta la storia di Roma […] è la storia di una città la cui importanza di estende infinitamente al di là del suo territorio, di una città, cioè destinata ad essere capitale di un grande Stato. […] Ho detto, o signori, e affermo ancora una volta che Roma, Roma sola deve essere la capitale d’Italia.»
Al di là della giurisprudenza o di qualche residuato simbolico, della vecchia Urbe rimane oggi quel senso di “universalità” che il cristianesimo ha saputo riprogrammare sulla frequenza spirituale del Vangelo testimoniato proprio qui, in prossimità dei Fori e delle vie consolari, dalla Chiesa e dai suoi martiri.
«Urbem fecisti quod prius orbis erat», «hai fatto del mondo una città», scrisse di Roma Rutilio Namaziano, poeta del V secolo, esaltandone la grandiosità pubblica. Ed è un po’ questo il segreto della sua “eternità”, il suo farsi mondo nell’umanità radicale di ogni persona e ogni comunità.
“Capitale dell’universo”, dal 1871 Roma è anche capitale d’Italia della quale da subito ha sopportato l’onere dell’unificazione. Ha intrapreso il cammino di una modernizzazione che altre capitali europee avevano conosciuto diversi secoli prima, e con ben altro amor patrio, ma ha perduto, progressivamente, la sua identità locale, i suoi umori popolari, il suo volto aristocratico, feudale e papalino. Ha offerto ospitalità e lavoro a mezza Italia, inserendo nelle burocrazie statali notabili e proletari del Meridione, tecnici e i professionisti del Settentrione, ma non ha saputo svilupparsi secondo un modello urbanistico coerente e rispettoso della sua “anima” particolare. Meta di pellegrini, forestieri e turisti di ogni angolo del pianeta, il centro storico è divenuto nel tempo un loro “ostaggio”, assaltato dagli avventori di grandi e piccoli esercizi commerciali che ne hanno sfigurato il paesaggio. Sede delle principali istituzioni italiane che hanno allontanato la cittadinanza nelle zone residenziali periferiche o extraurbane, il centro storico è sempre più abbandonato a se stesso.
“Roma sparita”, “Roma scomparsa”, ogni giorno si moltiplicano coraggiose iniziative di promozione, rilancio e rievocazione di un mondo in fondo ignorato e maltrattato da molti, dai più, residenti compresi, che di Roma rispettano a malapena il proprio “orticello”.
Il romano di sette generazioni, pure, è scomparso. Sicuramente sopravvive nella comunità ebraica più antica d’Europa, tra il Portico d’Ottavia e le piccole aree del commercio e della cultura “giudìa”, pienamente radicate, dopo secoli di discriminazioni, nel tessuto sociale capitolino. Ma il sentimento della romanità è oggi prodotto di nicchia, esercitazione accademica, roba d’antiquariato o da Cinecittà.
Nonostante tutto, la città fondata da Romolo è ancora “caput mundi”, capitale storica del cristianesimo universale, tradizione spirituale e cultura vive, capaci di parlare alle coscienze di un mondo sempre più insicuro e bisognoso di speranza. Le Settimane Sante e le feste romane richiamano sempre pellegrini da ogni dove e questo conferma che la capitale d’Italia rimane “città aperta”, alla fede e alla civiltà umana.
Ma se Roma unisce il mondo, se il suo Cupolone e i fasti dell’Urbe antica attirano persone dai cinque continenti, anche l’Italia non deve dimenticare che le sue storiche divisioni possono e devono essere pacificate nel comune orgoglio della Città Eterna.