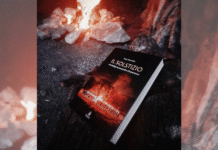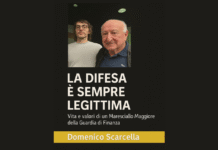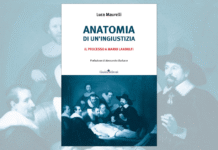di Massimiliano Scorrano
Prologo
La produzione scientifica dominante è concorde nel sostenere che il merito creditizio degli Stati sia esclusivamente verificabile dal rapporto Debito/PIL. Sostenere semplicemente che un maggior indebitamento sia deleterio può essere vero ma non sufficiente, questo perché, genericamente, tutti siamo consapevoli che questo sistema prevede l’indebitamento per la crescita del PIL. Gli Stati, tutti, hanno necessità di investire gli impieghi acquisiti dalle fonti per realizzare i propri piani di spesa; tradotto, tutti gli Stati, nessuno escluso, hanno necessità di fare debito, tramite l’emissione di TDS, per ottenere i mezzi finanziari da impiegare affinché si dia seguito alle politiche fiscali intraprese. Dire semplicemente che solo un maggior debito pubblico sia causa, e non anche concausa, del rallentamento crea gli spread in quanto induce tutti a rivolgere l’attenzione sul debito e non sulla potenziale profittabilità ottenuta grazie a quel indebitamento. Ma quel è il limite massimo dell’indebitamento?
è qui disponibile la Parte2: https://www.lavocedelpatriota.it/il-limite-dellindebitamento-r-o-t-a-vs-moltiplicatore-fiscale-2/
____________________
PARTE3
Ma torniamo alla pubblicazione dell’Osservatorio C.P.I. La trattazione continua con Galli che affronta il famoso “divorzio dell’ottantuno”. Ne abbiamo parlato prima ma è utile rivedere alcuni dati in esso riportati. Anche in questa sede si continua a sostenere, senza dire o sapere quale sia il limite di indebitamento sostenibile, che il debito è stato generato a partire dal 1975 grazie a deficit primario, ossia spese finanziate a deficit al netto degli interessi sul debito stesso. Ci permettiamo di ribadire in questa sede che il processo del “divorzio” non ebbe inizio nel 1981 ma da qualche anno prima. Se pur i dati siano inconfutabili e condivisibili la ragione di questa presa di posizione è ben spiegata da quello che rispose in un’intervista rilasciata al Sole24Ore da Andreatta: “La soluzione classica al problema dell’inflazione sarebbe stata quella di una stretta del credito, accompagnata da una stretta fiscale ma avrebbe creato una recessione con la caduta di alcuni punti del Pil, come era accaduto nel 1975. L’imperativo era quindi quello di cambiare il regime della politica economica, che è qualcosa di più e di diverso dal cambiare la politica economica. Facendo queste proposte era mia intenzione drammatizzare la separazione fra Banca d’Italia e Tesoro per operare una disinflazione meno cruenta in termini di occupazione e di produzione, sostenuta dalla maggiore credibilità dell’istituto di emissione una volta che esso fosse liberato dalla funzione di banchiere del Tesoro.”
Quindi l’operazione serviva per dare credibilità alle azioni intraprese. Alla base vi sono sempre scelte politiche ed in quel caso si decise che andavano cambiate alcune cose nel nome dei “mercati” che dovevano acquisire fiducia verso il sistema Italia. Come abbiamo detto in precedenza, chi teme l’inflazione, la tassa da inflazione, sono quei soggetti che non hanno possibilità di adeguare i propri redditi al costo della vita reale ed anche i mercati finanziari che non amano vedersi depauperare gli investimenti in modo sostenuto. Infatti l’inflazione trasferisce le risorse dai creditori ai debitori. Fu una scelta di politica economica perché occorreva scrollarsi di dosso la sensazione che la Lira, con le sue svalutazioni, creasse un clima di incertezza. Tali concetti sono stati semplicemente travasati nei compiti della B.C.E. Termina il paragrafo con l’interrogativo concernente ancora il problema irrisolto del debito pubblico che aumenta e non si arresta. Siamo anche qui a porre di nuovo la stessa domanda: quale dovrebbe essere il limite dell’indebitamento?
Stante la situazione attuale, è assodato che per aumentare il PIL occorra aumentare il debito e che quando parliamo di debito non bisogna riferirsi al solo debito pubblico. Riassumendo brevemente il lavoro svolto dall’Osservatorio C.P.I. si evince che:
- non è stato fissato, con assoluta certezza, il limite massimo di indebitamento;
- non è stato definito il giusto mix tra debito privato e debito pubblico;
- il moltiplicatore fiscale non è infallibile;
- un maggior debito, per effetto degli interessi passivi su quel debito, incide negativamente sulla crescita di ricchezza rallentandola;
- stati con il più alto PIL sono anche quelli maggiormente indebitati;
- gli studi effettuati sull’Europa a 12 hanno condotto ad un risultato non applicabile a tutti gli Stati ma ha solo evidenziato delle medie di risultati degli Stati presi in esame;
- gli Stati analizzati hanno confermato tendenze differenti in base alla politiche fiscali adottati singolarmente.
I risultati degli studi condotti non possono essere negati, certamente, ma il fatto che non si riesca a percepire “la” soluzione anziché “una” generica soluzione, non contribuisce certamente alla determinazione del problema. Dire semplicemente che un maggior indebitamento sia deleterio può essere vero ma non sufficiente, questo perché, genericamente, tutti siamo consapevoli che questo sistema prevede l’indebitamento per la crescita del PIL. Gli Stati, tutti, hanno necessità di investire gli impieghi acquisiti dalle fonti per realizzare i propri piani di spesa; tradotto, tutti gli Stati, nessuno escluso, hanno necessità di fare debito, tramite l’emissione di TDS, per ottenere i mezzi finanziari da impiegare affinché si dia seguito alle politiche fiscali intraprese. Dire semplicemente che solo un maggior debito pubblico sia causa, e non anche concausa, del rallentamento crea gli spread in quanto induce tutti a rivolgere l’attenzione sul debito e non sulla potenziale profittabilità ottenuta grazie a quel indebitamento. Profittabilità è un termine mutuato dall’economia aziendale ma noi tutti sappiamo che adottare questo termine per spiegare le politiche fiscali degli Stati potrebbe essere inappropriato; lo Stato non è un imprenditore, o meglio, lo scopo di uno Stato non è quello di fare l’imprenditore ma quello di erogare ed amministrare principalmente i servizi non acquistabili sul mercato.
Lo è un bene non acquisibile sul mercato, per esempio, la pubblica sicurezza, l’amministrazione della giustizia, il funzionamento dell’apparato centrale dello Stato. Certo, alcune funzioni potrebbero essere esternalizzate ed acquisite sul mercato ma quelle strategiche no. Resta inteso che stiamo facendo riferimento a stati democratici che non adottano sistemi comunisti dove non esiste la proprietà privata. Poi è anche vero che gli Stati possano detenere quote di partecipazioni in aziende produttive come quote in società di gestione aeroportuali, di gestione delle acque, di smaltimento rifiuti. Del resto anche i servizi sanitari prevedono la coesistenza del pubblico e del privato al contempo, ma buona parte della spesa pubblica afferisce a servizi non acquisibili sul mercato. Il debito contratto per far fronte a questi piani di spesa “improduttiva” è costo che non produce reddito per se stesso ma servizi erogabili ai fini della redistribuzione della ricchezza sotto forma, appunto, di servizi e non a scopo di lucro. Le spese di uno Stato, per loro natura, non producono valore aggiunto; possono solo generare perdite (ci riferiamo a perdite economiche, non certo all’arricchimento sociale) e queste perdite vengono sostenute dalle entrate fiscali, dalle alienazioni dei beni dello Stato, dal ricorso al finanziamento tramite l’emissione di T.D.S., tutte variamente mixate.
Ed è anche errato pensare che solo grazie alla spesa pubblica si ottenga maggior P.I.L. In nessun testo di economia troveremo mai l’identità G ≡ Y; è errato e totalmente fuorviante pensare o far credere che non ci possa essere reddito senza la spesa pubblica o che in assenza di spesa pubblica non ci sia l’attività di impresa. Di conseguenza è fuorviante asserire che il solo eccessivo debito pubblico sia la causa della depressione di un sistema economico produttivo. La conseguenza è che potrebbe essere limitativo sostenere di poter misurare la salute di un intero sistema produttivo con il rapporto Debito/PIL perché, se è vero che maggior debito equivale a maggior interessi passivi e che maggior interessi passivi equivale a minori disponibilità da investire a causa del prelievo fiscale è anche vero che migliori performance contribuiscono ad assorbire gli effetti negativi degli interessi passivi ma soprattutto nell’ottica che, in questa fase, non è possibile ottenere strumenti monetari se non ricorrendo all’indebitamento e tali strumenti monetari devono essere impiegati nella produzione; in pratica non può esistere produzione se non si ricorre al capitale di terzi.
Appuntamento a sabato prossimo con la pubblicazione della quarta parte dell’articolo.
(https://www.lavocedelpatriota.it/il-limite-dellindebitamento-r-o-t-a-vs-moltiplicatore-fiscale-4/)
02/05/2020, Massimiliano Scorrano