Nei giorni scorsi ci ha preceduto Maria Romana De Gasperi, primogenita di Alcide. La notizia della sua morte è stata ampiamente trascurata dai media italiani, nonostante la prima delle quattro figlie dello statista trentino sia stata una donna profondamente italiana, di grande cultura civile e politica. A lei si devono eccellenti iniziative dedicate alla memoria del padre e del suo ruolo nazionale e internazionale, indispensabile per la rinascita dell’Italia del secondo dopoguerra e per la promozione di una politica estera e di difesa europea.
Correva l’anno 1954 quando De Gasperi vide svanire il sogno della CED, il grande progetto di una “Comunità Europea di Difesa”. Non poche sono le analogie tra quel contesto storico e il nostro. L’orologio della storia sembra essere tornato indietro e la “nuova guerra fredda” assomiglia molto, troppo, a quei tempi che di lì a poco avrebbero portato alla cortina di ferro, al Muro e alla minaccia atomica.
E in effetti agli anni ‘50 bisogna tornare per rilevare il primo progetto di un esercito europeo e di una politica di difesa comune. Il contesto continentale era segnato dalla Guerra Fredda e dai problemi relativi alla linea difensiva da tracciare contro una temuta invasione sovietica. All’epoca c’era stato l’episodio della Guerra di Corea.
Allora come oggi, l’Europa era profondamente divisa. C’era oltretutto l’aggravante del controllo della Repubblica Federale tedesca, della quale si doveva evitare il riarmo generalizzato e l’eventuale ripresa di spinte egemoniche. E in quello scenario, la Nato, l’organizzazione militare euro-atlantica nata a scopo difensivo, fungeva da “vigile urbano” e garante militare in caso di offensiva russa. Le cose, a quanto pare, non sono cambiate.
La CED doveva rispondere all’esigenza politico-strategica di attivare un meccanismo di difesa dell’Europa (allora soltanto) occidentale dalla minaccia sovietica, nell’ottica di un riarmo progressivo e nella logica di un impegno condiviso con gli americani che avrebbero disposto un distaccamento di forze permanenti sul continente europeo. Gli americani aumentarono in modo consistente la loro presenza militare, nel quadro di una forza alleata integrata di cui avrebbero assunto il comando – inevitabilmente: troppo grande era il divario politico, militare ed economico con gli Stati del Vecchio Continente – ma gli europei dovevano accettare la partecipazione alle forze integrate di dieci divisioni della Germania federale. Il primo ministro francese René Pleven propose un piano che prese il suo nome: in sostanza, si applicava il modello della comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) alla difesa comune europea. E anche qui, il parallelo tra armi e risorse energetiche, è ancora tremendamente attuale.
La CED fallì nel 1954 quando l’assemblea nazionale francese respinse l’approvazione della versione finale del trattato. Un mese dopo, il tema della difesa comune europea fu ripreso con l’ampliamento del Patto di Bruxelles, stretto nel 1948 da Regno Unito, Francia e Benelux (Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo): nacque l’”Unione Europea Occidentale” (UEO), organizzazione a cui aderirono subito anche Italia e Repubblica Federale tedesca.
Arrivarono poi i Trattati di Roma del 1957, la nascita della “Comunità Economica Europea” (CEE) e la CEEA (“Comunità Europea dell’Energia Atomica”) nuclei fondanti del grande mercato comune. La CEEA vedeva impegnati gli Stati nella condivisione di professionisti, di programmi, di investimenti in ricerca. Sembrava il primo passo per una vera integrazione, che da economica poteva aspirare a divenire pienamente politica.
Ma così non fu. E da Maastricht a Lisbona, passando per il Trattato di Amsterdam, tutto è rimasto come prima. La “Politica Estera e di Sicurezza Comune”, la famosa PESC, il vecchio “secondo pilastro” dell’Unione Europea, continua a vacillare. E al suo interno il problema della difesa, dell’esercito e del riarmo, dorme un sonno tutt’altro che tranquillo, vista l’invasione russa dell’Ucraina.
Oggi come allora, l’Europa è attraversata da gravi tensioni. Gli interessi nazionali sono ancora troppo divergenti. Oggi come allora, la minaccia russa ci invita a fare presto. Senza rinunciare alla sovranità, gli Stati devono urgentemente rilanciare la cooperazione militare e riarmare un continente chiamato nuovamente, nel quadro delle sue storiche alleanze internazionali, a difendere le proprie frontiere geografiche, satellitari, aerospaziali e virtuali. Il nemico che viene da Est bussa ancora alle sue porte.




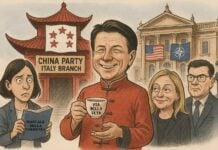


























A Differenza della Germania- dell’Austria–che hanno detto No al Blocco del petrolio Noi poveri in Canna di Prodotti petroliferi x Far contenti gli americani di BIDEN Senza Importazione dalla Russia Moriremo tutti di Fame oltre Per disoccupazione e Freddo del prossimo Inverno!
il Governo Italiano di Mario Draghi e compagni di sventura ancora spingono con nuove ASSURDE sanzioni alla Russia come dicevo Malgrado la nostra Carenza di Petrolio e simili!
Invece di seguitare con l’invio di Armi tutti i capi di stato+ governo con dei Bus Pronti ha partire per trattare una giusta Proposta con Putin Invece di stare con il vostro C…o sulle poltrone!
E’ decisa e si farà, quindi
BUONA GUERRA A TUTTI
La difesa unica europea?? E chi glielo dice agli americani????
Gli americani ci hanno sconfitto in guerra e hanno il dominio sul nostro territorio e non molleranno facilmente l’osso. Io credo che l’attuale guerra in Ucraina abbia due compiti principali che sono
1) Dividere l’Europa dell’Ovest da quella dell’Est (Russia). Si perché la Russia è Europa. Questa unione
creerebbe un pericoloso concorrente alla egemonia mondiale anglosassone e dell’Alta finanza.
2) Distruggere o asservire la Russia per accerchiare la Cina.
E’ una guerra mondiale a mozziconi in cui si gioca il dominio del mondo, la salvezza di Israele e
dell”AUSTRALIA e degli stessi USA. Per questo nobile compito, i nostri alleati americani sono
pronti a sacrificare la sicurezza e il benessere e, forse, anche la vita, di noi europei. Un sacrificio molto grande visto il bene che ci vogliono.
Poi ci sono le divisioni tra noi europei, la mancanza di una lingua comune e i ricordi degli odi passati. I baltici e i polacchi ricordano bene le nefandezze dei russi nella seconda guerra mondiale ma sono completamente all’oscuro dei misfatti degli alleati dalle nostre parti.
Ancora ci trastulliamo col fascismo e antifascismo senza pensare al futuro che impone di scordarci il passato.
Per la nostra salvezza dobbiamo avere una sola lingua e un solo popolo che abbia la forza e il coraggio di pretendere di essere trattato da pari a pari dai nostri alleati anglosassoni.
Gallozzi Ferdinando
Distrutti nella prima guerra quegli imperi che ancora in qualche misura si richiamavano ad un principio trascendente, l’austroungarico, il tedesco, l’ottomano e il russo, al loro posto fioriscono i nazionalismi rissosi che innescheranno la seconda guerra mondiale, come la Madonna aveva profetizzato a Fatima. Saranno gli Stati Uniti a determinare la vittoria delle “democrazie” e avviare la pace dopo il 1918. Francia ed Inghilterra saranno modesti comprimari, tutte prese dal desiderio di mutilare ed umiliare la Germania sconfitta. L’Italia ne uscirà delusa nelle sue aspettative; la Russia diventerà comunista. Da allora però sarà chiaro a tutti che gli USA non sono più una modesta e folcloristica potenza periferica.
L’esito del secondo conflitto sarà determinato dagli Stati Uniti, che così si incoroneranno prima potenza mondiale. Unico antagonista, ma anche complice, sarà il “paradiso rosso” di Stalin. L’Europa ne uscirà definitivamente detronizzata, divisa nei rispettivi blocchi delle potenze egemoni e serva di esse, con Francia e Gran Bretagna ridotte a liquidare i loro imperi ed a ridimensionare fortemente la loro influenza nel mondo.
Oggi vediamo in Ucraina il terzo conflitto civile fra europei. Prescindendo anche qui dalle cause iniziali e dalle responsabilità, possiamo già cogliere gli effetti. Le nazioni d’Europa procedono in ordine sparso, serve degli USA, in misura e con modalità diverse. L’Italia brilla fra tutte: compra il gas non dalla Russia, ma dai suoi alleati ed è pronta a rinunciare a qualche grado nei condizionatori (così dice Draghi) per “sistemare” l’orso russo. Gli europei fanno una guerra per procura, fornendo armi all’Ucraina e colpendo la Russia (e se stessi) con le sanzioni economiche. Borrell e Von der Leyen hanno iniziato da un pezzo la danza di guerra e non intendono fermarsi.
Ma il nostro interesse non dovrebbe essere quello di giungere al più presto ad una tregua d’armi? Certamente, ma ancora una volta sono gli americani a dirigere le danze e i loro pupazzi del vecchio continente si accodano più o meno diligentemente: la guerra deve continuare per più tempo possibile fino al crollo del “genocida” Putin; almeno. E la Russia? Impantanata nella palude ucraina in cui si è cacciata non sa come uscirne salvando la faccia. Biden vuole sottomettere ancora più a sè l’occidente e vendere le sue materie prime, cominciando dal gas, agli europei orfani delle esportazioni russe. La NATO ha rigenerato la sua ragion d’essere che era ormai ridotta al lumicino. Alla Cina che vedrebbe una Russia sempre più avvinta nella propria spirale commerciale e politica? L’Europa non si estenderà dall’Atlantico agli Urali come voleva S. Giovanni Paolo II, consegnando definitivamente la Russia all’Asia, perdendo ogni residua autonomia politica e andando incontro ad un crisi economica senza precedenti.
Il terzo conflitto civile europeo è la fine definitiva dell’Europa come soggetto politico. Bisogna fermarlo finchè si è in tempo. Serve uno scatto d’orgoglio, una proposta di mediazione autorevole che salvi la faccia a quei due popoli (e all’Europa tutta), ignorando le smanie guerrafondaie di chi comanda in America.
Condivido pienamente la sua analisi. Aggiungerei solo qualcosa al suo cenno riguardo a chi “comanda in America”. Chi comanda?? Trump è stato detronizzato con l’inganno?? In America c’è una finta Democrazia?? Molte volte e molti hanno spesso alluso alla forza nascosta che tiene in pugno la Democrazia americana e la dirige secondo i suoi voleri. Forse Trump si è allontanato troppo dai loro desiderata ed è stato “allontanato dal potere”. La Democrazia americana ha artigli di acciaio, di fuoco atomico. Accusa Putin di essere un ” criminale, fuorilegge” ma ne usa essa stessa il linguaggio violentoe minaccioso. I nostri politici sono stati accuratamente scelti da chi di dovere e fanno a gara a chi si genuflette più in basso.
Noi abbiamo, ora, legami di sangue e affinità di civiltà e sentire con gli americani ma questo non li può autorizzare a trattarci come loro servi muti.
Sta a noi richiedere e dimostrare che pretendiamo considerazione e che siamo determianti ad ottenerla,
La Russia e laq Cina o la turchia non credo siano meglio degli USA e dobbiamo coltivare la nostr amicizia e collaborazione da non confondere con la servitù o schiavitù
Gallozzi Ferdinando
Riarmare non credo proprio sia la soluzione.. La minaccia viene dall’interno (Bruxelles e l’identità digitale, il green pass ed il credito sociale che ci vogliono imporre) e dall’occidente (USA che vogliono venderci il loro gas a prezzo triplicato, ecc). Per me la NEUTRALITA è l’unica soluzione, ed ovviamente il liberarci dall’oligarchia di una Commissione europea non eletta (Gentiloni in Italia non aveva voti e lo hanno piazzato alla commissione, Ursula von der Leyen era indesiderata dai tedeschi e l’hanno piazzata lì, ecc, anche Prodi fu piazzato lì per dargli il contentino dopo la mancata elezione a Presidente della Repubblica). Non spendiamo per armi, spendiamo per gli ITALIANI (salute, economia delle piccole e medie imprese, famiglie).
Concordo quasi in tutto.Tuttavia oggi chi non ha potere è come una piuma nel vento.La Storia insegna che ,federati in un’unione Europea o Nazioni singole sovrane,si deva avere qualche deterrente per difendersi dall’esterno.La piccola Svizzera ,per es.,non ha nel suo esercito(tra l’altro esiguo ma perfettamente organizzato) la difesa maggiore ma nelle sue banche che detengono i soldi di tutto il mondo.Quindi o si hanno “leve economiche,finanziarie,merceologiche,militari oppure si è in balìa dei “lupi.”Ed il mondo,specie oggi,con una globalizzazzione e tecnologia del “tutto connesso” mai vista,è costituito da “lupi…..
Non è una novità. Togliere la bandiera azzurra con le stelle e mettere quella dell’imperatore Costantino e dei Crociati : IN HOC SIGNO VINCES !