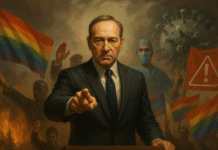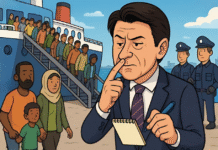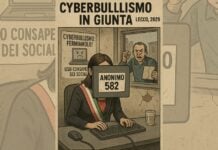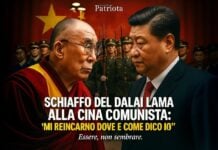Le guerre degli anni Novanta del secolo scorso in Croazia, Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Serbia hanno a lungo occupato le prime pagine dei giornali e le loro conseguenze si percepiscono ancora oggi. Tuttavia nella polveriera balcanica scatenatasi dopo la dissoluzione della Jugoslavia (sopravvissuta poco più di un decennio alla morte del suo padre-padrone Josip Broz “Tito”) un altro conflitto, molto meno cruento, ma vissuto con ardore da entrambe le parti in causa, è proseguito fino ai nostri giorni e non è detto che si concluda del tutto. Esso riguarda la denominazione di quella repubblica federata alla Jugoslavia con il nome di Macedonia, la quale nel settembre del 1991 proclamò la propria indipendenza, ma la confinante Grecia pose il veto all’uso del nome “Macedonia” poiché così si chiama anche una regione ellenica, di cui si voleva garantire l’unicità e nei cui confronti si temevano mire irredentiste da parte di Skopije (come in passato era già avvenuto).
Da parte della Former Yugoslav Republic of Macedonia (questo il nome che in via transitoria fu internazionalmente assegnato al nuovo Stato) la disputa si inseriva nel difficile percorso non solo di State building (il veto di Atene precludeva l’accesso all’Unione Europea ed alla Nato) ma anche di Nation building, poiché la cospicua comunità macedone in esilio, per differenziarsi dallo jugoslavismo titoista, aveva cominciato a coltivare il mito nazionale di Alessandro il Grande, laddove i macedoni autoctoni risentivano della complessa contestualizzazione nel mondo slavo della propria etnia. Esisteva un ceppo macedone originario o si trattava, come sostenevano i nazionalisti di Sofia, di una diramazione bulgara? Pesava di più nella connotazione della propria identità aver dato i natali alla dinastia di Filippo e Alessandro o aver fatto parte della Grande Bulgaria medioevale? Perdurando lo stallo diplomatico nonostante i molteplici tentativi di mediazione internazionale, i governi di Nikola Gruevski, leader del VMRO, partito che si ricollega al vecchio movimento indipendentista macedone, noto anche per l’uso del terrorismo per il conseguimento dei propri obiettivi indipendentisti nella prima metà del secolo scorso, impressero decisamente una svolta nell’accaparramento dell’eredità del conquistatore dell’immenso impero. Il nome dell’aeroporto internazionale della capitale e della principale autostrada nazionale, monumenti equestri, vie e statue in tantissime località: i primi anni Duemila hanno contrassegnato un florilegio di opere dedicate ad Alessandro che hanno inasprito i rapporti con la repubblica ellenica e allontanato la soluzione della vicenda. Ben comprensibili le recriminazioni della diplomazia greca, tuttavia la figura del grande conquistatore poteva rappresentare una personalità aggregante nell’ambito di uno Stato piccolo, ma caratterizzato dalla presenza di una cospicua comunità albanese non priva di velleità separatiste, rinfocolate soprattutto dall’indipendenza acquisita dal Kosovo e dal recupero del concetto di Grande Albania negli ambiti nazionalisti, laddove calcare la mano sull’identità slava avrebbe inasprito la spaccatura tra i due gruppi etnici.
L’avvicendamento al potere avvenuto l’anno scorso con l’ascesa al potere del socialdemocratico Zoran Zaev ha impresso una sorprendente accelerazione alla trattativa con il governo di Tsipras: innanzitutto sono sparite molte intitolazioni all’illustre allievo di Aristotele, ma soprattutto la contiguità del nuovo governo macedone alle posizioni europeiste ed atlantiste ha portato ad ammorbidire la posizione negoziale pur di entrare a far parte di questi organismi internazionali. Il compromesso raggiunto a Prespa, sulle rive di un lago attraversato dal confine greco-macedone, afferma che tanto a livello di rapporti interstatuali, quanto nei documenti interni ufficiali e nella sua Costituzione, lo stato che ha per capitale Skopije si chiamerà Macedonia del Nord. Non sono tuttavia mancate le proteste nelle piazze di entrambe le parti in causa: ad Atene i manifestanti hanno veementemente asserito che comunque viene concesso l’utilizzo della parola “Macedonia”, dall’altra parte della barricata viene contestata una lesione di sovranità, poiché numerose saranno le modifiche costituzionali e legislative da apportare per soddisfare le richieste dello Stato confinante. È plausibile ritenere che le proteste godano del supporto della Russia, nazione tradizionalmente legata ad entrambi i contendenti e che ora teme di perdere influenza nei loro confronti e soprattutto che l’adesione macedone all’alleanza atlantica contribuisca a rafforzare l’accerchiamento di Washington nei confronti del Cremlino. L’iter a Skopije si preannuncia complesso, poiché il Presidente della Repubblica appare restio a ratificare il trattato, l’attuale forza di governo gode di uno scarto minimo di voti nei confronti delle agguerrite opposizioni e difficilmente giungerà alla maggioranza qualificata richiesta per le modifiche costituzionali, così come è tutt’altro che scontato l’esito positivo del referendum che si svolgerà in autunno per confermare il compromesso raggiunto. Solamente qualora tutte queste tappe venissero coronate dal successo, anche in Grecia si procederebbe alla ratifica parlamentare dell’accordo.
Di fronte alla caparbietà ellenica nel voler dirimere tale questione in maniera confacente al proprio interesse nazionale ed all’uso spregiudicato del potere di veto esercitato contro Skopije nei consessi internazionali, stride pensare all’arrendevolezza italiana nei confronti di Slovenia e Croazia nei cui confronti erano aperte questioni collegate ai beni abbandonati dagli esuli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e che Lubiana e Zagabria dovevano accollarsi in quanto Stati successori della Jugoslavia. La diplomazia italiana al momento dell’implosione jugoslava si era adoperata per garantire l’integrità territoriale di Belgrado, come prevista dagli accordi internazionali sull’inviolabilità dei confini ed in quanto conveniente per la mole di sinergie economiche che la “Ost-politik” italiana aveva intessuto con l’altra sponda dell’Adriatico. Il riconoscimento dell’indipendenza slovena e croata da parte di Vaticano (due stati tradizionalmente cattolici uscivano dalle grinfie di un regime tendenzialmente ateo) e Germania (l’interesse dell’economia tedesca riunificata a riallacciare i rapporti con l’area danubiano-balcanica relazionandosi con Stati piccoli e con minor potere contrattuale) costrinse la Farnesina a fare altrettanto. Restava tuttavia la possibilità di esercitare un diritto di veto nei confronti dell’adesione delle neonate repubbliche alle strutture comunitarie europee, volendo prima risolvere le questione collegate al Trattato di Osimo (1975) ed al conseguente Trattato di Roma (1983) relativi all’indennizzo per i beni abbandonati dagli esuli nella Zona B (distretti di Capodistria e di Buie) del mai costituito Territorio Libero di Trieste e nazionalizzati dal regime titoista; afferivano inoltre alla Croazia le porzioni di Dalmazia, Carnaro e Istria che erano state oggetto del Trattato di Pace del 1947, territori in cui vi erano margini per ridiscutere gli espropri, le violenze e le privazioni patiti dai nostri connazionali alla fine della Seconda guerra mondiale. Se il Ministro degli Esteri Martino nel primo Governo Berlusconi cercò di affrontare tali questioni, i suoi successori nel Governo Dini e negli esecutivi di centrosinistra della legislatura 1996-2001 spianarono la strada verso l’Unione Europea agli interlocutori adriatici senza ottenere alcunché di sostanzioso in cambio. In questa maniera, accollandosi il restante dell’indennizzo che la Jugoslavia si era impegnata a corrispondere ratealmente (una sola quota era stata versata prima dell’implosione della repubblica federale) , la Slovenia versò su un conto corrente della Dresdner Bank in Lussemburgo quanto ritenne di sua spettanza e la Croazia non erogò alcunché. Bisogna, però, precisare che l’accordo tra Lubiana e Zagabria finalizzato a suddividere quest’onere non risulterebbe valido per il diritto internazionale, in base al quale si richiedeva un accordo trilaterale. La perdurante inerzia italiana è valsa come un silenzio-assenso, anche se tuttora restano margini di trattativa: una diplomazia efficace potrebbe ancora adire una controversia per violazione degli obblighi pattizi, nonché, stante l’impossibilità della restituito in integrum, riaprire la questione degli indennizzi chiedendo il calcolo degli interessi di mora.