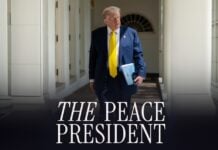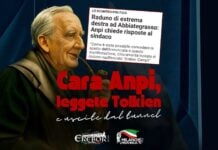L’amicizia, quella autentica, quella disinteressata e veritiera, senza secondi fini e interessi strumentali, è merce rara, pietra preziosa di inestimabile valore. La vicinanza, di cuore e di pensiero, non produce assembramenti di corpi, ma simposi di anime desiose di relazioni umane. L’incontro tra intendimenti affini, tra spiriti e intelletti, avrebbe suscitato l’ideale nobilissimo della humanitas, approdo ultimo della lunga “navigazione” ciceroniana: “L’ideale della humanitas, cioè la concezione dell’uomo che emerge dall’insieme della produzione ciceroniana, ci appare una sintesi complessa ed originale del pensiero filosofico greco e dell’esperienza morale e politica romana” (G. Garbarino, Letteratura latina. Storia e testi. Excursus sui generi letterari, Torino, Paravia, 1995, p. 217). Marco Tullio Cicerone (Arpino 106 a.C. – Gaeta 43 a.C.) fu uomo politico, filosofo, avvocato, retore e oratore che mise la sua persona, anche a costo di fatiche e delusioni cocentissime, quali l’esilio, a servizio di un preciso e nobile proposito, opponendosi all’atteggiamento rinunciatario di molti suoi contemporanei: “Se i poeti neoterici e Lucrezio risposero alla crisi della repubblica con un atteggiamento di indifferenza e di rifiuto verso i valori politici e morali tradizionali, Cicerone cercò invece, seppur vanamente, di trovarvi soluzione con un progetto politico conservatore e anche con un programma di educazione etico-politica della gioventù destinata a divenire la nuova classe dirigente dello Stato” (A. Cavarzese, A. De Vivo, P. Mastrandea, Letteratura latina. Una sintesi storica, Roma, Carocci editore, 2003, p. 79).
L’humanitas non si esauriva in un concetto astratto e puramente teoretico, ma appariva come magistrale luogo di incontro tra le differenti istanze della vita attiva e di quella contemplativa, denotando, pertanto, un’insospettabile originalità, negata di sovente all’eclettismo ciceroniano. Tra i valori indicati dal Nostro emergevano la preminenza della ragione, il valore della cultura, la benevolenza e l’affabilità nei confronti del proprio simile, nonché il senso del dovere verso la patria e la società (cfr. G. Garbarino, op. cit., pp. 217-218).
Cicerone operava una felice conciliazione di scuole e pensieri antagonisti, come l’epicureismo e lo stoicismo, “intorno ad alcune verità: la legge morale, la spiritualità dell’uomo, la sua libertà, l’immortalità dell’anima, l’esistenza del divino” (M. Pancaldi, M. Trombino, M. Villani, Atlante della filosofia. Gli autori e le scuole. Le parole. Le opere, Milano, Hoepli, 2006, p. 156), individuando “[nel]la Res Publica romana, fondata sul diritto” (Ibidem), “l’espressione più alta di humanitas” (Ibidem).
La grandezza di Cicerone risiedeva anche, e non solo, nella sua abilità nel realizzare convergenze tra prassi e teoria, tra individuo e Stato, tra diritti e doveri, tra trascendenza e immanenza, nel segno di una benefica e proficua amicizia tra uomini buoni, liberi, intenti a praticare la virtù: “L’amicizia non è niente altro che una grande armonia di tutte le cose umane e divine, insieme con la benevolenza e l’affetto; davvero non so se, eccettuata la sapienza, sia mai stato dato all’uomo dagli dei immortali niente di meglio di essa. Alcuni le preferiscono la ricchezza, altri la buona salute, altri la potenza, altri gli onori e molti anche i piaceri. Quest’ultima cosa si addice alle bestie mentre quelle altre sono vane e incerte; infatti si basano non tanto sul nostro buon senso, quanto sui capricci della sorte. Quelli che pongono il sommo bene nella virtù, certo pensano assai bene, ma proprio questa virtù genera e preserva l’amicizia né senza la virtù può esistere in alcun modo l’amicizia” (M.T. Cicerone, L’amicizia, VI, a cura di E. M. Gigliozzi, Roma, Tascabili Economici Newton, 1993, p. 31).
In un momento di prova e di scoramento come questo, gravato da incertezze e sfiducie, lasciamo che l’insegnamento di Cicerone ci provochi, ci sfidi all’impresa tutta umana, ed esistenziale, del sapere vivere tra speranze e delusioni, tra gioie e timori, nell’oscillante e perpetuo moto dell’essere presenti a se stessi, nelle forme storiche dell’amicizia e della virtù.