L’economia degli Italiani piange. Piangono le tasche di tutti, imprenditori e operai, dipendenti dello Stato e liberi professionisti, lavoratori autonomi, partite iva, impiegati d’azienda. I dati OSCE sui livelli salariali sono un continuo “memento mori”.
L’ultima rilevazione sulla variazione percentuale tra la media degli stipendi del 1990 e quelli del 2020 vedono il nostro Belpaese maglia nera dell’Europa: -2,9%.
Si tratta di un decremento particolarmente grave se si considera che è l’unico in tutto il Vecchio Continente. Tutti hanno fatto meglio di noi. Proprio tutti: dalla Lituania, prima in classifica con un +276,3 %, seguita sul podio dalle sorelle baltiche Estonia (+237,2%) e Lettonia (+200,5%). La matematica non è una opinione e i numeri sono numeri. Si dirà che lo sviluppo galoppante dei Paesi baltici, un tempo sovietici, è stato direttamente proporzionale alla caduta del comunismo e alla conquista delle libertà, individuali e dei mercati. Ma anche gli Stati abituati alla società aperta e alla democrazia sono cresciuti: nella ricca Germania gli stipendi sono complessivamente aumentati del 33,7%, in Francia del 31,1% e anche la Spagna ha visto migliorare le proprie buste paga del 6,2%. Dimentichiamoci i redditi dei virtuosissimi e “frugali” Paesi scandinavi, così come il progresso dei salari nella vecchia Mitteleuropa. E, ohinoi, hanno il portafogli più gonfio anche la Grecia e il Portogallo.
Nel profondo rosso salariale italiano c’è una categoria che soffre più di altre. Più che una categoria professionale è una categoria sociale, vasta e composita. È quella dei laureati. E anche per loro i numeri sono sconfortanti, se non disastrosi. Sono stati appena battuti dalle agenzie i dati pubblicati dalla Fondazione Nord Est, nell’ambito di uno studio che quantifica il costo dell’emigrazione dei laureati italiani all’estero. Insomma, la famosa “fuga di cervelli” quanto ci costa?
“L’Italia nel complesso ha perso nel 2019, oltre 13 mila laureati e più di 100 mila nel periodo 2011-19, con un’emorragia di capitale umano equivalente a 3,8 miliardi nell’ultimo anno pre-pandemico e 29,3 miliardi nell’intero periodo qui considerato”. “Di fatto, un trasferimento di competitività ad altri sistemi produttivi, che intrappola il Paese in una spirale viziosa di bassi salari-fuga di cervelli-bassa produttività”, ci dice impietoso il Rapporto che certifica la scarsa attrattività del “sistema-Italia” anche dal punto di vista regionale: tra il 2011 e il 2019, la Lombardia ha visto emigrare il numero più alto di laureati, oltre 22 mila, seguita dal Veneto, dal Lazio e dalla Sicilia, tutti con quasi 10 mila perdite. Come sempre, però, i numeri non dicono tutto.
I problemi del sistema accademico italiano sono profondi. Tra luci e ombre, la riforma Gelmini ha tentato di restituire un accesso agli studi superiori più trasparente e un cammino di “professionalizzazione” più rigoroso e rispondente agli standard internazionali. L’istituzione dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione della Ricerca deve essere inquadrata in questa prospettiva di sintesi tra le ragioni del merito e quelle della produttività scientifica. Ma i risultati sono stati contraddittori e insufficienti, sia dal punto di vista del reclutamento del personale docente che della progressione di carriera. La figura del “ricercatore” è caduta in disgrazia perché sedotta e abbandonata sulla via burocratica di continue certificazioni e abilitazioni i cui criteri sono meramente quantitativi e non meno condizionati da logiche “politiche”. Sradicato da un contesto, dalla tradizione delle grandi scuole che in ogni settore scientifico e disciplinare hanno reso grande l’Università italiana, il ricercatore si è ormai praticamente estinto.
Il virus dell’antipolitica ha colpito l’Università a cui sono state sottratte risorse fondamentali con procedure concorsuali sempre più pesanti e bandi pieni di requisiti inutili che non premiano la storia, il profilo, la qualità personale di chi ambisce a produrre sulla via del sapere.
Di fronte alle grandi sfide della competizione globale, l’energia, il clima, la salute, il digitale, la sicurezza, aggravate dagli attuali rischi di una guerra mondiale, l’Università è ancora una volta chiamata a dare risposte pratiche alle esigenze della convivenza, così come a formulare nuove domande sul destino dell’uomo.
Favorire il rientro dei cervelli è oggi una emergenza nazionale. Investire sull’Università come autorità libera e patrimonio pubblico è indispensabile per formare classi dirigenti capaci e consapevoli dell’Italia, del suo “genio” e del suo contributo alla scienza e alla civiltà universali.







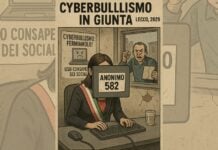















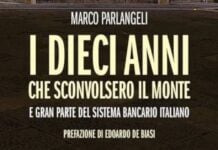



Favorire il rientro dei cervelli… molto molto difficile. Per conoscenze personali posso dire che ad esempio negli ultimi quindici anni il numero di medici italiani che sono andati all’estero è costantemente aumentato, e nessuno di questi tornerà, che sia in Francia, in Germania, in Svizzera, in Gran Bretagna, in Olanda, nessuno. Perchè? In quanto la considerazione per il professionista in questi Paesi, le condizioni di lavoro, gli stipendi sono incomparabili. Il sistema sanitario prevede le mutue che rimborsano tutto o quasi al cittadino che dunque non ha problemi economici per andare a visita nel privato, e così non esistono liste d’attesa infinite come negli ospedali pubblici italiani. Alcuni giovani medici vanno già a fare all’estero la specializzazione, anche in Spagna oltre che nei classici Francia e Germania, per non perdere anni in attesa di entrare. E chiaramente dopo restano a lavorare in quei sistemi sanitari, se per caso rientreranno sarà perchè riescono a fare ottima ricerca lì e poi si presentano e per estrema fortuna vincono il concorso per Professore universitario ordinario in qualche università importante italiana, altrimenti non torneranno mai, forse quando saranno anziani per vivere la pensione in Patria (ma chissà come sarà l’Italia fra trent’anni….). Piuttosto bisogna fare in modo che le condizioni migliorino per i cervelli italiani in formazione che siano incentivati così a restare. Oppure fare entrare cervelli esteri invece di braccia.