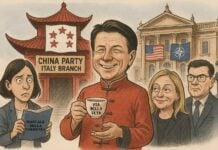La montagna è sinonimo di magnificenza, di purezza, di piacere, di ispirazione poetica, di mistero. La montagna, soprattutto, è vita. Affermarlo non è un mero esercizio retorico, bensì una constatazione fattuale. Le alture sono infatti un essenziale patrimonio di biodiversità da cui sgorgano le sorgenti d’acqua. E quale elemento più dell’acqua alimenta la vita? La montagna è dunque un luogo da preservare e da rispettare, la sua stabilità idrogeologica garantisce la sicurezza delle valli. Se avviene un dissesto in montagna, del resto, l’effetto a cascata si ripercuote sulla pianura. Se la montagna è in salute, ha maggiori possibilità di essere in salute anche il territorio che si dipana ai suoi piedi. Negli ultimi decenni, tuttavia, l’importanza della montagna è stata gradualmente eclissata da una narrazione che premia l’opzione metropolitana come unico paradigma socialmente accettabile. L’idea che vivere in città sia più cool ha così finito per condizionare l’azione politica. Le risorse stanziate per i territori montani si sono rivelate sovente inadeguate, da un punto di vista dell’ampiezza geologica (sono 4.176 su 7.904 i Comuni montani in Italia, pari a circa il 49 per cento della superficie nazionale, con percentuali ancor più rilevanti in alcune Regioni) e da un punto di vista dell’interesse economico (secondo Eurostat, l’Italia è il primo Paese dell’Unione europea per Pil realizzato in province montane, il 44,9 per cento del totale, contro una media europea del 20,7 per cento). Nelle zone ad alta quota, però, si assiste a uno stillicidio di spopolamento costante e graduale. È un processo inevitabile laddove la montagna viene depauperata di servizi, di opportunità lavorative, nonché del suo valore culturale. Ma finalmente, con il governo Meloni, lassù ha iniziato a soffiare anche un vento tanto atteso: quello del cambiamento. Il 31 ottobre scorso è stato approvato in prima lettura in Senato il disegno di legge quadro che ridisegna la disciplina delle aree montane. È una legge finalizzata a contrastare spopolamento e desertificazione dei servizi, che rappresentano le principali cause del dissesto idrogeologico. Ingenti i fondi stanziati: cento milioni l’anno dal 2025, per un totale di circa un miliardo al 2034. Denari che andranno a strutturare una vera e propria “strategia verticale” che si ramifica abbracciando settori diversi ma organicamente collegati tra loro: incentivi a medici, operatori sanitari e insegnanti per incoraggiare lavori essenziali nelle zone montane, sostegni a imprenditori under 41 che investono in agricoltura, eliminazione dei contributi previdenziali per il lavoro agile, crediti d’imposta a microimprese che intraprendono una nuova attività, bonus per ogni figlio nato nei piccoli comuni, mobilità volontaria tra personale dipendente per assicurare la copertura delle piante organiche dei Tribunali. Al Governo è assegnata la delega per il riordino di tutte le agevolazioni. È tanto? È poco? È sicuramente un segnale precipuo, che testimonia una volontà politica. L’obiettivo è chiaro: non relegare la montagna a essere soltanto uno scenario esotico da cartolina o un pretesto di vacanza da consumare rapidamente, ma riempirla di senso facendola tornare attrattiva come luogo in cui risiedere. Perché è lì, nelle aree interne, che affonda la parte più robusta delle nostre radici di italiani. Ed è quindi lì che bisogna tornare per guardare in avanti.
mercoledì, Luglio 16, 2025
Create an account
Welcome! Register for an account
A password will be e-mailed to you.
Password recovery
Recover your password
A password will be e-mailed to you.
© La Voce del Patriota 2018 - 2025 | www.lavocedelpatriota.it - testata registrata presso il Tribunale di Roma al nr. 65/2023 | Direttore Responsabile: Ulderico de Laurentiis