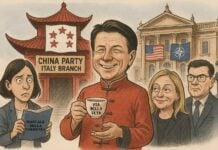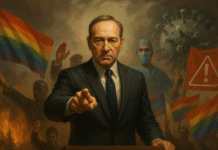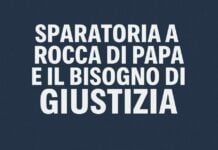Erano rimasti gli ultimi a non aver abbandonato la Vela rossa di Scampia ma stamattina hanno accettato di sgomberare le loro case e stanno andando via al momento senza proteste. Con le ultime undici famiglie si conclude così lo sgombero dell’ultima Vela. Immediatamente dopo partiranno le operazione di abbattimento e si potrà avviare, così, il progetto ‘Restart Scampia’ che prevede il recupero di tutta l’area.
Dopo la demolizione delle Vele, per anni simbolo di degrado, l’intera zona dovrebbe rinascere con spazi verdi, abitazioni a norma, scuole. E’ stato il crollo dello scorso 22 luglio nella Vela Celeste, che segnò la morte di tre persone e il ferimento di undici residenti, tra i quali molti bimbi, ad aver accelerato le procedure di sgombero e di abbattimento. A novembre, poi, il cedimento di una passerella proprio nella vela rossa ha determinato un ulteriore forte spinta.
Il quartiere delle aspettative tradite
Scampia è il luogo delle aspettative tradite. Agli inizi degli anni Settanta qui doveva nascere il sogno della media borghesia napoletana. Si costruivano i primi parchi privati, lontano dal caos del centro della città, il verde attorno, la prospettiva di qualcosa di bello, dove la bellezza non è dirompete, ma serena. Ma nell’Ottanta il terremoto in Irpina ha segnato l’inizio delle scelte politiche sbagliate. Furono edificate strutture in piena emergenza post-terremoto, c’era bisogno di case per gli sfollati. Quelle scelte hanno lasciato spazio alla Camorra. Sono poco meno di 41mila gli abitanti residenti, una stima al ribasso. A loro si aggiungono le migliaia di famiglie che, in mancanza di alternative occupano le case, e una consistente comunità Rom che vive in un campo costruito nel quartiere. Scampia è il luogo delle aspettative tradite perché le Vele non dovevano essere le vele, roccaforte della droga con le vedette sui palazzi. Le “case dei Puffi” nel lotto P, fatte di amianto e che oggi cadono a pezzi – come gran parte del quartiere – dovevano essere provvisorie, per tamponare l’emergenza, invece poi sono diventate l’emergenza.
A Scampia non c’è mai stato un cinema, un parrucchiere, un negozio che vende scarpe. Vicina al centro di Napoli ma abbastanza lontana da disegnarne i contorni a Nord. Le strade larghe, le vie di accesso alle autostrade veloci. A Scampia non c’era un supermercato, così la camorra ha aperto quello della droga: c’erano 25 piazze di spaccio. Il quartiere è stato profondamente segnato dalla prima faida di Secondigliano. Una guerra di camorra tra i Di Lauro e gli “scissionisti”. Mentre si ammazzavano tra loro i colpi di proiettili vacanti hanno ucciso anche ragazze e ragazzi del quartiere, vittime innocenti. Ma che cos’è Scampia oggi? Dopo la faida Scampia è iniziata a cambiare, gli abitanti hanno detto basta. In questo pezzo di Napoli, che lega il centro della città all’hinterland, sono le persone che fanno la differenza.
La camorra ha lasciato spazio all’abbandono
Oggi le piazze di spaccio sono poche, la Camorra ha lasciato spazio all’abbandono. A rimanere è l’emergenza abitativa, la povertà estrema, di quella che non metti insieme il pranzo con la cena, a rimanere – prepotente – è lo stigma su un quartiere e i suoi abitanti. Eppure questo è il quartiere dove non importa chi sei, cosa hai fatto prima, conta solo di cosa hai bisogno adesso. E infatti, negli ultimi 10 anni, è diventato il quartiere con la densità associativa – 32 tra cooperative, imprese sociali, centri diurni, associazioni di volontariato – più alta di tutta la città partenopea.
Scampia, fino agli anni Sessanta, semplicemente non esisteva: era un borgo rurale a nord di Napoli, ai confini con il quartiere di Secondigliano. Il paesaggio ri-dente pieno di alberi e terreni coltivati dava un senso a quell’espressione latina che oggi risuona come un vago ricordo: “Campania felix”.
Fu proprio qui, in questa zona dal vago sapore arcadico, che, coi primi governi di centrosinistra, si pensò di realizzare un enorme complesso residenziale che servisse da sfogo al centro della città, ormai congestionato.
La follia di un’architettura figlia del ’68
Erano gli anni della “programmazione economica” e di una Cassa per il Mezzogiorno pronta a finanziare lautamente ogni progetto di “sviluppo” e di edilizia popolare. Ma erano anche gli anni in cui maturava e si imponeva una cultura architettonica e urbanistica monopolizzata dalla sinistra, la cui “egemonia culturale” si consolidava anche attraverso, e forse soprattutto, l’azione di intellettuali non umanistici ma legati alle scienze pratiche.
Il Sessantotto, a Napoli come altrove, ebbe nelle facoltà di ingegneria ed architettura la sua massa critica. L’idea che si faceva strada era che l’emancipazione dei più poveri sarebbe avvenuta non per una loro concreta e personale volontà e crescita, ma per l’intervento di uno Stato potente e benevolo, sotto la guida di “illuminati” che ne sapevano più di loro stessi e che li avrebbero accompagnati per mano alla conquista della “città futura”.
Con una ipocrita compassione, che celava un sostanziale disprezzo per i diseredati, si pretendeva di plasmarne le vite creando a loro beneficio di un ambiente estetico e umano “perfetto”. Che poi questa utopia si incontrasse con un affarismo politico che si serviva dell’ideologia per coprire la propria sete di potere, non è da meravigliarsi più di tanto, è anzi un topos consegnatoci dalla storia del Novecento.
Fatto sta che le Vele, costruite fra il 1962 e il 1975, furono esaltate come esempio di edilizia popolare modello, capolavori estetici, realizzazione pratica di un ideale di vita in comune e solidale che avrebbe ricreato i legami sociali dei vicoli in un ambiente moderno e funzionale. Era tutto il contrario, come sempre accade per i progetti disegnati “a tavolino” da chi non conosce le esigenze dei poveri che vorrebbe aiutare.
Le promesse-bluff del sindaco Rosso Maurizio Valenzi
Nel frattempo, a Napoli diventava sindaco Maurizio Valenzi, un’icona del politico-intellettuale comunista e antifascista, eroe della Resistenza e pittore nel tempo libero. Fu sotto la sua spinta che, tra il 1976 e il 1980, più di un quarto degli abitanti del centro storico napoletano fu trasferito in modo più o meno volontario (qualcuno ha parlato di “deportazione”) nel nuovo complesso edilizio. A livello propagandistico, un vero successo per le nuove giunte di sinistra che, sull’onda dell’avanzata comunista, si insediavano nei maggiori centri italiani. Inutile dire che tutti quei servizi che avrebbero dovuto accompagnare questo trasferimento in massa, dai collegamenti veloci alle strutture pubbliche di ogni tipo, non erano ancora state realizzate. O, semplicemente, non erano state nemmeno pensate.
Scampia, con le sue Vele avveniristiche che erano in realtà casermoni-dormitorio, in poco tempo sarebbe divenuta la località con il più alto grado di criminalità, disagi psichici, piccola delinquenza, spaccio di droga, non solo del Sud ma di tutta l’Italia. O forse dell’intera Europa.
Gomorra e le fortune di Saviano
Con un voltafaccia incredibile, fu la stessa sinistra che cominciò presto a denunziare i mali di Scampia, quei mali di cui era stata in ultima istanza la causa culturale e politica. Sul degrado di Scampia ha costruito le proprie fortune pseudo-letterarie Roberto Saviano, il quale, più volte, non ha fatto mancare la sua voce, ben tenendo nascoste le responsabilità della sua parte politica. Casomai accusando il governo e i “fascisti” dei morti del crollo. In circa quaranta anni di ininterrotto governo cittadino, di riqualificazioni mai avvenute, di demolizioni di ciò che si era con tanto trasporto costruito, di trasferimenti di sedi universitarie a solo scopo di immagine, la sinistra dovrebbe solo fare autocritica. Non la farà. Intanto, il suo fallimento sarà pagato, ancora una volta, da poveri cristi innocenti.