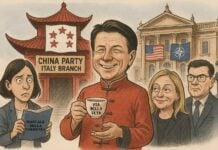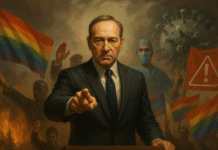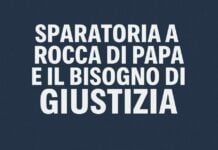«Il sistema sociale che relega il lavoratore al ruolo di strumento o di ingranaggio è in contraddizione secondo me con la natura della nostra specie, anzi perfino con lo spirito di una sana produttività. Senza voler contestare ciò che il capitalismo realizza a profitto non solo di singoli individui ma anche della collettività, la realtà è che esso porta in sé i motivi di una massiccia e perpetua insoddisfazione». Queste parole incentrate sulle idee di superamento del laissez-faire e di partecipazione dei lavoratori provengono da un insospettabile: Charles De Gaulle. Il celebre leader francese mirava ambiziosamente al progressivo inserimento delle maestranze nella gestione e nell’amministrazione delle grandi aziende, e le sue idee rivoluzionarie si arenarono solamente con la sconfitta nel referendum popolare del 1969. A remare contro furono in particolare la finanza e grandi multinazionali, che temevano “l’intrusione” dei lavoratori nei processi decisionali, che il Generale voleva realizzare attraverso un processo di crescita e “nuova consapevolezza”. Al fianco dei grandi interessi economici paradossalmente si schierarono i sindacati (nella loro componente marxista), i quali non riuscirono ad andare “oltre” la lotta di classe, incapaci di pensare alla collaborazione capitale-lavoro e all’idea del lavoratore quale parte attiva di un processo economico dinamico e complesso che può anche non esaurirsi nello “scontro” tra padroni e operai, così da sbocciare in strade diverse da quelle di improbabili rivoluzioni proletarie.
Si tratta degli stessi gruppi che remarono contro l’attuazione della partecipazione in Italia, nonostante l’avveniristico articolo 46 della nostra Costituzione, che riconosce il «diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende». In pochi portarono avanti con convinzione questa strada, tra tutti basti citare ampie frange “sociali” del Msi e del sindacalismo nazionale fino ad Amintore Fanfani, teorico del corporativismo tra le due guerre e successivamente uomo di punta della Democrazia Cristiana. Ad ogni modo, siamo di fronte a un principio dal respiro europeo, che ha trovato attuazione in molti paesi, dalle esperienze scandinave fino al noto caso tedesco. La co-determinazione, attuata in Germania in diverse forme sin dagli anni ’50, è stata spesso capace di garantire l’elevazione sociale e culturale degli operai, favorendo al contempo il legame delle imprese al territorio, come racconta Enrico Grazzini in Democrazia Economica. Da ultimo, Mario Bozzi Sentieri ha scritto una ricca rassegna delle esperienze in questo senso nel volume L’Idea Partecipativa, in cui dal corporativismo dell’Antica Roma e del Medioevo si arriva fino ai recenti provvedimenti dell’Unione Europea, passando per il pensiero religioso di Toniolo, Chesterton, Mounier, Spiazzi, Zampetti e della Dottrina Sociale della Chiesa. Un volume che lancia un messaggio: l’idea di collaborazione di classe e del «lavoro soggetto dell’economia», nonostante le enormi difficoltà, non vuole morire. Spunti più attuali che mai nel contesto di quella Società della sorveglianza magistralmente descritta da Guillaume Travers.
Proprio in questo senso, giunge molto gradito il volume La Sfida Partecipativa del giovane studioso Francesco Marrara, originato dai suoi studi universitari nel campo del Diritto del Lavoro, che l’Istituto “Stato e Partecipazione” non poteva non promuovere e pubblicare con la speranza di scuotere il dibattito e animare riflessioni, rinnovando la collaborazione con Passaggio al Bosco dopo La sola ragione di Vivere (2020) dedicato all’impresa di Fiume. Oltre a riportare importanti intuizioni sul tema della partecipazione, Marrara si sofferma ampiamente sul sindacato, offrendo cenni storici e analisi giuridiche sull’attualità degne di nota, che aprono quesiti fondamentali. Quale potrà essere il ruolo delle organizzazioni sindacali sempre più in crisi nell’epoca della robotica e della rivoluzione digitale? E la partecipazione può essere una risposta alla crisi della comunità e della “società liquida” del XXI secolo? Si tratta di crisi non solo sociali, sanitarie e geopolitiche, ma anche valoriali, e allora comunità, etica e responsabilità appaiono parole necessarie. «Non si può fare una buona economia con una cattiva etica», ricorda Marrara citando Ezra Pound. Veneziani ha sottolineato giustamente che la partecipazione «non è solo un prender parte, ma è soprattutto un esser parte, un sentirsi parte. Si partecipa solo se si avverte il bisogno di integrazione comunitaria, si partecipa solo se si percepisce l’esigenza di riconoscersi in una comune appartenenza, in una comune provenienza, in un comune destino. La partecipazione è dunque il tentativo di risvegliare un’identità collettiva dopo le lacerazioni prodotte dalla modernità e di ridestare un solidarismo di tipo nuovo. La scommessa partecipativa dei nostri anni è quella di ritrovare la dimensione comune del noi, non calandola dall’alto di un’auctoritas statale, ma ritrovandola nell’anima stessa della società e nel cuore degli uomini. E nel bisogno diffuso e inesausto di riconoscersi in un’identità collettiva».
Per rilanciare la Nazione su questa strada bisognerà inoltre ricostruire il patrimonio industriale pubblico, l’unico che, se adeguatamente valorizzato e armonizzato col privato, può promuovere lo sviluppo. Colpita a morte dalle privatizzazioni (protagonista Mario Draghi), stretta tra precarietà e deindustrializzazione, l’Italia deve riprendere in mano (e attualizzare) la strada di un modello sociale interrotta bruscamente negli anni ’90 e denunciata tra gli altri da Tremonti, Guarino e Accame. Oggi, i mutati equilibri politici possono offrire l’occasione di sperimentare strade sociali in cui al fianco dei diritti ci siano il dovere e la responsabilità, superando anti-politica, demagogia e invidia sociale che hanno spesso caratterizzato in negativo il dibattito pubblico. Sperimentare strade “partecipative” per cavalcare le innovazioni; ricreare il tessuto dei nostri territori martoriati; rilanciare i distretti industriali e le idee di “sovranità alimentare” ed energetica, per un lavoro che sia crescita e costruzione individuale e della comunità nazionale allo stesso tempo.