Quando non si comprende un problema serio, e si vuole continuare a non capirlo, ci si immerge nelle astrazioni. O, per usare una metafora calcistica, si butta la palla in tribuna. E’ quanto sta facendo lil dibattito pubblico in questi giorni a proposito della “esportazione della democrazia” e dell’Afghanistan, con Enrico Letta rassicurante che mai più saranno presi dalla tentazione e i vecchi blairisto-bushisti delusi da Biden a ribattere che no, la democrazia si esporta, eccome! (Entrambi sono d’accordo a importare l’islam, in compenso). In nessun altro paese che ha partecipato alla guerra e pagato un tributo di sangue il dibattito è cosi surreale. A cominciare dagli Stati Uniti, dove, altro che “esportazione della democrazia”, la questione è ben più seria, ed è quello della stessa legittimità del modello democratico in casa, negli Usa ma anche da noi. Ci ritorneremo.
Ma prima chiariamo perché il dibattito sull’esportazione della democrazia, già astratto in sé, si faccia surreale nel caso dell’Afghanistan. La guerra fu decisa allora, esattamente vent’anni fa, pochi giorni dopo l’11 settembre, con voto bipartisan in quasi tutti i paesi (compreso il nostro) non per esportare la democrazia o per togliere il burqa alle donne ma perché la base terroristica di Al Qaada stava li. Nessuno, neppure il più trotskista dei consiglieri di Cheney (il vero presidente, non me ne voglia Bush jr) si spinse a parlare di guerra per esportare la democrazia. Questo semmai si fece tempo dopo per l’Iraq, con molto minore consenso internazionale. Il governo in carica, il Berlusconi II, non partecipò in prima linea alla guerra in Iraq, come invece Regno Unito, Spagna, Polonia e altri paesi. Basti ricordare che non tutte le forze di governo erano convinte, e parecchie e sensate critiche pubbliche vennero da esponenti di An, della Lega e del partito di Casini, allora presidente della Camera. Per non parlare della posizione di netta contrarietà di Giovanni Paolo II. La sinistra, a parte d’Alema e qualche esponente dell’allora Margherita, fu ovviamente nettamente contraria all’intervento , e andò a ingrossare le file dell’antiamericanismo rosso di piazza, che poi arrivò a sfilare con lo slogan “uno dieci cento Nassyria”.
Questa la breve storia. A cui bisogna accostarne un’altra. Da quando esiste, cioè dalla Rivoluzione francese, passando per la rivoluzione bolscevica in avanti, la sinistra è sempre stata a favore della esportazione di quella che, per loro, è “democrazia”. Esportazione manu militari, con armi e uccisione di tutti coloro che non gradivano il nuovo regime. Poi ovviamente variavano le forme della esportazione: durante la guerra fredda, prese forme politiche anche se i missili a testate nucleari dei paesi del Patto di Varsavia erano puntate sulle nostre città. La sinistra sostiene sempre la esportazione della “democrazia” a patto che però siano loro a farlo: quando erano gli odiati americani, allora si scendeva in piazza contro. Con una leggera variazione dopo il crollo del Muro: la sinistra, diventata da filo sovietica europeista e filo americana, protestava solo quando a esportare la democrazia erano presidenti repubblicani: e, di fatto, nessuna dimostrazione di peso si ricorda contro le guerre di Clinton, di Obama e quelle future di Biden.
Siamo in pieno iper uranio. Mentre il problema reale, ben colto da diversi conservatori in Usa negli ultimi tempi, è la “crisi di legittimità” dello stesso regime democratico, eroso dalla tecnocrazia e dalla perdita di sovranità. Si, perdita di sovranità anche per gli Usa, come scrive Roger Kimball su “American Greatness” del 22 agosto, per cui la “legittimazione tecnocratica della classe dirigente politica è esplosa”. Nella stessa direzione Rod Dreher che, su “American Conservative” del 20 agosto parla di “momento Chernenko” per gli Usa (in attesa di un Gorbaciov che poi ne acceleri la distruzione?). Dreher cita un passaggio della Crisi della democrazia parlamentare di Carl Schmitt in cui il giurista spiega che un regime finisce quando i suoi valori sono andati perduti per sempre, e rimangono in piedi solo gli “apparati esterni”. Infine, Michal Anton, su “American Mind” del 17 agosto scrive che l’errore degli Usa è stato di non ritirarsi dopo aver distrutto le basi terroristiche, rimanendo con l’illusione, che fu della seconda amministrazione Bush e di quella Obama, appunto di “esportare la democrazia”. Ma, scrive Anton, l’Afghanistan è privo di “istituzioni, sistemi educativi, infrastrutture e economie industriali”, inoltre la sua “cultura” e le sue “tradizioni” sono antitetiche alle nostre. E comunque, quali sono i valori che oggi si accompagnano alla cosiddetta democrazia? La cancel culture, l’abbattimento di statue: ma a fare questo hanno cominciato proprio i talebani, e l’originale è sempre meglio della copia.






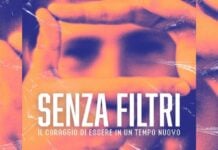
















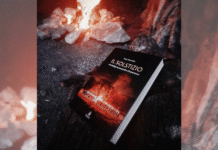

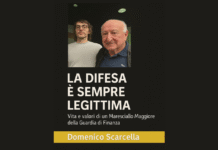
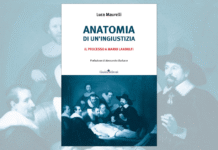






Bello Professore! Grazie