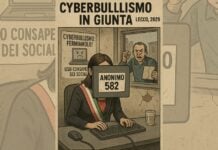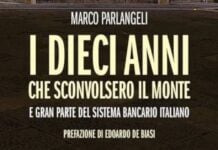Dante scrisse: “Amore (Dio) e ‘l cor gentil (l’anima santificata) sono una cosa”. Questo endecasillabo è la sintesi suprema della mistica cristiana e neoplatonica. La data del solstizio è prefigurazione degna di rispetto, ma riproporla oggi, significa rimanere ingabbiati nei cicli annuali di morte e rinascita, cicli da cui l’uomo deve affrancarsi per poter dire con Eckhart :”L’occhio nel quale io vedo Dio è lo stesso occhio in cui Dio mi vede.”
Insomma, l’Uomo è oggi chiamato a centrarsi nel cuore della croce e non perdersi nei suoi bracci, ma per giungere a tale centralità sarà necessario interiorizzare ciò che la natura e lo stesso universo ci offrono in termini di simbolo, camminare dunque su quel percorso tradizionale che si presenta a noi come orma.
Nel cielo dell’emisfero boreale, la stella del Nord ha rappresentato nel corso dei secoli un sicuro punto di riferimento per le rotte di navigazione, diventando simbolo di fissità e centralità. Essa non conosce mutamento alcuno e neppure i cicli stagionali (solstizi ed equinozi) minano la sua stabilità è per questo che la tradizione cristiana ha dato alla Vergine il titolo di Stella Maris, invocando Maria come guida, speranza e stella polare di tutti i cristiani. La Stella Polare, per dirla con Dante, è quel termine fisso d’etterno consiglio al quale tende l’uomo in cerca di una realizzazione integrale, proprio come l’ago della bussola che volge a Nord. E allora, ancora una volta, sarà necessario pensare al mare, agli astri ed a Roma come ad un superbo continuum, realizzando una visione universale come quella dell’Urbe.
D’altronde, secondo un’antica Tradizione, Roma ha un profondo legame con l’Orsa Minore o Piccolo Carro, poiché riflette sommariamente, con la disposizione dei suoi sette colli, i sette astri della costellazione.
Il Palatino, a sua volta, rappresenterebbe la Stella Polare stessa e, non a caso, il nome di questo colle deriva dalla radice indoeuropea “Pal”, “Pol”, che sta a significare un movimento circolare o un oggetto tondeggiante, da qui “polos”, “polus”: palo, asse. Dunque, in virtù di quanto appena detto, il Palatino acquista la funzione di asse, Axis Romae, all’interno della stessa Urbe, che è centro ombelicale (omphalos) corrispondente al polo celeste.
Proprio alla luce di questo stretto rapporto tra la continua ricerca di una fissità e l’eroico combattimento operato nella navigazione, appare piuttosto debole la critica rivolta contro le civiltà del mare, colpevoli – secondo una narrazione che prende le mosse dal tedesco Schmitt e che oggi si diffonde dalla Russia – di agevolare una società apolide e capitalista. Gli assertori di questa teoria tendono a dividere, secondo un paradigma elementale, i soggetti dello scacchiere geopolitico in “talassocrazie” – cioè quelle nazioni che traggono la propria forza vitale dal mare – e “tellurocrazie”, che al contrario basano la loro weltanschauung sull’elemento terra. Secondo questo schema: le prime rispecchierebbero l’elemento acqua anche nel loro operare quotidiano e, per questo, andrebbero a generare una società fluida incentrata sulle attività commerciali, sviluppando un sistema materialista e schiavo del capitale; le potenze tellurocratiche, al contrario, connaturandosi all’elemento terra ed ai suoi cicli stagionali (e quindi solstiziali), avrebbero come proprio soggetto principale il lavoro e – per questo – garantirebbero una vita sociale più omogenea e radicata.
I russi, secondo questo schema, sarebbero la quintessenza delle potenze tellurocratiche, indicando come prove a loro vantaggio il passato zarista dell’Impero Russo ed il periodo stalinista dell’ex Urss, integrando il tutto alla specificità della Chiesa Ortodossa russa.
Va detto, infine, che per i seguaci di questa teoria non solo l’antica Roma era una potenza tellurocratica, ma Mosca ne è oggi la più degna proiezione, motivo per il quale la capitale russa è identificata con l’appellativo di Terza Roma.
Ai sostenitori di tali teorie sfugge, evidentemente, il concetto di “universalità”, poiché proprio in virtù della sua universalità, l’unica e vera Roma non fu né potenza talassocratica né potenza tellurocratica, bensì una sintesi armonica di entrambe.
D’altro canto, le civiltà del mare tradizionali – non le degenerazioni anglosassone e statunitense spesso portate ad esempio dagli “eurasiatisti” – non hanno nulla da invidiare né a livello spirituale né a livello sociale alle cosiddette potenze di terra: anzi, la virtù della “stabilità” terrestre sarà addirittura maggiore in quelle comunità marinare abituate a guardare al cielo e alla fissità della stella polare durante le incertezze della navigazione; fissità che, al contrario dei cicli terrestri, non conosce né solstizi né equinozi.
Giano, il dio italico e romano delle chiavi e della nave, risolve tali cicli nell’asse della sua bifacialità e li proietta nella nuova tradizione che trova in Pietro – l’apostolo con le chiavi sacre “tibi dabo clavis” e la custodia della barca/chiesa- il vicario di Cristo sulla terra e la massima autorità spirituale del mondo. Pietro, giunto a Roma via mare, è dunque il supremo pescatore di anime, mentre Roma è l’unica ed irripetibile città sacra del cristianesimo.
Nella Tradizione Occidentale, dunque, non c’è spazio per una seconda o una terza Roma poiché, come afferma Dante nel De Monarchia: «Il popolo romano fu predestinato dalla natura all’Impero; dunque il popolo romano, assoggettandosi il mondo, giunse all’Impero in forza di un diritto.»
Questa missione di “guida tra le nazioni” è sacra, unica ed irripetibile. In questo senso, a venirci in aiuto, è ancora il sommo Poeta che – spingendosi laddove nessuno si era mai spinto prima – realizza una sintesi tra l’antica tradizione romana e la nuova forma tradizionale rappresentata dal cattolicesimo, fino a tracciare la figura di una Roma città-celeste, descritta al poeta da Beatrice nel penultimo canto del Purgatorio:
«E sarai meco sanza fine civedi quella Roma onde Cristo è romano.»
Al vate Virgilio, che dopo aver cantato la Roma dei Cesari e l’antica tradizione, profetizza nella IV Ecloga l’arrivo del puer e della Vergine, si avvicenda il vate Dante che in epoca medievale canta la Roma cattolica dei papi.
Dunque, se davvero il vaticinio di una Terza Roma si realizzasse, sarebbe ancora sul suolo italico e romano. D’altronde, tale vaticinio si ritrova nell’ideale mazziniano di un’Urbe universale, “Tempio dell’umanità”, dalla quale uscirà “la trasformazione religiosa che darà, per la terza volta, unità morale all’Europa.”
Questa non sarà più la Roma dei Cesari o dei Papi, ma la Roma degli italiani.