L’Ucraina è una medaglia a due facce. Su un lato è raffigurato un Paese di cultura e tradizione europea, con la propria lingua e con una forte appartenenza di popolo. Sull’altro lato è raffigurata una terra che difficilmente si distingue dalla vicina Russia, dove la popolazione parla russo e spesso si sente più vicina a Mosca che non a Kiev. Queste due anime si ritrovano nei movimenti, filo europeo nelle regioni occidentali e filo russo nelle regioni orientali, che si sono alternati negli ultimi dieci anni alla guida dello Stato.
Gli ucraini hanno le loro buone ragioni, alcune antiche e altre recenti, per avercela con i russi, Fin dal medioevo, l’Ucraina, è una terra che i russi considerano legittimati a dominare, che contendono ai vicini europei e nella quale reprimono con durezza ogni aspirazione di indipendenza. Nel tentativo di cancellarne il tessuto sociale fatto di piccoli proprietari terrieri, l’Unione sovietica di Stalin arrivò a mettere in atto, tra il 1929 e il 1933, quello che passerà alla storia come il “genocidio ucraino” o Holodomor, la “morte per fame”, sarebbe a dire la premeditata carestia agricola dell’Ucraina che in quegli anni causò la morte di milioni di persone. Passando ai nostri giorni, il sostegno russo al governo corrotto e inconcludente di Viktor Yanukovich non ha certo giovato ad attenuare lo storico, e spesso giustificato, astio degli ucraini nei confronti della “sorella maggiore”
Dal canto loro, i russi di Mosca e i filo russi dell’Ucraina, considerano la rivolta di Kiev espressione di una minoranza “nazionalista” e non rappresentativa della volontà della
maggioranza della popolazione.
D’altronde, sotto l’aspetto formale non si può non tener conto che Yanukovich ha vinto le ultime elezioni politiche. Sulla Crimea i russi reputano di avere ragioni addirittura più forti, considerato che sì tratta di una terra da sempre fortemente autonoma, a maggioranza russa, che è stata “assegnata” da Kruscev a Kiev solo nel 1954, in anni nei quali i confini tra le repubbliche sovietiche erano più
simbolici che reali.
Ma è chiaro a tutti che la vera questione non è stabilire da che parte stia la ragione, ma piuttosto capire le conseguenze geopolitiche di un esplicito posizionamento dell’Ucraina nell’area Nato. Di questo sì tratta, senza finti tatticismi, considerato che fin dal 2005 è stato avviato il “Dialogo intensificato” per l’adesione dell’Ucraina all’Alleanza Atlantica,
Perché la partita è molto più vasta di quella che si sta giocando in questi giorni tra i manifestanti di Piazza Indipendenza a Kiev e quelli pro referendum a Sebastopoli. Si tratta di una partita che coinvolge l’intero scacchiere europeo, iniziata nel 1991 con la fine dell’Unione Sovietica e la vittoria occidentale e americana della guerra fredda.
Per capire meglio la portata degli avvenimenti ucraini è utile fare mente locale sull’Europa del 1989 e confrontarla con quella di questi giorni.
Negli anni della “contrapposizione tra blocchi” l’Europa era divisa a metà da una linea che delimitava l’area di influenza sovietica da quella occidentale.
Nel giro di pochi anni, a partire dal 1989, la quasi totalità degli ex Paesi socialisti del Patto di Varsavia hanno aderito all’organizzazione militare dell’Alleanza Atlantica. Sfruttando la debolezza della Russia post comunista, la Nato è riuscita a portare i propri confini a ridosso della ex Urss. Con l’adesione nel 2004 dei tre paesi baltici si è perfino infranto il tabù di far aderire all’organizzazione militare occidentale anche dei territori che facevano parte della stessa Unione Sovietica.
Quella seguita dagli Stati Uniti è stata, fin dai primi anni ’90, una strategia molto decisa nei confronti di Mosca, volta a guadagnare velocemente terreno e a togliere alla Russia ogni zona d’influenza in Europa e non solo.
La domanda che si pongono gli analisti, anche e soprattutto americani, è fin dove è possibile spingere questa azione e quale sia il confine non negoziabile da parte russa. L’adesione dell’Ucraina al Patto Atlantico è la mossa conclusiva di questa strategia, perché vorrebbe dire portare la potenza militare occidentale e americana fin dentro il territorio russo, a ridosso delle sue città vitali. Sancendo, in questo modo, la definitiva vulnerabilità della Russia e il suo ridimensionamento come potenza mondiale.
La Russia é così debole da accettarlo? Già nei 2008, in Georgia, in un contesto per molti versi simili, la Russia aveva dato un segnale molto forte che qualcosa era cambiato rispetto agli anni precedenti. Difficile che subisca passivamente gli eventi in Ucraina. E difficile che gli Stati Uniti e l’occidente si spingano oltre davanti a una reazione russa.
Ma d’altro canto, siamo certi che sia questa la strategia migliore per L’Europa? in quale sede è stata concordata? L’Europa ha detto la sua, lo ha fatto l’Italia? Oppure ci siamo ritrovati ad assecondare strategie, spesso fallimentari, scaturite da improbabili think tank d’oltre oceano?
Non sarebbe stato più lungimirante favorire un assetto europeo che ten esse ani tu d elle esigenze di sicurezza di un Paese che conta più di 8000 testate nucleari e che, insieme agli Stati Uniti, è l’unico capace di causare un disastro a livello planetario?
Si sarebbe potuta percorrere la stessa strada seguita alla fine della seconda guerra mondiale con l’Austria, per La quale si è favorito uno status di paese neutrale e fuori dalle contrapposte alleanze militari.
La, neutralità, anziché l’adesione alla Nato, dei paesi ex socialisti avrebbe, forse, garantito una stabilità definitiva al continente europeo. Oggi la questione si ripropone, con ancora maggiore forza, per l’Ucraina. Ed è questo il momento che la diplomazia europea giochi il suo ruolo dì saggia mediazione tra Stati Uniti e Russia, magari mettendo sul piatto proprio l’ipotesi di uno status speciale di neutralità per Kiev.




















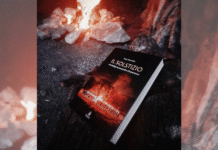

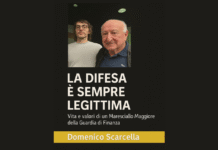
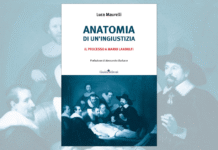






Condivido assolutamente, parola per parola, tutto questo articolo