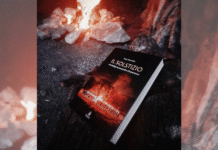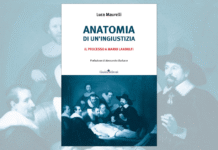L’incrocio politico del 21 settembre per il governo Conte presenta all’orizzonte un semaforo giallo pronto a sbarrargli la strada – tutt’altro che fatalmente – sul rosso.
Stavolta, però, questo non rappresenta il “soccorso rosso” del Pd: quello che gli ha permesso il ribaltone clamoroso con cui il M5s, il partito di cui è espressione, ha svenduto nel settembre scorso anni di fantomatica opposizione al “partito di Bibbiano” e al sistema che continua a rappresentare. No. Stavolta si tratta di uno stop destinato – se i sondaggi dovessero essere confermati – a mettere politicamente la parola fine a un’esperienza nata non per governare l’Italia ma proprio per fermare i sovranisti: evitando in tutti i modi – questo il corollario – di fare i conti con il popolo. È questo, per Conte, Di Maio e Zingaretti, l’unico modo per continuare ad esercitare il potere nell’esclusivo interesse di due minoranze. Rissose e disorganiche per giunta.
Eppure le elezioni Regionali, nonostante la tentazione di palazzo Chigi di rinviarle sine die, alla fine stanno per arrivare e rappresentano, con tutta evidenza, il redde rationem non solo e non più per ciò che concerne le amministrazioni territoriali: sono, al di là delle formule di rito dei politici coinvolti, il voto su un anno di spericolata guida giallorossa. Stagione a cui si è aggiunto il carico di una gestione pandemica dove l’oscuro “ex” avvocato del popolo ha trovato l’occasione d’oro per legare mani e piedi il destino dell’Italia nelle mani dell’asse franco-tedesco.
Certo, quello che andrà in scena domenica e lunedì prossimo è un appuntamento elettorale che riguarda solo sette regioni, Ma è un test altamente indicativo, dato che coinvolge circa 18 milioni di italiani: quasi un terzo della popolazione. Non solo. La tornata di Regionali è l’ultima di una serie, iniziata con la vittoria di Nello Musumeci in Sicilia, che ha consegnato al centrodestra tutte le regioni (10 a 2) e che ha legittimato ancora di più il primo posto della coalizione alle Politiche e l’affermazione del destra-centro alle Europee.
È del tutto evidente, insomma, che dal “tasso” di affermazione di quest’ultimo voto – a maggior ragione nelle regioni targate Pd, Marche, Puglia e Toscana, dato che quelle amministrate da Toti e Zaia sono date per riconfermate senza alcun problema – non si potrà non prendere plasticamente atto di una legislatura formale che non rispecchia più, nemmeno lontanamente, la volontà popolare.
Che ciò per Conte & co. non rappresenti un problema lo hanno spiegato, mettendo le mani avanti con l’ormai proverbiale faccia tosta, tutti i giallo-fucsia interpellati sull’argomento. Discorso diverso, stavolta, dovrebbe essere invece dalle parti del Quirinale. Giorgia Meloni lo ha spiegato con rispetto («Non voglio dare alcuna lezione al capo dello Stato») ma puntando i riflettori sulle prerogative di Sergio Mattarella: «Il presidente della Repubblica non è un notaio delle maggioranze parlamentari. È il garante della Costituzione, dei principi che vi sono iscritti. A partire dal primo: che la sovranità appartiene al popolo».
Per la leader di Fratelli d’Italia lo è a partire da un principio cardine della fisiologia democratica – l’aderenza fra ciò che il popolo ha stabilito e ciò che vuole il Palazzo – ma anche rispetto a un governo giallo-fucsia che ha più volte disatteso le raccomandazioni, le indicazioni, lo “stile” stesso che il Colle ha chiesto nell’affrontare la crisi pandemica e prima ancora la difficile transizione verso la Terza Repubblica.
E se è vero, come hanno fatto filtrare i quirinalisti, che il presidente Mattarella non ha alcuna intenzione di assecondare un terzo “ogm” – dopo i gialloverdi e i giallofucsia – e che qualunque sia il responso del referendum costituzionale delegittimerà o la legislatura (nel caso prevalesse Sì) o il governo (in caso di No), si comprende bene perché davanti a un exploit del destra-centro nelle sette regioni chiamate al voto non ci sarebbe più alcun appiglio formale con cui Conte possa ancora incollarsi a palazzo Chigi.