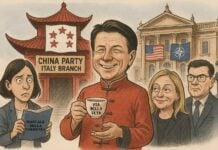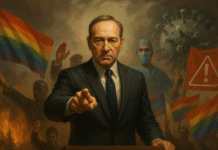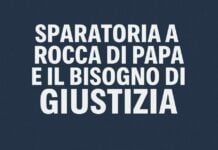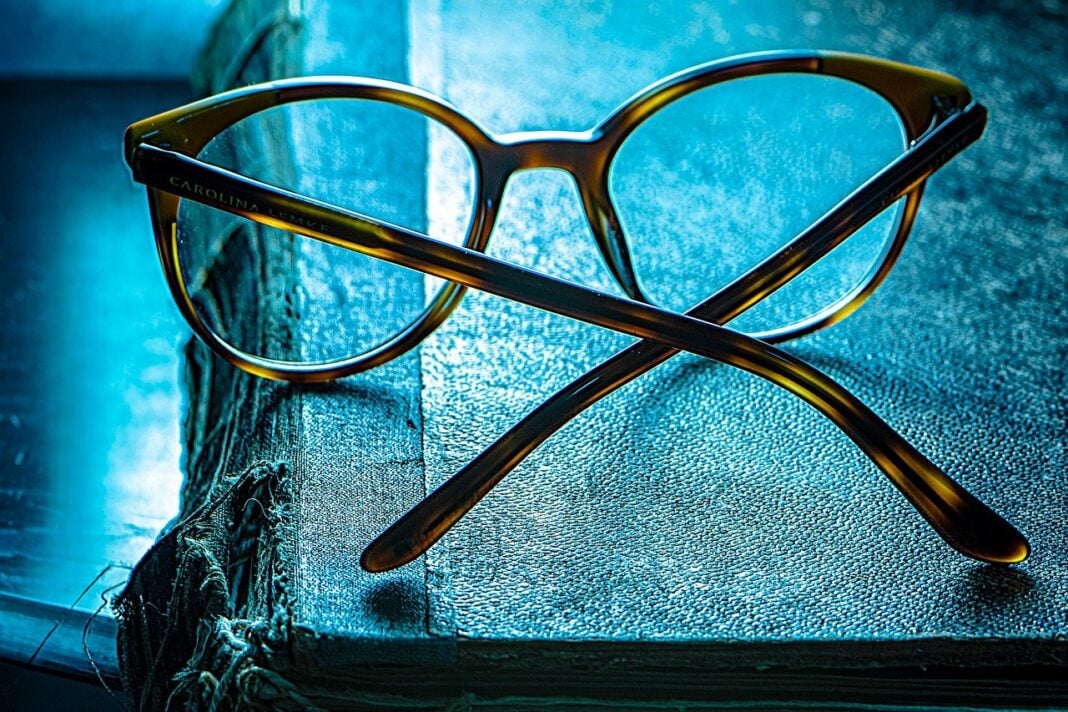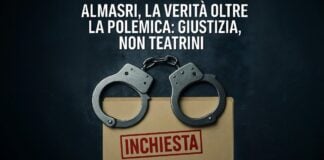Novembre 2020, in un’Italia forzatamente sonnachiosa e chiusa in se stessa al termine di un anno in cui i giorni sembrano tutti uguali, due avvenimenti minori e di per sé insignificanti (la copertina di una rivista gloriosa che oggi per sopravvivere viene venduta allegata a un quotidiano, e il nome d’una piazza in un comune dell’hinterland sconfinato d’una grande città) diventano oggetto di dibattito nell’ambito della cultura di destra. Un dibattito a mezza bocca, anzi un pucciniano coro a bocca chiusa.
Un ambito che altrimenti sarebbe vivacissimo (per non cadere nell’autoreferenzialità basterebbe ricordare il post su Facebook dello scrittore e assessore circoscrizionale romano Raimo in cui citava ad esempio per la sinistra la varietà di iniziative editoriali… a destra!), ma la cui esistenza non solo non è nota al grande pubblico (forse per colpa dell’egemonia culturale di sinistra) ma che è ignorata anche nella destra stessa, quella che governa non poche regioni e non pochi comuni, e che pure dagli anni ’90 in poi ha governato il paese per diverse legislature.
Perché chi fa l’intellettuale e non si colloca a sinistra vive in una sorta di perenne Comma 22. Se nel romanzo del 1961 di Joseph Heller si ironizzava sull’alienazione e sull’esperienza di pilota di guerra nel secondo conflitto mondiale affermando: «Chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di guerra, ma chi chiede di essere esentato dalle missioni di volo non è pazzo» per chi fa cultura e non si inserisce nell’alveo del mainstream egemone il comma 22 diventa: «se è uno di destra non può essere un intellettuale, se è un intellettuale allora non potrà essere di destra».
È il paradosso dell’intellettuale di destra che non “può esistere in quanto tale”. Un paradosso continuamente ribadito e ricordato a sinistra, ma che amaramente, dobbiamo ammettere che spesso alberga anche a destra quando questa non impiega i suoi di intellettuali. Non l’area culturale e quella militante, attiva, ma quella governativa, che quando si trova a condurre dal più complesso ministero, al più piccolo assessorato di un comune sperduto, improvvisamente è convinta di non poter contare su propri intellettuali e quindi chiama quelli di sinistra.
È quello che è accaduto in questo scampolo di novembre 2020 è un lampante esempio di questo comma 22 culturale. Un settimanale, uno dei pochi rimasti, dedica la copertina a un fumettista, e fin qui nulla di strano. Quello che colpisce (e si scoprirà imbarazzare persino il fumettista in questione) è il titolo «L’ultimo intellettuale». D’altronde il fumettista in questione vende bene, sa essere non banale, è andato in zone di guerra a fare reportage a fumetti (onore a lui), e sa essere anche divertente con i suoi cartoni su Youtube. La definizione di intellettuale per dei fumettisti di quel calibro ci sta. Certo è un qualcosa costruito nel tempo È cresciuto in dieci anni un ecosistema fatto di contenuti, di immagine di promozione, per arrivare a numeri da bestseller, film tratto dai fumetti incluso.