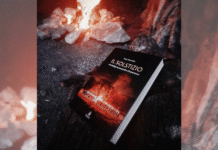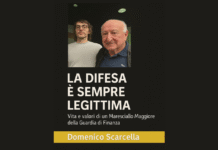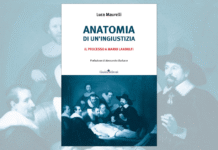Nel Documento di Finanza Pubblica 2025, il governo italiano delinea una traiettoria di contenimento del deficit (dal 3,4% al 3,3% del PIL) e una spending review selettiva. Tuttavia, secondo le opposizioni, lascia sullo sfondo – senza adeguata trasparenza – la questione cruciale delle voci di bilancio legate alla difesa. Eppure, proprio da qui si accende una delle più significative tensioni tra la necessità di rigore contabile e il bisogno strategico di sicurezza.
Le opposizioni lamentano l’assenza di dettagli su entrate, saldi strutturali e allocazione delle risorse future. Eppure, proprio in questa zona d’ombra si colloca una scelta politica che merita di essere indagata e – con lucidità – spiegata: il progressivo riallineamento dell’Italia agli standard NATO, con l’obiettivo di destinare fino al 2% del PIL alla difesa.
I numeri del riarmo
Attualmente, l’Italia destina circa l’1,57% del PIL alla difesa. Per raggiungere l’obiettivo del 2%, sarebbe necessario un incremento di circa 10 miliardi di euro, portando la spesa totale a oltre 35 miliardi di euro nel 2025 . Questo rappresenterebbe un aumento significativo rispetto agli anni precedenti e segnerebbe un record storico per la spesa militare italiana.
Impatto sul PIL e sulla stabilità economica
Secondo le previsioni del DFP 2025, il PIL reale è atteso in crescita dello 0,6% nel 2025, con un incremento allo 0,8% nel 2026 e 2027 . Tuttavia, l’aumento della spesa per la difesa potrebbe avere effetti sia positivi che negativi sull’economia:
Effetti positivi: Gli investimenti nel settore della difesa possono stimolare la domanda interna, creare posti di lavoro e incentivare l’innovazione tecnologica, contribuendo così alla crescita economica.
Effetti negativi: Un aumento significativo della spesa pubblica potrebbe mettere sotto pressione i conti pubblici, soprattutto in un contesto di alto debito pubblico, con il rapporto debito/PIL previsto al 136,6% nel 2025 .
La logica della deterrenza gioca, però, un ruolo importante visto il disimpegno crescente degli Stati Uniti nella protezione dell’Europa – testimoniato dai documenti ufficiali del Congressional Budget Office e dai recenti indirizzi della politica estera statunitense – che impone ai Paesi europei di farsi carico direttamente della propria sicurezza.
Sembra di capire che questa non è retorica militarista ma più una non svelata strategia di stabilizzazione in base al contesto geopolitico creatosi. Come negli anni della Guerra Fredda, la spesa per la difesa assume valore non nella sua funzione bellica, ma in quella dissuasiva. È un investimento di “credibilità sistemica”: serve a rendere il Paese non attaccabile, e quindi economicamente affidabile. Ogni euro speso in deterrenza è un argine contro i cambiamenti non gestiti, e quindi un moltiplicatore implicito di fiducia per gli investitori stranieri.
Difendere i confini territoriali e le aree extraterritoriali di interesse strategico (flussi energetici, infrastrutture digitali, rotte commerciali) significa difendere il valore del lavoro, del reddito e del potere d’acquisto degli italiani. Un sistema economico esposto a minacce esterne – convenzionali o ibride – perde appeal, attrattività e accesso ai capitali.
Il “campo di battaglia”, delimitato dal Governo e dalle opposizioni sugli stanziamenti per la difesa, dunque, non è un capitolo accessorio ma strutturale della politica economica nazionale. Lo sforzo chiesto all’Italia dal contesto internazionale, se inserito in una cornice chiara e accompagnato da un’adeguata narrazione istituzionale, può essere trasformato da costo non compreso in leva di stabilità e sviluppo e necessario.